In collaborazione con 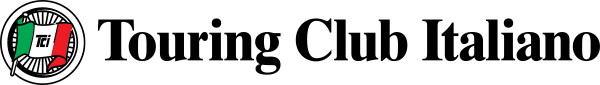
Itinerario lineare, interamente lungo la rete delle strade provinciali. Nella prima parte attraversa il territorio delle colline del Querciolese (il toponimo riprende la presenza di estesi boschi di querce che in antico ne ammantavano le pendici, e di cui rimane il ricordo nelle località principali), comprese tra le valli dei torrenti Tresinaro e Crostolo, fino a Carpineti.
Una lunga appendice penetra da Villa Minozzo nel cuore dell’Appennino fino alle pendici del monte Cusna (m 2.120), la più alta cima del Reggiano e la seconda dell’Appennino settentrionale, culminante in vaste praterie erbose, notevolmente panoramiche.
Di interesse prevalentemente paesaggistico, ha nel castello di Carpineti la meta più rilevante dal punto di vista storico e monumentale. In quest’area costituiscono una forma di spettacolo popolare molto vitale i «maggi», rappresentazioni in versi ispirate ad argomenti tratti dalla storia sacra, da leggende, dai cicli cavallereschi, che vengono recitati e cantati in estate, di regola nelle radure dei boschi e nei prati da attori dilettanti o improvvisati – i maggerini – accompagnati da orchestrine composte da violino, fisarmonica, chitarra, con costumi talvolta ricavati da materiali poveri.
Questa tradizione, che ben si inserisce nella cultura del ‘minore’ di cui tutto il territorio è espressione, si estende dalla valle del Secchiello all’alta val d’Asta e Secchia, e annovera tra i centri più noti e attivi quelli di Asta, Costabona, Gazzano e Toano.
-
Lunghezza57 km
-
Albinea
Albinea (RE)
A m 166, ab. 8.773, moderno abitato dominato, dall’alto di un colle, dalla seicentesca villa Tarabini-Viganò. Più avanti, in incantevole posizione elevata appare la settecentesca chiesa della Natività di Maria di Albinea. Al culmine del poggio, il castello di Albinea con il suo parco, di proprietà privata.
-
Regnano
Viano (RE)
A m 439, nell’area del Querciolese, introdotto dalla chiesa di S. Prospero (secolo XIX, su disegno di Pietro Marchelli). Di particolare a Regnano sono le salse, caratteristici vulcanelli di fango trascinato in superficie da idrocarburi gassosi, visibili dalla strada all'altezza del bivio per Viano, non lontano da un piccolo caseificio; con quelle di Nirano, nel Modenese, le salse di Regnano costituiscono l’esempio più cospicuo di tale fenomeno in Italia.
-
Castello di Querciola
Viano (RE)
A m 391, borgo oggi semispopolato, tenuto nel 980 dal vescovo di Reggio, ove si osservano la chiesa di S. Maria del XIII secolo e l’originale palazzo dominicale (restaurato nel 2008), inglobato nella canonica, che conserva un fregio ad affresco con figure fantastiche e stemmi, attribuito a Lelio Orsi (1535-40 circa).
-
Cavazzone
Viano (RE)
A m 445, corte agricola con agriturismo della tenuta Franchetti, preceduta dalla villa padronale in stile pseudo liberty, con singolare belvedere in ferro battuto adibito a osservatorio panoramico.
-
San Giovanni Querciola
Viano (RE)
A 512, distribuisce il suo sparso abitato sul morbido pendio coltivato rivolto verso la valle del Tresinaro. Nei dintorni, numerosi borghi con case-torri come Villa m 612, corte rurale con massiccia casa-torre quattrocentesca, Giandeto m 616 (seicentesca chiesa di S. Paolo), e Croveglia m 608, articolato in un complesso a corte dominato da due case-torri (secolo XV) arroccate sulla base rocciosa.
-
Pantano
Carpineti (RE)
A m 646, antico dominio dei Canossa, con chiesa di S. Martino (secolo XVIII) contenente un capitello romanico, e tipologie edilizie dei secoli XV-XVII.
-
Carpineti
Carpineti (RE)
A m 562, ab. 3.966, centro di villeggiatura e stazione di soggiorno estivo, ai piedi della bella dorsale che va dal Monte Valestra m 933 (a est) al Monte Fòsola m 987 (a ovest). Il nucleo antico si concentra intorno alla piazzetta su cui prospettano il municipio e il seicentesco palazzo Amorotti; al centro, colonna con croce del 1685. Numerose sono, lungo la strada principale, le villette borghesi costruite a partire dal primo Novecento. L’emergenza storica e monumentale più significativa della cittadina è il castello di Carpineti.
-
Castello
Carpineti (RE)
Il castello di Carpineti, detto anche di S. Andrea, a m 805, posto sullo spartiacque tra le valli del Tresinaro e della Secchia, è testimone di un passato insigne: proprietà canossiana, ospitò in gran numero pontefici e illustri prelati, per passare, alla morte di Matilde, all’Impero e successivamente ai Fogliani, agli Estensi e, come ultimi proprietari, ai Valdrighi, che lo conservarono sino alla fine dell’Ottocento, pur essendo dalla prima metà del secolo XVII in parziale rovina. Si presenta come un castello-recinto a perimetro irregolare prossimo al trapezio, al cui interno emerge vistosamente la torre del mastio, isolata. Accanto al complesso, che è stato recentemente oggetto di estese opere di consolidamento, rimane la chiesa di S. Andrea.
-
S. Andrea
Carpineti (RE)
Accanto al castello di Carpineti rimane la chiesa di S. Andrea, consacrata nel 1117, restaurata nel 1902 e nei primi anni ’90; incendiata dai Tedeschi nel 1944, è stata recentemente restaurata; tracce della primitiva costruzione romanica sono comunque riscontrabili, specialmente nel portaletto scolpito.
-
S. Vitale
Carpineti (RE)
Nel Medioevo una delle due pievi principali della montagna reggiana; vi conduce in un'ora, dalla base del castello di Carpineti, un sentiero rivolto a levante. Forse di origine bizantina, è ricordata nel 980 e in seguito compresa nei possedimenti di Bonifacio di Canossa; rifatta dalla contessa Matilde, si trova oggi allo stato di rudere benché consolidato, e conserva il portale e due capitelli romanici dai rilievi figurati; accanto, il settecentesco edificio della canonica. Nella pieve è stato allestito e inaugurato nel 2015 un Museo lapideo che espone elementi decorativi come capitelli, calchi di fregi, vasi antichi e la mensa d’altare.
-
Vesallo
Carpineti (RE)
A m 500, in fondo alla valle della Secchia, nucleo rurale formato da due complessi con casa-torre e corte rurale (secolo XVII-XVIII).
-
Gatta
Castelnovo ne' Monti (RE)
A m 383, dove, all’inizio dell’abitato, attorno a un ampio spazio a corte, si contrappongono due palazzi Gatti: uno più antico (secolo XV-XVI), di chiara matrice fortilizia, e il seicentesco palazzo ‘nuovo’, imponente residenza signorile con interno affrescato nel Settecento.
-
Poiano
Villa Minozzo (RE)
A m 567. Degno di segnalazione il fenomeno consistente in una serie di sorgenti salate (raggiungibili a valle dell’abitato), poste al termine di un condotto sotterraneo; si tratta di sorgenti salso-solfate alcalino-terrose, con portate comprese fra i 300 e i 600 litri al secondo, determinate dalla infiltrazione nel sottosuolo delle acque del torrente Lùcola, che nel percorso dilavano gessi e salgemma.
-
Villa Minozzo
Villa Minozzo (RE)
A m 680, ab. 3.612, centro agricolo, commerciale e di villeggiatura, situato in un vasto pianoro sul versante nord-est del Monte Prampa m 1.699. Il nome riprende, associandole, le denominazioni di due distinte località, Villa e Minozzo m 774, quest’ultima oggi ridotta a frazione (km 4 a ovest), ma anticamente sede di pievania (nell’attuale chiesa, un Noli me tangere del Tiarini) e di una rocca dipendente dal vescovo di Reggio fin dal 1070, della quale sopravvivono alcuni resti su una rupe ofiolitica a margine della strada di attraversamento. Nelle vestigia recuperate del fortilizio è ubicato il Museo del Maggio.
-
Museo del Maggio
Villa Minozzo (RE)
Nelle vestigia recuperate del fortilizio di Villa Minozzo è ubicato il Museo del Maggio, dove si conserva il materiale scenico e di documentazione di questa forma di spettacolo popolare – il Maggio – che ha le sue tipiche espressioni tradizionali nell’Appennino reggiano e modenese.
-
Asta
Villa Minozzo (RE)
Già possedimento dell’abbazia di Frassinoro, si trova nella boscosa Val d'Asta, a m 928, dove la visione della catena del Monte Cusna si fa più ampia, evidenziando qualche circo glaciale.
-
Abetina Reale
Villa Minozzo (RE)
Vasto complesso forestale (828 ettari) oggi parte del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e Sito di Interesse Comunitario (SIC), dove sopravvivono foreste di conifere come popolazioni autoctone relitte delle epoche a clima più freddo. La zona è altresì molto adatta alle escursioni, la cui meta più considerevole è il Monte Cusna.
-
Civago
Villa Minozzo (RE)
A m 1.011, pittoresco centro situato in una bella conca circondata da folti boschi, in cui a partire dagli anni ’50 si è sviluppato un intenso movimento turistico favorito dai pregi naturalistici e dai vicini impianti sciistici del villaggio Appenninia m 1.100.
-
Quara
Toano (RE)
A m 722, anticamente Acquaria, nota per le sue acque termali ancora in uso nel XIV secolo, ma scomparse in seguito a sconvolgimenti franosi; nella Parrocchiale, un tabernacolo ligneo di Antonio Ceccati; a fianco, l’antico palazzo Sassi, in gran parte alterato.
-
Toano
Toano (RE)
A m 842, ab. 4.296, centro di villeggiatura in panoramica posizione, molto danneggiato nel corso della guerra partigiana (si ricorda che, sull’opposto versante vallivo, ebbe vita la repubblica di Montefiorino). Sull’altura che domina l’abitato (seguire la strada per gli impianti sportivi) sorge la pieve di S. Maria di Castello, ricordata nel 980 in un diploma di Ottone II, rifatta in epoca matildica, incendiata dai Tedeschi e di nuovo ricomposta; notevole l’interno a tre navate absidate, ripartite da colonne con capitelli scolpiti con scene dell’Antico Testamento (secolo XII). Il vicino campanile è quanto rimane delle torri del castello di Toano. A m 310, si trova la frazione di Cerredolo, località commerciale e industriale nella valle del torrente Dolo.
-
Massa
Toano (RE)
A m 796, la cui chiesa di S. Michele Arcangelo, romanica ma riedificata nel secolo XVII, reca nel fianco destro una scultura (Cacciata dal Paradiso terrestre) dell’XI secolo. Dalla chiesa si può salire direttamente sul poggio dove rimangono i resti dell’antica torre del castello; nel nucleo rurale ai suoi piedi, rustico palazzo cinquecentesco della famiglia Gandini, con pregevole portale in pietra.