In collaborazione con 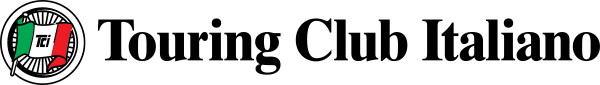
Nella vasta area compresa tra le scomparse porte S. Raimondo (piazzale Genova) e S. Lazzaro (piazzale Roma) ancora nel XVII secolo esistevano grandi estensioni inedificate; tra il Seicento e il Settecento i nuovi palazzi della numerosa aristocrazia piacentina vennero concentrandosi in questa zona, che appariva la più alta e la più salubre della città.
Spazi e attrezzature fecero da adeguato contorno al nuovo quartiere patrizio: lo stradone Farnese allestito per le parate e per il passeggio delle carrozze, i bastioni trasformati in ‘pubblico passeggio’ e infine il Teatro municipale.
-
Lunghezzan.d.
-
Piacenza
Piacenza (PC)
Nodo ferroviario e autostradale di primaria importanza sulla riva destra del Po, Piacenza m 61, ab. 104.260 è la ‘porta dell’Emilia’ per chi proviene dal Piemonte e dalla Lombardia; lambita dalle grandi correnti di traffico, ha conservato la sua forte, e un po’ appartata, fisionomia di centro padano. Nonostante la discontinuità delle vicende politiche ed economiche, la città offre una sequenza ininterrotta di brillanti fasi artistiche: dagli episodi monumentali del Medioevo alle espressioni del Rinascimento, fino agli esempi di edilizia civile del XVII e XVIII secolo che oggi configurano il carattere prevalente del centro storico.
-
S. Teresa
Piacenza (PC)
Chiesa seicentesca. All’interno, le cappelle di destra sono decorate con quadrature di Francesco Natali e figure di Bartolomeo Rusca (1a cappella) e Robert De Longe (2a cappella), quelle di sinistra dallo stesso Natali con Sebastiano Galeotti; le pale sono rispettivamente del De Longe (Estasi di S. Teresa), di Gaetano Callani (Sacro cuore di Gesù), di Francesco Cairo (La Madonna appare a S. Antonio), e di Giuseppe Nuvolone (La morte di S. Giuseppe); in sagrestia, S. Alessandro che abbatte l’eresia, di Giacomo Ceruti (1745); la volta del presbiterio, Gloria di S. Teresa, è di Giovanni Angelo Borroni, con quadrature di G.B. Natali.
-
XNL Piacenza Contemporanea
Piacenza (PC)
Spazio dedicato alle forme della cultura contemporanea, con sede nell’edificio ex Enel. Il palazzo fu edificato nel 1907 e ristrutturato nel 1919 da Guido Tirelli.
-
Galleria d'Arte moderna «Ricci Oddi»
Piacenza (PC)
Allestita in un edificio appositamente progettato da Giulio Ulisse Arata (1925-31) con illuminazione zenitale. L’importante museo, formato da oltre 900 opere di arte contemporanea, specie italiana, del periodo 1830-1930, nacque per volere del nobiluomo piacentino Giuseppe Ricci Oddi, industriale del settore meccanico e proprietario terriero, che il 27 dicembre 1924 donò alla città la sua ricchissima collezione e mise a disposizione i fondi necessari per la costruzione della sede, in un lotto acquistato dal Comune. Nell’area sorgeva un tempo il monastero benedettino femminile di S. Siro, soppresso nel 1820. Demolita la chiesa per far posto alla nuova scuola elementare «Giordani», rimase in piedi solo un’ala del monastero con una parte di chiostro, che fu restaurata e adibita a uffici, depositi e abitazioni dei custodi, e alla sede dell’associazione Amici dell’arte. Questa poté aprire al pubblico gli ampi spazi già nel 1927, con mostre e attività promozionali, secondo il volere di Ricci Oddi. La galleria fu inaugurata nel 1931, con allestimento curato anche dal donatore, ma più volte modificato nei decenni successivi. Per la pianta Arata non solo rielaborò studi leonardeschi e impianti modulari policentrici come il Musée des Beaux-Arts di Tournai, di Victor Horta, ma guardò a spazi ottagonali, come la sala della Domus Aurea neroniana, i nuclei centrali di chiese fiorentine come S. Maria del Fiore e la Rotonda degli Angeli. La facciata, esemplata sulla porta Pertusa di Roma, è ispirata a soluzioni locali nel contrasto materico tra basamento e portale in arenaria e specchiature in laterizio, e ospita i rilievi di P. Antonio Maraini. All’ingresso, nella sala studio della Biblioteca «Stefano Fugazza», è esposta dal 2020 La Pisana di Arturo Martini. Superata la biglietteria, si accede al Salone d’Onore, ottagonale, scavato da nicchioni sui lati diagonali e coperto da cupola con oculo centrale. Da qui si diparte un lungo corridoio, vero asse di simmetria dell’edificio, alle pareti del quale sono collocate opere di artisti piacentini di secondo Ottocento e prima metà del secolo successivo, tra i quali Bernardino Pollinari, Francesco Ghittoni, Pacifico e Nazzareno Sidoli, Bruno Cassinari e Luciano Ricchetti. Su questo corridoio affacciano 3 sale a destra e 3 a sinistra. A destra quella degli Emiliani (sala 1), con opere di Giuseppe Graziosi, Amedeo Bocchi e di Mario Cavaglieri, che a Piacenza soggiornò tra 1921 e 1924; quella dei Toscani attivi nel XIX secolo (sala 2), in prevalenza Macchiaioli, con dipinti di piccolo formato di Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Cristiano Banti, Raffaello Sernesi e Silvestro Lega, e un ritratto realizzato da Giovanni Boldini, che negli anni ’60 soggiornò a Firenze; quella dei Liguri e dei Piemontesi (sala 3) con grandi tele di Giacomo Grosso, Marco Calderini e Giuseppe Pellizza da Volpedo. Le sale che si affacciano sul corridoio, a sinistra, sono dedicate: al Simbolismo (sala 19), con capolavori di Giulio Aristide Sartorio e Adolfo De Carolis; a un piccolo ma rilevante nucleo di dipinti di artisti stranieri (sala 20), tra i quali lo svedese Carl Larsson e lo spagnolo José Villegas y Cordero, accanto a pittori che ebbero fortuna all’estero, come Federico Zandomeneghi e Giuseppe De Nittis; alla scuola veneta (sala 21), con tele di Pietro Fragiacomo, Lino Selvatico ed Ettore Tito. Proseguendo lungo il corridoio si incontra una saletta biconca (sala 4), consacrata agli orientalisti, quali Alberto Pasini e Cesare Biseo, e un andito, con mosaico di Vittorio Zecchin donato alla Galleria nel 2000, che immette nella sala ottagonale detta La Rotonda (sala 7). Negli angoli spiccano bronzi di piccolo formato di Pietro Canonica, Vincenzo Gemito, Eugenio Maccagnani, Libero Andreotti, Quirino Ruggeri e Alessandro Moretti. Le quattro salette sugli assi diagonali della Rotonda ospitano paesaggi del francese Auguste Ravier e di artisti fortemente influenzati da Fontanesi (saletta 6); tele di Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni e Luigi Conconi, e un ritratto scultoreo di Paolo Troubetzkoy riconducibili alla Scapigliatura lombarda (saletta 10); opere di Piero Marussig, Filippo De Pisis e Bruno Saetti in parte legate a Novecento italiano (saletta 14); tre dipinti e un acquerello del napoletano Vincenzo Irolli (saletta 18). Aperte sulle quattro salette radiali, altrettante sale più ampie e due ambienti maggiori tra esse incastonati conservano: numerose opere di Antonio Fontanesi (sala 5), tra gli artisti prediletti di Ricci Oddi per i suoi paesaggi tardo-romantici; opere di pittori lombardi dal Romanticismo in poi (sala 8), tra i quali Francesco Hayez, Mosé Bianchi, Francesco Filippini, Gaetano Previati e Cesare Tallone; ancora dipinti di artisti lombardi di primo Novecento (sala 9), quali Angelo Morbelli ed Emilio Rizzi; in prevalenza dedicata ad Antonio Mancini è la sala 15, con opere che coprono la sua lunga carriera, alle quali si accompagnano quattro vedute di Giuseppe Casciaro; diverse opere dei militanti di Novecento italiano o comunque di personalità distanti dalle avanguardie sono nella sala 16, come Felice Carena, Arturo Tosi, Aldo Carpi, Carlo Carrà e Felice Casorati, o ancora colti in un momento precedente l’adesione alle stesse, come Umberto Boccioni, con quattro ritratti scultorei di Francesco Messina e un marmo di Adolfo Wildt. Nell’ultimo ambiente della raggiera (sala 17) significative testimonianze della Pittura del Meridione, con paesaggi, ritratti e scene di genere di Francesco Paolo Michetti, Domenico Morelli, Giuseppe e Filippo Palizzi, Federico Rossano ed Edoardo Dalbono. Nella parte terminale della galleria, affacciata su un piccolo giardino: Saletta biconca, con sculture di Medardo Rosso e Domenico Trentacoste; sala dedicata a una collezione privata, in comodato alla Galleria, con opere di ambito toscano di piccolo formato; sala consacrata dal 1934 a Stefano Bruzzi, il più noto pittore piacentino dell’Ottocento. Trafugato nel 1997 e ritrovato nel 2019, il ritratto di Signora di Gustav Klimt è esposto nuovamente in Galleria dal 2020.
-
S. Agostino
Piacenza (PC)
Eretta nel 1570-87 da Bernardo Panizzari detto il Caramosino, forse su progetto di Cristoforo Lombardo (la facciata neopalladiana fu disegnata da Camillo Morigia nel 1786-92). La chiesa fu magazzino militare fino al 1959, poi fatta oggetto di numerosi restauri: chiusa al culto da circa due secoli, solo di recente è tornata al primitivo splendore, ospitando Volumnia, galleria d’arte e design privata. L’interno, di proporzioni grandiose, è a cinque navate ripartite da poderose coppie di colonne granitiche e pilastri rettangolari; originale la copertura a cupolette con decorazioni a stucco; all’incrocio con il transetto, grande cupola ottagonale. Alle spalle della chiesa si stende per oltre 3,5 ettari il vastissimo complesso dell’ex monastero dei Canonici regolari lateranensi, disposto attorno a tre eleganti chiostri; costruito nel 1554-67 forse entro il perimetro dell’antico castello di S. Antonino, su progetto dello stesso incerto architetto della chiesa, appartiene dal 1798 al demanio militare.
-
Stradone Farnese
Piacenza (PC)
Ampio stradone tracciato nel 1543 per iniziativa del legato pontificio Egidio Gambara, come prestigioso asse residenziale in grado di valorizzare i terreni del settore sud. All’estremità occidentale dello stradone nel 1608 venne terminata la chiesa di S. Chiara; all’interno, un bel crocifisso ligneo trecentesco. In angolo con la via S. Franca si trova l’incompiuto palazzo Pallavicino (N. 21), del XVI secolo; accanto, il settecentesco palazzo Salvatico (N. 23). All’incrocio con la via Pietro Giordani, sopravvive l’importante fabbrica della chiesa di S. Agostino, eretta nel 1570-87 da Bernardo Panizzari detto il Caramosino. Proseguendo lungo lo stradone Farnese si incontra, al N. 32 il neoclassico palazzo Landi di Chiavenna, al 49 il settecentesco palazzo Dal Verme, e infine, quasi all’estremità est, la chiesa dei Cappuccini.
-
Chiesa dei Cappuccini
Piacenza (PC)
Chiesa dei Cappuccini (S. Bernardino o santuario di S. Rita), di struttura tardo-gotica (XV secolo), con interno a una navata coperta da volte a crociera, e abside con volta a padiglione. Nella 3a cappella destra, S. Francesco che riceve le stimmate, tela del Guercino.
-
Palazzo Scotti di Sàrmato
Piacenza (PC)
Monumentale palazzo, opera di Giuseppe Marioni del 1780, forse su disegno di Cosimo Morelli; l’edificio rivolge verso il giardino e lo stradone Farnese il fronte posteriore loggiato, scenograficamente aperto a U, e verso strada due fronti con adorne finestre; preziosi di stucchi, tempere e affreschi lo scalone e il salone d’onore.
-
Palazzo Anguissola di Cimafava-Rocca
Piacenza (PC)
Imponente palazzo di origine medievale (appartenne a una delle più potenti famiglie di parte ghibellina) ma rifatto nel secolo XVIII; il salone è decorato di stucchi e dipinti di buona qualità (storie di Alessandro) di un ignoto artista della prima metà del secolo.
-
Teatro Municipale-Fondazione Teatri di Piacenza
Piacenza (PC)
Teatro dalla facciata neoclassica, realizzato da Lotario Tomba (1803-4). Degli originari quattro ordini di palchi che cingevano la sala ellittica, due furono successivamente trasformati in gallerie; le decorazioni in stucco dorato sono opera dello scenografo Alessandro Sanquirico.
-
Santa Maria in Cortina
Piacenza (PC)
Di fronte al Teatro Municipale prospetta la chiesetta di S. Maria in Cortina, fondata nel IV secolo sul sepolcro di S. Antonino, rifatta nel XVI. Nell’interno a una navata, affreschi frammentari collocabili tra la fine dell’XI secolo e il XVI. A 4 metri e mezzo di profondità, una camera ipogea del IV secolo è ritenuta la tomba di S. Antonino, martire decapitato nel 303.
-
Sala dei Teatini-Fondazione Teatri di Piacenza
Piacenza (PC)
Ha sede nell'ex chiesa di S. Vincenzo, ricostruita nel Seicento ad opera dei padri Teatini in forme barocche; l’interno, adorno di quadrature e figure dipinte da Andrea Galluzzi, Giovanni Evangelista Draghi, Robert De Longe, Felice Biella e Federico Ferrari, dopo un periodo di abbandono e degrado, è stato restaurato ed è utilizzato come auditorium musicale.
-
Via Scalabrini
Piacenza (PC)
Già stradone di S. Salvatore. Delle grandi fabbriche religiose e civili che vi si allineano, conferendole notevole carattere, nel primo tratto meritano attenzione: al N. 7, il settecentesco palazzo Giacometti; al N. 6, il palazzo Appiani d’Aragona, del XVI secolo ma sopraelevato e rimaneggiato nel Settecento (sullo sfondo di un cortile colonnato è il giardino d’impronta romantica). Segue la ex chiesa di S. Vincenzo, ricostruita nel Seicento ad opera dei padri Teatini in forme barocche ed ora utilizzata come auditorium musicale chiamato Sala dei Teatini. Sul lato opposto della via Scalabrini, i palazzi Pallastrelli (N. 2), Passerini (N. 10) e Gragnani (N. 12), l’ultimo opera di Giacomo Agostini. Poco più avanti, di nuovo a destra, la chiesa di S. Stefano, di impianto romanico ma rifatta dai Somaschi alla fine del Cinquecento, e il settecentesco palazzo Dodi-Giandemaria (N. 33), con un bel cortile aperto verso il giardino. Seguono altri complessi religiosi: sul lato sud, preceduto dalla chiesa di S. Paolo (di origine altomedievale, trasformata nel XVII secolo da Giacomo Agostini), si trova il Seminario vescovile, sistemato da Gaetano Curotti alla fine del XVIII secolo (all’interno, notevole la cappella di S. Opilio in stile neogotico); sul lato nord, l’ex convento di S. Maria della Neve (N. 76), ristrutturato nel 2004, è sede universitaria. Lo fronteggia la chiesa di S. Anna, del XII secolo, ricostruita nel 1334 e ampiamente restaurata da Camillo Guidotti (1924-25); all’interno, in controfacciata sinistra, Gesù risorto, affresco del Soiaro (1543 circa). Da via Scalabrini è poi accessibile Il complesso denominato Urban Center che, nell’area dell’ex macello comunale, comprende sedi universitarie, uffici comunali e il Museo di Storia naturale.
-
Urban Center
Piacenza (PC)
Nell’area e negli edifici dell’ex macello comunale, importante complesso di archeologia industriale (1892-94), compreso tra via Scalabrini e stradone Farnese, sono state ricavate strutture di servizio tra cui sedi universitarie, uffici comunali e il Museo di Storia naturale. Il complesso denominato Urban Center è accessibile da via Scalabrini N.107 e da stradone Farnese N. 126.
-
Museo civico di Storia naturale
Piacenza (PC)
Il Museo civico di Storia naturale nel 2007 è stato trasferito nella nuova sede della fabbrica del ghiaccio nell’ex macello comunale in via Scalabrini. Suddiviso in tre settori geografici – pianura, collina e montagna – per ogni settore sono evidenziati gli aspetti geologici, paleontologici e floro-faunistici; possiede tre collezioni – mineralogica, botanica e zoologica – diorami, con piante essiccate o tessute e animali impagliati, che ricostruiscono ambienti naturali della zona.
-
Giardini Margherita
Piacenza (PC)
Ampliamento del settecentesco giardino dei Costa, del quale resta il tempietto neoclassico sulla sommità della montagnola; il giardino venne realizzato a partire dagli stessi anni (1863- 65) in cui venivano allestiti il contiguo piazzale Marconi e la Stazione ferroviaria (l’attuale edificio risale al 1935 circa), creando nell’insieme un continuum prospettico, concluso dal grattacielo dei Mille (22 piani) progetto dell’architetto Marco Cattozzi dei tardi anni ’60 del Novecento.
-
S. Savino
Piacenza (PC)
Preceduta da una facciata con portico a colonne binate del 1581 (frammenti di affreschi) poi rimaneggiata da G.B. Galluzzi (1720). Fondata nel IV secolo e ricostruita dai Benedettini, venne consacrata dal vescovo Aldo nel 1107. Modificata tra XVII e XVIII secolo, fu radicalmente restaurata da Ettore Martini, e riportata alle forme romaniche nel 1903. Ripartito in tre navate da pilastri in granito con archi a tutto sesto (notevoli i capitelli), l’interno si presenta oggi con i caratteri del romanico puro. Il presbiterio ha un ampio mosaico pavimentale della prima metà del secolo XII; l’altare, in marmo nero su progetto di Alessandro Reni (1730) con ornati in bronzo, opera di Giuseppe Filiberti (1764), racchiude una ricca urna contenente le reliquie di S. Savino, vescovo di Piacenza, morto nel 420. Sopra di esso, *Crocifisso ligneo romanico (sec. XII). Alla parete destra, tabernacolo in marmo, di Pietro Calabrino, seguace dell’Amadeo (firmato e datato 1510). Nella parete destra, Madonna, frammento di affresco di scuola lombarda degli inizi del ’400. La cupola della cappella della Medaglia miracolosa reca affreschi (scene bibliche) attribuiti a Giovanni Evangelista Draghi, rinvenuti nei restauri del 2006). Un’ampia scala davanti al presbiterio scende nella *cripta, che si apre con tre arcate sostenute da colonne e sormontate da una balaustra moderna. È retta da agili colonnette dal fusto squadrato, con ricchi, svariati capitelli a figure vegetali e antropomorfe (secolo XII). Il pavimento è coperto da un *mosaico coi segni zodiacali entro medaglioni, opera fra le più complesse e raffinate dell’arte musiva della prima metà del secolo XII. L’altare è del ’400, scolpito a rilievo da uno scultore locale vicino all’Amadeo (1481). Sulla volta sotto al campanile sono alcuni affreschi dei primi decenni del secolo XII, opera di pittori padani (santi e animali entro racemi).
-
Palazzo Anguissola di Grazzano
Piacenza (PC)
Palazzo con facciata in cotto chiaro, di Cosimo Morelli (1774-77), che presenta una sequenza (atrio colonnato, vasta corte porticata, scalone monumentale, salone delle feste con decorazioni di Alessandro Della Nave, Antonio Villa e Antonio Bresciani) di notevole effetto.
-
Museo ambientale-Palazzo Costa
Piacenza (PC)
Il Museo ambientale del Settecento ha sede nell’imponente palazzo Costa, progettato da Ferdinando Bibiena e realizzato alla fine del XVII secolo; nel fronte, dal corpo centrale bugnato, sormontato dallo stemma di famiglia e da un timpano, notevoli decorazioni rococò. Dall’ampia corte prospettante sul giardino, uno scalone esterno conduce al piano nobile, dove in alcune sale finemente decorate è ospitata la Fondazione Horak che gestisce il Museo ambientale del Settecento. Nella lunga galleria Bibiena sono esposte 76 incisioni di architetture bibienesche. La galleria porta alla Sala d’Onore, con affreschi prospettici del Bibiena di notevole effetto, e scene mitologiche (Nozze di Bacco e Arianna) di Giovanni Evangelista Draghi. Nelle altre sale sono esposti dipinti, sculture e arredi antichi; il nucleo più importante è raccolto nella sala di Salvator Rosa, dove il dipinto raffigurante Mario davanti alle rovine di Cartagine è considerato uno dei suoi capolavori.
-
Palazzo Landi
Piacenza (PC)
Palazzo dalla grande mole laterizia, di origine medievale, rifatto alla fine del XV secolo da maestri lombardi già attivi con Leonardo (Giovanni Battagio, Agostino de’ Fondutis), sotto la direzione del committente Agostino Landi, una delle massime figure dell’Umanesimo piacentino; espropriato da Ottavio Farnese, l’edificio ospita dal secolo XVII gli uffici giudiziari. Notevole il *portale rinascimentale coronato da statue, opera di Giovan Pietro da Rho, sopra il quale corre un fregio che continua nell’armonioso cortile porticato. Un altro cortile, con portico su colonne, loggiato e decorazioni in cotto, è accessibile da via Giordano Bruno 7.
-
Ex chiesa di S. Lorenzo
Piacenza (PC)
Un tempo di pertinenza della famiglia Landi è l’ex chiesa di S. Lorenzo, di impianto trecentesco, con bella facciata in laterizi; già destinata a usi impropri, è stata oggetto di interventi di restauro sia nell’elegante struttura architettonica, sia negli affreschi, parzialmente rimasti in situ (altri sono al Museo civico). L’utilizzo previsto per la ex chiesa è come auditorium, sala teatrale o galleria d’arte.