In collaborazione con 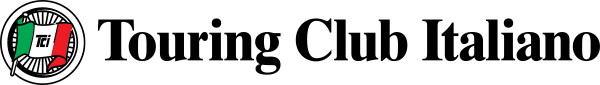
Le origini
Solo recentemente si è raggiunta la certezza sui fatti all’origine della nascita della città.
La scoperta, che ha risolto molti dubbi e tolto valore a interpretazioni distorte, è avvenuta studiando la pianta della città mediante l’osservazione zenitale. E la traccia più antica si è rivelata in un gruppo di strade che, nell’insieme, determinano una conformazione a cuneo rivolto verso nord, anomalo anche per l’andamento a labirinto dei tracciati interni. Questa struttura, interpretata come nucleo difensivo o castrum, si adagia sulla Ripagrande, asse viario generatore dello sviluppo e della crescita della città.
Tale asse riproduce ancora il profilo della sponda sinistra del Po, quando per Ferrara transitava il suo ramo maggiore. Il cuneo di strade identificato come struttura di difesa era dunque a nord del Po, con una precisa collocazione rispetto a eventuali invasioni; venne edificato dagli Esarchi verso la fine del VII secolo, dopo che era stata distrutta la sede vescovile di Voghenza e il seggio episcopale si trasferiva nel polésine di S. Giorgio, una sorta di isola protetta dalle acque della grande palude.
L’avvio dei meccanismi degli scambi e dei mercati mise in moto la creazione di un nucleo edificato che la storia definisce con il nome di Ferrara a partire dal 760 circa. Intorno al 1000 il Papa investì il marchese Tedaldo di Canossa del controllo sul polo urbano in formazione.
Questi fece erigere un castello sul Po, a occidente del castrum bizantino, e cominciò a collegare i due poli di difesa con una cinta di mura ad andamento est-ovest, il cui tracciato è leggibile nella sequenza di alcune strade del centro storico (vie Saraceno, Mazzini, Garibaldi).
Il progressivo rafforzamento e sviluppo di Ferrara avveniva mentre era al tramonto la politica bizantina in Italia e, di conseguenza, in declino l’economia di Ravenna sul mare e sui fiumi dell’interno.
La collocazione geografica fece immediatamente di Ferrara una città dal commercio fiorente. Ma nel 1152 la rotta di Ficarolo, poco a monte, deviò il ramo principale del Po nel Po di Venezia, mutando radicalmente l’idrografia del territorio e l’economia di Ferrara.
L’impoverimento idrico del braccio fluviale (detto Po di Volano) rimasto a sud della città condusse gradualmente all’interrimento del porto e alla fine della navigazione. Dopo la morte di Matilde di Canossa (1115) nasce il libero Comune i cui statuti, del 1173, sono incisi in lastre di pietra ancora esistenti alla base del fianco meridionale della nuova cattedrale di S. Giorgio, edificata (1135) oltre le mura di Tedaldo.
Frattanto emerge la dinastia degli Estensi, che con Azzo VI regge Ferrara come podestà per due volte, nel 1196 e nel 1208. La rapida fortuna commerciale prelude a lotte che dagli inizi del XIII al termine del XIV secolo si intrecciano con i dissidi interni per l’egemonia tra le più potenti casate. Nel secondo quarto del secolo XIV gli Este finiscono per prevalere e insediarsi stabilmente alla guida della città.
Momenti decisivi della storia urbana, dopo quelli che avevano visto la costruzione del Castello da parte di Bartolino da Novara (1385), su mandato di Niccolò II, saranno le date degli ampliamenti: 1386 (addizione di Niccolò II); 1451 (addizione di Borso); 1492 (addizione di Ercole I).
Le addizioni sono quartieri interi, già formati, che vengono collegati con sapienti allacci alla trama antica ed entrano immediatamente a far parte della città come parte integrante di essa; non sono mai esterni o periferici perché, per contenerli, vengono ampliate anche le mura.
La prima addizione nasce in concomitanza con l’edificazione del Castello e determina la costruzione della nuova cinta di mura lungo il tracciato del canale della Zudeca (il futuro corso della Giovecca). Sarà il luogo delle residenze dei dignitari di corte nei pressi della sede del governo della città; il suo asse correrà sulla via di S. Francesco (le attuali vie Voltapaletto e Savonarola).
La seconda, quella di Borso, la cui regia fu affidata prima a Pietrobono Brasavola e poi a Pietro Benvenuto degli Ordini architetto di corte, si determina per la necessità di occupare e di organizzare le aree lasciate libere dal trasferimento dell’alveo del Po: la via della Ghiara (oggi vie della Ghiara e XX Settembre) sarà la dorsale del nuovo quartiere.
Infine la terza, in pieno Rinascimento, sarà quella che darà forma compiuta alla città e ne farà, nei programmi di Ercole I e di Biagio Rossetti suo architetto, una capitale magnifica. Il suo centro è l’incrocio dei Diamanti (l’attuale quadrivio di corso Ercole I d’Este con corso Biagio Rossetti e corso Porta Mare).
La prima comunità ebraica
Si fa presente e attiva la prima comunità ebraica che sotto il governo estense avrà molte fortune.
Alberto V (1388-93), che succede a Niccolò II (1361-88), fonda l’Università con uno speciale privilegio papale. Sarà questo l’avvio di una grande stagione culturale, che troverà in Leonello (1441-50) la figura eminente e che continuerà con Borso (1450-71) ed Ercole I (1471-1505). Con Borso – prima duca di Modena e Reggio per nomina imperiale, poi duca di Ferrara per investitura di Paolo II – assumerà grande rilievo nella storia della città il monastero di S. Antonio in Polesine, mentre sarà compiuta dai pittori dell’Officina – Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, oltre a Gherardo di Andrea Fiorini e ad altri pittori anonimi – l’impresa del salone dei Mesi della ‘delizia’ di Schifanoia.
A Ferrara, con Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Roger van der Weyden, operano per conto della casa ducale e della nobiltà ferrarese miniatori, arazzieri, orefici, incisori; l’Università riceve nuovo impulso e richiama lettori e studenti, mentre la corte diventa uno dei centri più importanti nella storia musicale italiana.
Ma la vita civile ed economica ha anche risvolti non positivi. A fronte della bolla bonifaciana ottenuta da Alberto V a favore degli agricoltori dell’agro ferrarese e del dominio estense, sta la lotta grande e continua contro l’instabilità del territorio, che costringeva a un dispendio di energie senza misura. Il XVI secolo. Con Ercole I la casata estense raggiunge il culmine del suo prestigio: il re di Napoli gli concede la figlia Eleonora in sposa.
È la consacrazione della corte di Ferrara fra i grandi della penisola.
L’impresa grandiosa della terza addizione, detta Erculea, e la costruzione della nuova cinta bastionata di 9 km, ancora per buona parte esistente, con quattro porte, undici baluardi, due torrioni, sono la traduzione in opera di questo prestigio e della cultura che lo sosteneva.
Ancora un secolo, e nel 1598 l’ultimo duca di Ferrara, con la «devoluzione», cede la città alla sovranità del papa.
Questo secolo, il XVI, fu particolarmente difficile e non solo sul piano politico. Il Po di Primaro, dopo la sua immissione nel Reno nel 1542, ruppe 40 volte; il Po Grande negli anni di Ercole I provocò alluvioni che invadevano i terreni a ovest di Ferrara, e questo avvenne anche sotto il ducato di Alfonso II (1559-97); nel 1528 la città fu afflitta dalla «peste grande» e nel 1593 una carestia fece almeno 10 000 ‘veri poveri’.
Nel 1561, nel 1570 e nel 1591 una serie di scosse telluriche danneggiò Ferrara e le sue campagne.
Ma, anche nella fase di maggiore debolezza economica e di precarietà politica (l’ostilità di papa Giulio II contro Alfonso I, le tentazioni riformate della fede di Renata di Francia moglie di Ercole II, le disavventure di Alfonso II in Ungheria e il suo feroce disaccordo col Papa Pio V) non mancò la presenza alla corte estense di insigni figure delle arti e delle lettere: Dosso Dossi, Giovanni Bellini, Tiziano, Ludovico Ariosto e di prosecutori dell’attività di Biagio Rossetti: Girolamo da Carpi, G.B. Aleotti, Alberto Schiatti, e del fondatore dell’arte strumentale moderna, Girolamo Frescobaldi.
I cardinali legati amministrarono Ferrara per tre secoli. Il giudizio che si dà di questo periodo è generalmente negativo. In effetti molte conquiste, sul piano dell’organizzazione e controllo del territorio, andarono perdute: l’affievolimento (almeno nei decenni iniziali) del controllo delle acque produsse miseria nelle campagne e un generale decadimento della vita civile.
L’avvenimento urbano, a un tempo grandioso e inutile, che segna il governo in città è la costruzione di una grande fortezza, nell’angolo di sud-ovest della cerchia murata. Per la sua edificazione furono demoliti il Castel Tedaldo, la famosa ‘delizia’ del Belvedere che era su un’isola nel Po.
Architetto (l’opera è insigne e citata nella storia dell’architettura militare) fu il romano Pompeo Targone, che la concepì a forma di stella circondata dalle acque e con funzioni di offesa avanzata.
La legazione di Ferrara
Ma al di là dei fatti di rilievo, e alla capacità o incapacità dei cardinali che reggevano ogni tre anni la legazione di Ferrara, un’attenta osservazione della vita urbana in questi secoli rivela una città culturalmente molto vivace, ricca di fermenti e attenta a quanto avveniva nel resto della penisola.
Va ricordata la riforma dell’Università pubblica nel 1742, la nascita delle Accademie, la presenza di artisti di qualità (Carlo Bonone, lo Scarsellino e altri), il magistero di Andrea Bolzoni, la cui pianta piano-prospettica di Ferrara, terminata, dopo molti passaggi, nel 1747, resta il documento più vivo e più consultato di questi secoli.
Da questa grande opera nasce la città nuova, «definizione di un sogno che, nel momento in cui viene pensato, diviene reale ed inizia a realizzarsi» (Ranieri Varese).
Anni di singolare tranquillità e benessere furono quelli che dal 1700 al 1737 videro legato e vescovo il cardinale Tommaso Ruffo, il quale compì i grandi lavori di trasformazione della Cattedrale, l’edificazione del nuovo Vescovado, la riparazione e il rinnovamento di chiese e di palazzi. Suoi architetti furono Francesco Mazzarelli, Giulio Panizza, Vincenzo Santini e il romano Tommaso Mattei. A lui si deve l’erezione di Ferrara a sede arcivescovile, nel 1735, essendo papa Clemente XII.
Tra Settecento e Ottocento
Gli anni che vanno dal 18 giugno 1796, data di arrivo dei Francesi a Bologna e Ferrara, al 21 giugno 1859, quando insieme Austriaci e papalini lasciano la fortezza nelle mani del popolo insorto, sono il tempo del grande e sofferto travaglio.
Ferrara vive questo scorcio di secolo in uno stato di continua tensione, con pochi interessi per i problemi urbani anche se si compiono opere egregie come il Teatro comunale e il Cimitero monumentale.
Dopo la distruzione della fortezza (del cui disegno stellare sono visibili solo due punte ai limiti del moderno quartiere Giardino), la città attende, come si dice, a opere di pace e di ricostruzione della sua economia. Il sistema delle ferrovie accelererà la ripresa dei commerci e si apriranno nuovi rapporti e nuovi scambi; si programma il primo piano regolatore (ne è autore Ciro Contini, ingegnere progettista attento alle novità che in Italia vanno muovendo le ricerche formali e architettoniche); si ridà impulso, anche con la massiccia presenza di capitale straniero, alle operazioni di bonifica delle terre paludose; si rinnova la città nel quadro generale della modernizzazione.
Poi saranno di nuovo la prima guerra mondiale, il fascismo (che avvia un’industrializzazione senza adeguati supporti), la seconda guerra mondiale a rimettere in crisi la sempre labile condizione urbana ed economica di Ferrara.
Dopo il 1945, due piani regolatori – il primo dei quali firmato da Giovanni Michelucci – e la posizione di punta assunta dal governo municipale nella tutela e nella valorizzazione del centro storico, vogliono fare di Ferrara un polo di riferimento europeo della difesa dell’ambiente urbano e architettonico.
Le Mura
Questo monumento di architettura militare è stato trasformato in un parco pubblico alberato, una passeggiata nel verde di 9 chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta, sia sull’alto del rilevato sia dal fossato.
Il tratto settentrionale della poderosa cinta muraria fu costruito sotto Ercole I da Biagio Rossetti (1493-1505) contro gli eventuali attacchi dei Veneziani. I bassi torrioni circolari erano adatti a fronteggiare cannoni con tiro a parabola. Qua e là nella cinta appaiono fuciliere, cammini di ronda e cannoniere. A metà del tratto settentrionale si apre la porta degli Angeli (1525) mentre nel vertice di nord-est sporge la punta della Montagnola, riparata da un’altura di terra da cui sparare a grande distanza.
Da qui comincia il tratto dovuto ad Alfonso I (1512-18), basato su alti bastioni a freccia triangolare. Il più imponente è il baluardo della Montagna, in cui fu ricavata una delizia con grotte acquatiche e animali esotici. Il tratto meridionale risalente a Borso (1451) fu rafforzato dall’ultimo duca, Alfonso II, con bastioni ravvicinati ad asso di picche (1575-85), evoluzione del sistema precedente, comunque idoneo contro bocche da fuoco a tiro rettilineo. A metà si apre la porta di S. Pietro, dove si pesavano le merci e si esigeva il dazio. Da porta Paola (1612) le fortificazioni risalgono al periodo posteriore; il bastione di S. Paolo e di S. Maria sono i superstiti della pentagonale fortezza pontificia (1608-18), spianata con l’Unità d’Italia.