In collaborazione con 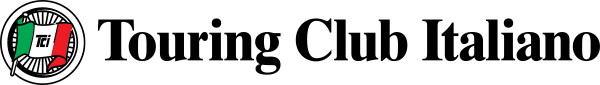
Il punto di partenza storicamente più significativo per la visita della città è la Biblioteca Malatestiana, il monumento cesenate di maggior prestigio. Da cui si esplorano piazza del Popolo e i suoi dintorni, salendo alla Rocca Malatestiana e percorrendo l'asse centrale della città, corrispondente alla via Emilia, da corso Mazzini a corso Garibaldi.
L'itinerario prevede anche due passeggiate fuori dal perimetro della cinta muraria, all’abbazia della Madonna del Monte e alla chiesa dell’Osservanza.
-
Lunghezzan.d.
-
Cesena
Cesena (FC)
Situata nel cuore della Romagna, in posizione equidistante da Forlì e da Rimini lungo il tracciato della Via Emilia, sulla destra del fiume Savio e ai piedi del colle Garampo, Cesena m 44, ab. 97.465, ha origini remote ma incerte. Il volto dell’odierno nucleo storico è quello di una città molto compatta, chiusa in una cerchia muraria tre-quattrocentesca, dalla caratteristica forma di scorpione. Modificatasi in età malatestiana (secolo XV) allorché venne in parte ridisegnato l’impianto medievale, la città ha vissuto successivamente nuove fasi di operosità edilizia fino al rinnovamento ottocentesco.
-
Biblioteca Malatestiana
Cesena (FC)
È il monumento cesenate di maggior prestigio, Patrimonio dell’Unesco, voluto da Malatesta Novello a metà del Quattrocento all’interno del grande complesso conventuale dei Minori di S. Francesco, ma che oggi si trova ‘incamiciato’ in un vasto edificio neoclassico costruito all’inizio dell’Ottocento, dopo l’abbattimento della chiesa e di parte del convento; al centro della piazza antistante, statua di Maurizio Bufalini, medico cesenate, di Cesare Zocchi (1883). Il progetto «Grande Malatestiana» prevede l’ampliamento e il riordino del patrimonio, secondo un nuovo percorso museale che valorizzerà la storia della biblioteca, divenendo museo della città malatestiana e spazio espositivo. Nell’edificio dell’ex Liceo Classico troveranno sede un nuovo deposito librario e rinnovati servizi. Al pianterreno è la sezione moderna della Biblioteca comunale, con un’ampia sala di lettura e di consultazione. Possiede oltre 350.000 volumi e opuscoli, 327 incunaboli, cronache e carteggi di grande valore, e l’importante biblioteca medica di Maurizio Bufalini. Al primo piano, nell’atrio della Biblioteca Malatestiana è esposta la mazza pontificale in argento, del papa Pio VI; in questo ambiente ogni due mesi vengono esposti a rotazione due codici. Attraverso un portale (nel timpano, l’elegante impresa dei Malatesta, un elefantino indiano, ripetuta al disopra entro una ghirlanda), chiuso da battenti in noce magistralmente intagliati nel 1454 da Cristoforo da San Giovanni in Persiceto, si accede all’interno dell’aula, costruita nel 1447-52 da Matteo Nuti sul modello della biblioteca conventuale di S. Marco a Firenze. Ha pianta di basilica a tre navate di undici campate, scandita da due file di colonne con capitelli variamente lavorati e recanti stemmi malatestiani. Nelle navate laterali sono disposti i plutei originali contenenti 343 codici miniati e 48 opere a stampa. Pur custodita dai frati, la libreria fu per volere del signore della città aperta al pubblico. Per la perfetta conservazione della struttura, degli arredi e la preziosità dei codici, la Malatestiana è oggi considerata un esemplare unico al mondo. I due fondi principali sono formati dai codici di Novello (126 furono scritti per suo ordine) e dai codici del suo medico, il riminese Giovanni di Marco (metà 1474). Tra i più prestigiosi per la bellezza delle scritture e la ricchezza delle miniature si segnalano una Bibbia del secolo XIII, con miniature di scuola bolognese; il De Consolatione Philosophiae di Boezio, miniato da artisti di ambito lombardo prossimo a Michelino di Besozzo; il De Civitate Dei di S. Agostino, scritto da Jacopo della Pergola nel 1450 e miniato da artista vicino a Taddeo Crivelli, al cui ambito sono pure ascrivibili le figure dei Sermones in Evangelium Johannis, scritti da Giovanni da Epinal; si segnalano ancora le Vite di Plutarco, con preziosi ritratti di scuola ferrarese, e il Liber Mascalciae di Rusio, con miniature di scuola emiliana della prima metà del secolo XV. Nel grande salone (già dormitorio) antistante alla Malatestiana è conservata la Biblioteca Pïana, la biblioteca privata del papa cesenate Pio VII Chiaramonti. Comprende oltre 5.000 volumi dal XII al XIX secolo, con un centinaio di manoscritti, 26 incunaboli ed edizioni rare. In visione entro bacheche sono sette Graduali del Duomo copiati da Enrico di Amsterdam nel 1486 e splendidamente miniati da artisti di scuola lombarda e ferrarese. Notevoli anche i sette Corali del convento dell’Osservanza, scritti e miniati negli anni 1455-60. Tornati a pianterreno, attraverso la sezione moderna della Biblioteca comunale, si accede al grande refettorio, tra le poche parti rimaste del convento trecentesco, abbellito nel secolo XV: capitelli delle colonne con insegne malatestiane, resti di affreschi monocromi in terra verde, nelle due grandi lunette che richiamano lo stile di Bartolomeo di Tommaso. È qui collocata la ricca Biblioteca Comandini (15.000 volumi, 1.700 fotografie dall’800 a oggi, monete, medaglie e manoscritti), pervenuta per lascito al Comune e aperta al pubblico nel 1970. Nel corridoio che fiancheggia il refettorio, alcuni resti lapidei e un altorilievo d’età malatestiana con S. Giorgio, ora attribuito a Nanni di Bartolo.
-
Museo archeologico
Cesena (FC)
Con sede al pianterreno, di fronte all’ex refettorio del complesso conventuale francescano, il museo espone i reperti provenienti dagli scavi archeologici in area urbana e nel territorio, databili dalla preistoria (Neolitico) al Rinascimento, con importanti nuclei dedicati alla romanità e al Medioevo. Il percorso espositivo presenta materiali riferibili all’ambito privato, all’artigianato artistico, alle attività produttive e al commercio, la raccolta numismatica e le iscrizioni funerarie. Tra i pezzi più importanti, due preziosi piatti argentei (missoria) del IV secolo, finemente niellati, rinvenuti in un ripostiglio ai piedi del colle Garampo, in cui erano stati celati forse al tempo di Teodorico. Il nucleo di ceramiche di età malatestiana è solo una piccola parte della notevole raccolta conservata nei depositi.
-
Palazzo del Ridotto
Cesena (FC)
Nel lato della piazza opposto alla biblioteca, ricostruito nel 1782 sul luogo dell’antica residenza municipale (secolo XV), della quale si conservano tracce in arcate e pilastri. La facciata prospiciente sul corso Mazzini è di Cosimo Morelli; la grande statua in bronzo del papa Pio VI (il cesenate Giovanni Angelo Braschi) collocata nella loggetta superiore, di Francesco Callegari.
-
S. Maria del Suffragio
Cesena (FC)
Costruita nel 1685-89 su disegno di Pier Mattia Angeloni. Pregevole l’interno barocco, ricco di marmi e di statue in stucco di Francesco Callegari; all’altare maggiore, splendida pala (*Natività della Vergine) di Corrado Giaquinto (1752), entro cornice disegnata dallo stesso pittore.
-
Piazza del Popolo
Cesena (FC)
Grande piazza, la cui sistemazione originale risale ad Andrea Malatesta; al centro, una monumentale fontana. Di fronte, il Palazzo comunale.
-
Fontana di piazza del Popolo
Cesena (FC)
Monumentale fontana al centro della piazza, dal complesso disegno anticlassico dovuto a Francesco Masini (1583).
-
Palazzo Albornoz
Cesena (FC)
Palazzo comunale eretto dal cardinale Albornoz nel 1359 e successivamente modificato nel 1474, nel 1557 e, in forma definitiva, nel 1725. Presenta un prospetto singolarmente ampio, dotato di alto portico e doppio ordine di finestre. All’interno, sale affrescate e con soffitti a cassettoni del Settecento; all’ultimo piano sono stati rinvenuti pregevoli fregi con grottesche di una fase più antica (inizi secolo XVI). In continuità con il palazzo si allunga un’austera cortina muraria, sovrastata da una loggia denominata loggetta veneziana, edificata nel Quattrocento per mettere in comunicazione il palazzo albornoziano con le fortificazioni della soprastante rocca, alla quale appartiene il possente torrione poligonale (o torre del Nuti) all’estremità destra. Nei locali della loggetta e della torre è stato allestito il Museo dell’Ecologia.
-
Museo dell’Ecologia
Cesena (FC)
Allestito nei locali della loggetta e della torre del Palazzo comunale, espone, ambientati in diorami, le principali specie di fauna provenienti in gran parte dalla valle del Savio; il giardino ospita una notevole varietà di specie botaniche.
-
S. Domenico
Cesena (FC)
Chiesa dalla possente mole, completamente riedificata nel 1706-22 da Francesco Zondini. L’interno, a una sola grande navata, è notevole soprattutto per la quantità dei dipinti che vi sono custoditi, per lo più provenienti dagli edifici di culto della città soppressi in età napoleonica. Tra i molti si ricordano: nella 1a cappella destra, Ss. Donnino, Carlo Borromeo, Apollonia e un devoto di Cristoforo Savolini (1671); tra la 1a e la 2a cappella, Annunciazione pure del Savolini (1640 circa); nella 2a cappella, alla parete sinistra, Madonna del Carmine e santi di Giovan Francesco Modigliani; al 3° altare, pregevole ancona marmorea (1755) con Crocifisso ligneo del secolo XVI. Nella zona absidale, Adorazione dei pastori di Ferraù Fenzoni; al centro, Epifania, grande tela di Francesco Menzocchi e Livio Modigliani (1571); sopra la porta a sinistra del presbiterio, Crocifissione di Francesco Menzocchi. Nella 3a cappella sinistra, tavola raffigurante S. Pietro martire di Scipione Sacco (1545), e nella cuspide dell’ancona, S. Apollinare di Cristoforo Serra; alle pareti, *Madonna del Rosario con S. Domenico, del Cavalier d’Arpino, e Assunzione della Vergine con apostoli, di scuola bolognese della seconda metà del secolo XVII; al 2° altare, Santo in preghiera di Luigi Crespi, e a sinistra, ovale con *S. Martino che dona il mantello al povero, di Arcangelo Resani (secolo XVII).
-
Rocca Malatestiana
Cesena (FC)
Fatta costruire in cima al colle Garampo m 85, da Galeotto Malatesta, continuata poi da Novello e ultimata tra il 1466 ed il 1476 principalmente per opera di Matteo Nuti. Sgomberata dalle prigioni mandamentali, i restauri hanno riportato la rocca alle condizioni originali, con i due grandi torrioni quadrati al centro di un vasto prato, circondato da possenti mura perimetrali bastionate, in parte camminabili. Oggi la Rocca è luogo d’arte, di spettacoli e di eventi. Nella torre ‘femmina’ è allestito il Museo di Storia dell’Agricoltura.
-
Museo di Storia dell'Agricoltura
Cesena (FC)
Allestito nella Rocca Malatestiana, raccoglie attrezzi agricoli e ricostruzioni di ambienti tipici della vita contadina tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
-
Chiesa dell’Osservanza
Cesena (FC)
Riedificata nel 1791 da Leandro Marconi; della precedente costruzione, quattrocentesca, rimangono il campanile e il pronao. L’interno, a una sola navata, di gusto neoclassico, reca nella parte presbiteriale affreschi dello stesso Marconi; sull’altare maggiore, Crocifisso ligneo del secolo XV; in sagrestia, Annunciazione di Marcantonio Franceschini.
-
S. Agostino
Cesena (FC)
Iniziata nel 1747 da Giuseppe Antonio Landi su suggerimenti di Luigi Vanvitelli, e compiuta, ma senza il rivestimento della facciata, nel 1778. Nei fianchi sono in evidenza le paraste che superiormente s’incurvano in larghe ed eleganti volute. Interno a pianta basilicale a una navata, coperto da maestosa cupola con lanterna; sull’alto dell’abside, Annunciazione, ovale di Girolamo Genga (1517); presso il 3° altare sinistro, Gesù crocifisso, la Madonna e S. Giovanni evangelista, pregevole gruppo ligneo del secolo XIV; al 2°, Strage degli Innocenti di G.B. Razzani (1640); al 1°, Madonna e i Ss. Giacomo ed Erasmo di Capua, di Cristoforo Serra (1640).
-
Museo della Cattedrale
Cesena (FC)
Adiacente alla cattedrale, conserva preziosi arredi liturgici e alcuni interessanti dipinti fra i quali la preziosa *Madonna della Pera di Paolo Veneziano (firmata e datata 1347) e S. Gregorio Magno di Scipione Sacco (1532).
-
Cattedrale
Cesena (FC)
La costruzione della Cattedrale (S. Giovanni Battista) venne compiuta fra gli ultimi anni del Trecento e il 1405 (fianchi e abside), per munificenza di Andrea Malatesta e su disegno del tedesco Underwalden. Modificata sul finire del Quattrocento e nel corso del secolo XVII, mal restaurata in stile neo-gotico nel 1890, è stata riportata (1957-60) alle forme originarie. La facciata, che ha un grande portale gotico in marmo, evidenzia nella parte superiore caratteristiche rinascimentali veneziane, frutto di un rifacimento tardo-quattrocentesco; a destra del portale, entro nicchia, bella scultura della Madonna col Bambino di Vincenzo Gottardi. Il nuovo portale bronzeo è opera di Ilario Fioravanti (2001). Nella parte posteriore, il campanile (secolo XV); dal fianco destro sporge un corpo porticato, corrispondente alla cappella di S. Tobia, con preziose decorazioni marmoree rinascimentali. Il vasto interno basilicale è a tre navate, con archi e volte ogivali. All’inizio della navata destra, bel Crocifisso ligneo del secolo XVI e sepolcro di Antonio Malatesta, vescovo di Cesena, eseguito da Ottaviano di Antonio di Duccio nel 1467. A metà della navata destra, il superbo *altare di S. Giovanni di G.B. Bregno (1494-1509), concepito come una nicchia al cui interno si trovano le figure di Cristo, S. Giovanni Battista e S. Giovanni evangelista con i committenti e angeli in volo. Alle pareti laterali dell’abside, grandi pannelli affrescati da Giuseppe Milani. A metà navata si apre la barocca cappella della Madonna del Popolo, opera di Pietro Borboni (1746), rivestita di marmi preziosi con statue di Antonio Trentanove; sull’altare, di Virginio Vespignani, è esposta l’immagine ad affresco della Beata Vergine del Popolo, del secolo XVI; nella volta, Genealogia e trionfo della Vergine di Corrado Giaquinto (1752). Segue, alla parete sinistra, un grande trittico marmoreo raffigurante i Ss. Leonardo, Cristoforo ed Eustachio, scolpito da Lorenzo Bregno (1514).
-
Santuario dell’Addolorata
Cesena (FC)
Santuario già dei Serviti, dalla mole notevole, di origine trecentesca ma completamente ricostruito su disegno di Pietro Borboni (1756-65). Nell’interno a una sola navata: al 1° altare sinistro, Comunione di S. Carlo Borromeo agli appestati, tra le opere migliori della tarda attività di Carlo Saraceni; nella parete di fondo, sempre a sinistra, monumento funebre a Margherita Tiberti in marmo bianco, del secolo XVI; nella parete destra del presbiterio, Annunciazione di Livio e Giovan Francesco Modigliani.
-
Teatro «Alessandro Bonci»
Cesena (FC)
Costruito a partire dal 1843 da Vincenzo Ghinelli e inaugurato il 15 agosto 1846 con la rappresentazione della Maria di Rohan di Gaetano Donizetti.
-
Basilica della Madonna del Monte
Cesena (FC)
Sul «Monte», il colle sparso di ville a sud-est di Cesena, si trova l’abbazia della Madonna del Monte. Annessa a un vasto complesso benedettino, sorge sul posto già occupato da un antico oratorio eretto verso la metà del secolo X da S. Mauro, vescovo di Cesena. Il successivo edificio, del secolo XII, venne modificato e notevolmente ampliato in età malatestiana e nel corso del secolo XVI, fino ad assumere l’aspetto attuale conferitogli da Francesco Terribilia, al quale in particolare si deve la cupola (1568), poi abbassata nel 1772. *Interno grandioso a una navata, con ampie cappelle laterali, presbiterio sopraelevato sulla cripta e profonda abside attorno alla quale gira il peribolo. La navata è corsa da un fregio dipinto formato da quattordici pannelli con episodi della vita di Maria, eseguiti da Girolamo Longhi (1557-59). Sulla facciata interna, un grande affresco allegorico del Cinquecento. Nella 1a cappella destra, Annunciazione, tavola di Bartolomeo Coda (1541); nella 2a, S. Mauro abate, tela di Francesco Mancini su disegno di Carlo Cignani; nella 3a, *Presentazione al tempio di Francesco Francia, entro cornice del sec. xvi intagliata e dorata; nella lunetta, Deposizione di Girolamo Marchesi. Per uno scalone progettato dal Terribilia (1572) si sale al presbiterio, sormontato da cupola dipinta da Giuseppe Milani (1773-74), che vi rappresentò l’Assunzione; nei pennacchi, gli Evangelisti e, negli otto riquadri del tamburo, personaggi e fatti dell’Antico Testamento. Nel catino absidale, altro grande affresco con l’Assunzione della Vergine, opera di G.B. Razzani. Dietro l’altare maggiore, coro ligneo intagliato e intarsiato da Giuseppe Scalvini (1560-62), con raffigurazioni bibliche e allegoriche entro ardite prospettive. Nelle vetrine disposte alle pareti del peribolo è esposta una parte della ricchissima *raccolta di ex voto della basilica, dal secolo XV al XX. Si passa nella sagrestia, dove si conservano eleganti arredi lignei, alcuni tra i più preziosi ex voto del secolo XV, un frammento di trittico con S. Giovanni evangelista della metà del Trecento, e una Madonna col Bambino e santi di Gaspare Sacchi (1536). Tornati in chiesa, si scende nell’ampia cripta, costruita nel secolo XVI, ma modificata nel corso del XVIII; sulla parete d’ingresso, affresco raffigurante l’Ultima cena; l’altare è costituito da un sarcofago d’età romana (secolo I d.C.) in marmo greco, sormontato da una grande croce in pietra del secolo IX; nell’absidiola, pregevole Deposizione in terracotta, forse di artista nordico del secolo XV.
-
Archivio dell'Immagine
Cesena (FC)
Nel grande complesso già conventuale della Biblioteca Malatestiana è stato trasferito il Centro Cinema Città di Cesena, in precedenza dislocato nel convento di S. Biagio, dove è rimasto il cinema S. Biagio. Oltre a un’ulteriore propria sala cinematografica, il Centro custodisce l’Archivio dell’Immagine, che raccoglie diversi fondi e archivi di personaggi legati al mondo del cinema, della televisione e della fotografia, acquisiti nel corso degli anni grazie alle donazioni di registi, fotografi, sceneggiatori. Oggi l’Archivio dell’Immagine conta numerosi carteggi con soggetti e sceneggiature originali di autori cinematografici, fotografie di scena, recensioni su centinaia di film di produzione nazionale e straniera. Il patrimonio degli archivi fotografici del Centro Cinema attualmente comprende oltre 550.000 tra negativi e stampe di foto di scena e di set, ritratti di registi e attori, provini e sopralluoghi. Da questo patrimonio scaturiscono diverse mostre fotografiche.
-
Pinacoteca comunale
Cesena (FC)
Ha sede nell'antico complesso conventuale di S. Biagio e comprende oltre 300 dipinti dal Quattrocento all’età contemporanea. Nella sezione centrale, corrispondente al vasto corridoio claustrale, si segnalano in particolare: affreschi frammentari di scuola romagnola del secolo XV, una tavoletta con la Madonna della Pera di Bitino da Faenza, un trittico smembrato con i Ss. Sebastiano, Rocco e Cristoforo attribuito ad Antonio Aleotti, Cristo in cattedra e santi, grande tavola di Scipione Sacco, una Madonna in trono e santi, pure dell’Aleotti (1510), un lunettone su tela con la Deposizione di Gaspare Sacchi (1536), una serie di Madonne del Sassoferrato, un Transito di S. Guarino e una S. Francesca Romana rispettivamente di G.B. Razzani e Cristoforo Serra. Nella sezione del Settecento: Sacrificio di Ifigenia del Piazzetta, una serie di pregevoli bozzetti di Giuseppe Milani (1773), un grande Ritratto del papa Pio VI di autore anonimo, Il genio della Vita e il genio della Morte di maniera cignanesca. La sezione contemporanea è composta essenzialmente dalla raccolta Morellini.
-
Palazzo Ghini
Cesena (FC)
Palazzo seicentesco, uno dei più considerevoli della città per l’interessante prospetto posteriore a doppio loggiato e gli affreschi di Giacomo Bolognini nel salone di rappresentanza.
-
Palazzo Romagnoli
Cesena (FC)
Austero palazzo del secolo XVIII (oggi location per eventi); all’interno, sale affrescate da Giuseppe Milani.
-
S. Cristina
Cesena (FC)
Leggiadra chiesa neoclassica fatta costruire dal papa Pio VII, il cesenate Barnaba Chiaramonti, da Giuseppe Valadier (1814-25); la facciata, di particolare vivacità cromatica, presenta un portichetto inserito in due avancorpi con terrazza superiore. L’interno, concepito a somiglianza del Pantheon romano, consiste in un vano circolare scandito da otto coppie di semicolonne ioniche, con cupola emisferica.
-
Palazzo Chiaramonti
Cesena (FC)
Grandioso palazzo acquistato dal pontefice dalla famiglia Carli, che lo aveva fatto costruire nel 1710 circa e decorare da Giuseppe Milani nel 1770-80.