In collaborazione con 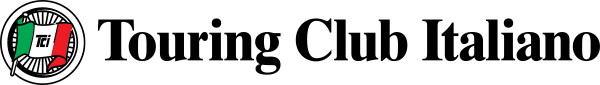
Il torrente Savena nasce in Toscana, dal fianco settentrionale del Sasso di Castro, a 5 km dal passo della Futa. Diretto a nord, è immissario ed emissario del lago di frana di Castel dell’Alpi, solca a ovest la base della dorsale di Monghidoro e Loiano e scende a Pianoro, segnando poi il confine, all’altezza della Via Emilia, tra i comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena.
In passato bagnava la pianura a nord-est di Bologna, ma nel 1776 è stato immesso nell’Idice poco oltre la Via Emilia, in prossimità dell’odierna tangenziale. Ha un bacino imbrifero di circa 170 km2 e una portata media annua di circa 5 m3/secondo.
La valle del Savena corre parallela a quella del torrente Idice, che ha origine alle falde del Monte Canda, nei pressi del passo della Raticosa. Diretto anch’esso a nord, incide a est la base della dorsale di Monghidoro e Loiano e, attraversata la stretta di Bisano, bagna Monterenzio e sbocca in pianura presso Pizzocalvo, dove vi affluisce, da sinistra, il torrente Zena.
In pianura, arginato, canalizzato (prima metà del XIX secolo) e pensile, riceve da destra il torrente Quaderna e, dopo 80 km di corso, confluisce nel fiume Reno a Bastia, presso Argenta. Con un bacino complessivo di 800 km2, grazie al consistente apporto solido accresciuto dalle torbide del Savena e del Quaderna, fu a lungo utilizzato per colmate nella bassa pianura bolognese.
L’itinerario circolare, da Bologna, utilizza all’andata la statale 65, della Futa, mentre il rientro avviene lungo un’agevole strada provinciale e un breve tratto della Via Emilia. La fascia a ridosso della pianura è quella di maggiore interesse geologico, caratterizzata dalla presenza di gessi, con grotte e doline carsiche; di notevole suggestione anche la zona immediatamente più a monte, dove le ‘argille scagliose’ danno luogo a frequenti fenomeni calanchivi.
Nel territorio montano ha prevalso in passato un’economia di sussistenza, nonostante l’area sia stata storicamente interessata, dall’età romana in avanti, da importanti percorsi viari. Le operazioni belliche tra l’autunno del 1944 e la primavera del 1945, connesse allo sfondamento della «linea gotica», hanno poi colpito molto duramente i centri disposti lungo la strada della Futa, cancellando gli edifici monumentali e una miriade di architetture rurali.
Tuttora, spostandosi da questa direttrice privilegiata a est, verso le valli dello Zena e dell’Idice, la realtà locale risente del processo di marginalizzazione conosciuto in età moderna, interrotto solo recentemente in aree limitate; queste circostanze d’altro canto hanno consentito la conservazione in molti tratti di un paesaggio ancora integro, sicuramente uno dei motivi di fascino di questo itinerario.
Particolare interesse riveste la visita all’area archeologica di Monte Bibele (e al museo di Monterenzio che conserva i reperti rinvenuti), dove è stato riportato alla luce un villaggio di fondazione etrusca, abitato anche da una componente celtica.
-
Lunghezza101,3 km
-
San Ruffillo
Bologna (BO)
Sobborgo di Bologna, prende nome dal primo vescovo di Forlimpopoli. Nel 1176 il Comune bolognese vi costruì una chiusa per deviare le acque del T. Savena e alimentare i mulini cittadini.
La chiesa di S. Ruffillo è stata più volte ricostruita, l’ultima nel 1948-56 in seguito alle devastazioni belliche. Il campanile è del 1715-23, la facciata del 1771, forse su progetto di Giuseppe Antonio Ambrosi.
Superato il ponte sul Savena, ci si trova subito a monte di quello della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze, più volte riattato a uso della via per la Toscana.
Il 20 giugno 1361 fu qui combattuta una delle più importanti battaglie della storia di Bologna, detta di S. Ruffillo, tra i cittadini alleati alle milizie di Romagna, Ancona e Genova, sotto il comando di Galeotto Manfredi, e le truppe di Bernabò Visconti, che risultarono sconfitte.
-
Rastignano
Pianoro (BO)
A m 97, lungo la valle del Sàvena, dove si susseguono numerosi stabilimenti industriali. Nella parrocchiale, sull’altare maggiore, Miracolo di S. Pietro di Alessandro Tiarini.
-
Sistema sotterraneo Spìpola-Acquafredda
San Lazzaro di Savena (BO)
L’altopiano di Miserazzano è costituito da un terreno carsico in cui si aprono numerose grotte, coperto da una nuda vegetazione termofila nelle parti più soleggiate e da vegetazione mesofila sul fondo delle doline.
Quasi al centro dell’area si trova il sistema sotterraneo Spipola-Acquafredda, il più importante complesso carsico nelle formazioni gessose dell’Europa occidentale, con quattro diversi punti d’accesso, attualmente esplorato per più di 8 km, con un dislivello di m 150 circa.
I primi 700 metri della grotta sono accessibili con visite speleologiche guidate, da un accesso artificiale aperto sul fondo della dolina. Il lungo traforo idrogeologico, di cui si conosce il corso principale dall’inghiottitoio nel vallone del torrente Acquafredda alla risorgente sulle rive del Savena, presenta tutte le morfologie degli ambienti ipogei, tra i quali i grandi saloni Giordani e del Fango, quest’ultimo caratterizzato dai mammelloni rocciosi che pendono dal soffitto.
-
Chiesa di S. Cecilia
San Lazzaro di Savena (BO)
Appartenuta a un’abbazia abitata dai monaci vallombrosani fino al 1487 e successivamente dai Canonici Regolari Lateranensi. La costruzione neoclassica (1830 circa) ospita all’interno due opere del Mastelletta, una Via Crucis in terracotta del secolo XV e un Gesù Bambino attribuito ad Annnibale Carracci. A fianco, un piccolo chiostro cinquecentesco con lapidine gotiche. La chiesa è stata dichiarata Monumento di Pace dall'Unesco.
-
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa
San Lazzaro di Savena (BO)
Esteso su una superficie di circa 5.000 ettari nei comprensori dei Comuni di San Lazzaro di Sàvena, Ozzano dell’Emilia e in piccola parte di Pianoro e Bologna. A Ozzano, nella villa Torre è il Centro visite. L’area dei gessi, compresa tra i torrenti Zena e Sàvena, il rio Olmatello e il Monte Calvo, è di rilevante interesse naturalistico: l’affiorare del minerale di gesso si accompagna alla presenza di forme carsiche superficiali (doline, inghiottitoi) e sotterranee, le più importanti delle quali sono la grotta del Farneto e quella della Spipola-Acquafredda.
Le cave per lo sfruttamento del materiale gessoso hanno costituito una presenza storica in questo territorio (lastre di gesso sono state utilizzate per rivestire la torre Garisenda di Bologna), causando problemi di sicurezza e degrado ambientale che hanno portato alla loro recente chiusura.
Rilevante anche l’interesse botanico della zona (sono state censite 550 specie di piante), con una vegetazione, sostanzialmente mediterranea e xerofila (quercia, leccio, cisto, cipresso, pino marittimo, olivo, ginestra, ginepro) che lascia il posto, sul fondo delle doline, a piante tipiche dei climi freddi. -
Monte Calvo
Pianoro (BO)
A Monte Calvo, m 335, si trova la chiesa di S. Giovanni Battista, ricostruita nel 1628. Nella parte alta dell’agglomerato si leva il palazzo di Montecalvo, edificato nel XVI secolo dalla famiglia omonima.
-
Carteria di Sesto
Pianoro (BO)
Presso Carterìa di Sesto, m 115, si trova la chiesa di S. Andrea di Sesto, ricostruita dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale, che conserva un Martirio di S. Andrea della scuola del Guercino.
-
Pianoro
Pianoro (BO)
A m 200, ab. 17.528, costruito nell’immediato dopoguerra su un alto terrazzo fluviale, dopo la distruzione del paese vecchio.
-
Torre dei Lupari
Pianoro (BO)
Complesso di edifici di varie epoche: a un’originaria torre duecentesca con bertesca d’accesso, sono state accorpate costruzioni dei secoli XIV e XV con loggia e bella scala a chiocciola.
-
Pianoro Vecchio
Pianoro (BO)
A m 187, interamente ricostruito dopo la distruzione subita nel 1945. Fu la prima stazione di posta sulla via per la Toscana.
-
Chiesa di S. Giacomo
Pianoro (BO)
Sorta nel XV secolo, ristrutturata nel 1750 e riedificata dopo la guerra, la tela dell’altare maggiore con i Ss. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Agostino è della scuola del Francia.
-
Brento
Monzuno (BO)
A m 451, in pittoresca posizione presso l’antico Brintum, località munita sulla storica via per la Toscana, nota dal IX secolo, appartenuta alla Chiesa bolognese e poi a Matilde di Canossa che la donò con altre terre all’arcivescovo di Pisa. Un sentiero sale al Monte Adone m 655, costituito da arenaria pliocenica e caratterizzato da una vegetazione formata da praterie aride (xerobrometi) con presenze sporadiche di specie legnose mediterranee (leccio, alaterno e poche altre).
-
Castello di Zena
Pianoro (BO)
Risalente al XII secolo, molto alterato dagli interventi ottocenteschi, con torre originaria del secolo XIII. Il vicino edificio rurale presenta porta e finestre in conci, a sesto acuto.
-
Museo dei Botroidi
Pianoro (BO)
A Tazzola, frazione di Pianoro, in un’antica ex stalla è stato allestito il Museo dei Botroidi. Il museo è una sintesi di tutti gli aspetti geologici della val di Zena nei suoi diversi segmenti e comprende: una grande raccolta di botroidi (formazioni di sabbie conglutinate che possono assumere forma antropomorfa o zoomorfa) riuniti da Luigi Fantini, speleologo e archeologo bolognese; elementi che ricordano il castello di Zena; un modello di formicaio in sezione; artefatti di materiali paleolitici; una raccolta di fossili di provenienza locale.
-
Santuario di S. Maria di Zena
Pianoro (BO)
Si trova sul Monte delle Formiche m 638, masso di conglomerato pliocenico tra i più spettacolari dell’Appennino bolognese, sia per la continuità inusuale di affioramento sia per la varietà di aspetti. La notorietà del santuario è legata a un fenomeno naturale che si ripete agli inizi di settembre: sciami di formiche alate vengono a riprodursi e a morire; raccolte e benedette, sono utilizzate per unguenti e talismani. La chiesa, risalente all’XI secolo, in seguito più volte restaurata, è stata ricostruita nel dopoguerra.
-
Livergnano
Pianoro (BO)
Caratteristico borgo a m 500, nella spaccatura del Monte Bellaria, con parte delle case incastrate nella roccia.
-
Loiano
Loiano (BO)
A m 714, ab. 4.376, è un piccolo borgo frequentato per villeggiatura, in posizione dominante ai piedi del Monte Bastia. Fino al secolo scorso noto come stazione di posta, fu conquistato da Bologna nel 1276.
-
Ss. Giacomo e Margherita
Loiano (BO)
Fondata dagli Agostiniani nel XIV secolo, conserva, nell’abside, un S. Giacomo di Denijs Calvaert e una statua della Madonna del Carmine di Angelo Piò; in una cappella, Pietà in terracotta del secolo XVIII.
-
Parco Astronomico di Loiano
Loiano (BO)
Gli strumenti principali che lo compongono, ospitati in distinte strutture, sono due telescopi, il telescopio storico Zeiss e il più moderno telescopio Cassini, un planetario e un’aula didattica. Altri strumenti sono il calendario cosmico, l’orologio solare e un modello del Sistema solare, realizzato lungo il sentiero che collega il telescopio Cassini a telescopio Zeiss e al planetario.
-
Monzuno
Monzuno (BO)
A m 621, località di soggiorno, in aperta posizione fronteggiante la valle del torrente Setta. Poco fuori dell’abitato, lungo la strada per Bologna, si incontrano i ruderi dell’Ospedale per pellegrini, dipendente in origine dai Vallombrosani e gestito nel XIV secolo dai Francescani; su base romanica, ha una configurazione fondamentalmente settecentesca, con cortile porticato.
-
Mulino dell'Allocco
Monzuno (BO)
Lungo la valle del Savena, i mulini che si disponevano un tempo con una densità di circa uno a km, sono andati in gran parte in rovina o sono stati convertiti ad altre forme di energia, prima di cessare ogni attività. Integralmente conservati e disposti in successione sono invece il mulino dell’Allocco, edificato nel 1874 su strutture cinquecentesche, con bel portico e pittoresca passerella d’accesso, e il mulino della Grillara che reca la data 1599.
-
Santuario della Madonna dei Boschi
Monghidoro (BO)
Eretto nel 1680 e dedicato alla Madonna di S. Luca, arricchito di ornati e sculture di Antonio Gamberini nel 1785.
-
Monghidoro
Monghidoro (BO)
A m 841, ab. 3.703, vivace centro di villeggiatura che gode di un vasto panorama per essere situato in uno dei punti più alti del crinale tra Sàvena e Ìdice. Il toponimo potrebbe derivare da Mons Gothorum e attestare un insediamento goto a controllo dei passi toscani. Fu signoria degli Ubaldini, che dominavano sia il versante toscano sia quello bolognese, fino al 1246, quando il Comune di Bologna vi fondò il borgo franco con il nome di «Scaricalasino», munito di rocca, a controllo del passo della Raticosa. Tale denominazione, adottata ufficialmente fino al XIX secolo, derivava forse dalla posizione della località, di faticoso accesso, che obbligava a scaricare i giumenti per avvicendarli. Nella canonica, che affianca la pieve di S. Maria Assunta ricostruita dopo le devastazioni belliche (Immacolata e i Ss. Petronio e Dionigi di Giovanni Antonio Burrini), è un piccolo museo che raccoglie arredi sacri, medaglie e stampe. Sulla piazza principale, all’interno di un edificio residenziale, sono i resti molto manomessi della quattrocentesca abbazia di S. Michele ad Alpes.
-
Parco naturale provinciale «La Martina»
Monghidoro (BO)
Nel territorio di Monghidoro è stato istituito il parco naturale provinciale «La Martina», esteso su 155 ettari e interamente boscato a conifere. È organizzato per il lavoro delle scuole con un percorso didattico-naturalistico.
-
Museo della Civiltà contadina e Piccolo Museo dell’Emigrante
Monghidoro (BO)
Il Centro di documentazione ospita un Museo della Civiltà contadina (oltre alle abituali ricostruzioni di ambienti tradizionali, c’è la ricostruzione di un mulino ad acqua in scala uno a tre) e il Piccolo Museo dell’Emigrante che con oggetti e documenti racconta gli anni dell’emigrazione dei Monghidoresi e – cosa assai più rara – quella dei nuovi immigrati che hanno scelto l’Italia.
-
Castel dell'Alpi
San Benedetto Val di Sambro (BO)
Apprezzato per il vicino laghetto, originato da una frana staccatasi nel 1951 dalle pendici del Monte dei Cucchi m 1140.
-
Madonna dei Fornelli
San Benedetto Val di Sambro (BO)
A m 798, sulla displuviale tra il Sàvena e il torrente Sambro, deriva il nome da un santuario, ingrandito e trasformato nel 1630 per voto contro la peste.
-
Piano del Voglio
San Benedetto Val di Sambro (BO)
A m 610, centro di soggiorno in vicinanza di abetaie, faggete e boschi di castagni. Alle spalle della chiesa, il palazzo dei conti de’ Bianchi che furono feudatari del luogo dal 1534 al 1797, mentre all’uscita dal paese si trova la fattoria La Torre, già centro del feudo.
-
Pian di Balestra
San Benedetto Val di Sambro (BO)
Nella verde zona montana dove si sono sviluppati i villaggi residenziali, dotati di attrezzature ricettive e di svago, di Pian delle Ginestre e Valserena, si trova Pian di Balestra m 950. In prossimità di quest’ultimo, tra le località La Faggeta e Piana degli Ossi, al di là dell’antico confine col Granducato di Toscana, è stato individuato negli anni '70 il primo tratto affiorante del tracciato della romana Via Flaminia Militare, citata da Tito Livio, che collegava Bologna a Firenze passando per il passo della Futa.
Negli 11 km di strada scoperti, oltre al basolato, in alcuni tratti in ottime condizioni, è stata rinvenuta la cava utilizzata per estrarre la pietra dei basoli. Il tracciato complessivo, lungo circa 60 km, si manteneva quasi pianeggiante lungo il crinale su livelli a lungo oscillanti intorno ai 500 m, prima di scendere verso la Via Emilia in prossimità del sito della romana Claterna. -
Raticosa (Passo della)
A m 968, aperto tra i rilievi ofiolitici del Monte Canda m 1158 e del Monte Oggioli m 1290. Al passo della Raticosa, fino all’epoca risorgimentale, la strada per la Toscana si congiungeva a un antichissimo itinerario, che correva lungo lo spartiacque tra le valli dei torrenti Ìdice e Sìllaro, il cui andamento corrisponde alla Via Flaminia Militare.
-
Futa (Passo della)
A m 903, sulla dorsale tra il Santerno e il fiume Sieve. Un grande muraglione fu costruito nel 1835 a riparo dai venti. In posizione dominante, il Cimitero militare germanico.
-
Cimitero militare germanico della Futa
Costruito nel 1962-65 da Dieter Oesterlen, il più grande dei tre esistenti in Italia, raccoglie le salme di oltre 32.000 caduti in combattimento durante l’ultimo conflitto, nelle province emiliane e toscane. È articolato in un lungo muro in pietra viva, che con andamento spiroidale contorna, innalzandosi progressivamente, la cima che domina a nord-ovest il passo della Futa.
-
Bisano
Monterenzio (BO)
Costeggiando l’Ìdice, ancora prima di raggiungere Borgo Bisano m 275, si individua su un colle isolato la chiesa del paese, dedicata a S. Alessandro Papa, ricostruita nel secolo XIX. Nell’abitato, disposto a valle della strada, sono interessanti il cinquecentesco oratorio di S. Rocco e la casa Cella, costruzione quattrocentesca con corte murata, loggiato e portale datato 1479. In posizione elevata Bisano m 375.
-
Area archeologica di Monte Bibele
Monterenzio (BO)
L’area archeologico-naturalistica di Monte Bibele è accessibile da San Benedetto del Querceto seguendo la carrozzabile di circa 3,3 km che si stacca a sinistra della strada di attraversamento e supera l’abitato di Quinzano m 490, per procedere poi a piedi per 2 km (circa 40 min.).
Gli scavi sono stati condotti dagli inizi degli anni settanta e hanno messo in luce, lungo le pendici orientali del Monte Bibele m 617, sulla Pianella di Monte Savino c. 300 m sopra il livello dell’Ìdice, un villaggio fondato nella prima metà del IV secolo a.C. da una comunità di Etruschi, affiancata da una componente celtica, che venne distrutto integralmente agli inizi del II secolo a.C. da un incendio, probabilmente da porre in relazione alle operazioni di conquista dei Romani.
I materiali rinvenuti sono conservati presso il Museo civico di Monterenzio e testimoniano la vitalità dell’insediamento, che occupava un’area di circa 7000 m2, in gran parte esplorati; questo, a causa della forte pendenza del colle, era disposto su una decina di terrazzamenti artificiali che ospitavano ciascuno da 3 a 7 abitazioni, raggruppate in isolati separati da strade, che si incrociavano tra di loro, larghe da 1 a 2 m, lastricate con ciottoli.
Le abitazioni avevano muri perimetrali a secco in sassi e lastre di arenaria, estratti dalla stessa montagna, associati probabilmente in alcuni casi a pareti e tramezzi lignei che non si sono conservati; con pavimenti in terra battuta e focolare, avevano coperture in paglia e legno sorrette da pali, di cui rimangono le buche d’imposta.
Alle case si affiancavano le strutture di uso collettivo, quali i magazzini per le derrate alimentari e la cisterna per la captazione dell’acqua sorgiva, con una capacità di 80.000 litri, profonda in origine m 4. La necropoli, situata 200 m a nord-ovest dell’abitato lungo il pendio del Monte Tamburino, è costituita da circa 170 tombe, prevalentemente a fossa, scavate direttamente nel terreno, senza alcun rivestimento litico; i riti funerari praticati erano l’inumazione e la cremazione, con netta prevalenza della prima. -
Monterenzio
Monterenzio (BO)
A m 206, ab. 6169, è il maggiore centro agricolo della valle. Vi ha sede il Museo civico «L. Fantini», che illustra le fasi dell’insediamento nelle valli dell’Ìdice e dello Zena, dalla preistoria all’età moderna.
Nelle colline di Monterenzio è aperto lo stabilimento termale delle Terme dell'Agriturismo, che si definisce 'villaggio della salute'; è infatti un moderno complesso di strutture edilizie, piscine e attrezzature.
Dall’abitato si stacca sulla destra una strada che con frequenti risvolte, lasciata a sinistra la torre degli Ungarelli o dei Pagani di impianto duecentesco ma con aggiunte successive, sale a Monterenzio Vecchio m 578, sul crinale tra la valle dell’Ìdice e del Sìllaro.
Nulla resta dell’antico castello; nel palazzo Frontini, massiccia mole cinquecentesca, soggiornò nel 1904 il drammaturgo norvegese Bjornstjern Bjornson.
-
Museo archeologico «Luigi Fantini»
Monterenzio (BO)
Inaugurata nel 2000, la nuova sede del museo è un moderno edificio.
L’allestimento (rinnovato nel 2015) illustra le fasi dell’insediamento nelle valli dell’Idice e dello Zena, dalla preistoria all’età moderna. Sono esposti interessanti reperti del Paleolitico e dell’età del Bronzo, e corredi tombali villanoviani.
Il nucleo più importante è costituito dai reperti rinvenuti negli scavi dell’abitato di Monte Bibele: utensili di lavoro, vasellame, locale e d’importazione, iscrizioni etrusche, monete celtiche e romane.
Dalle necropoli provengono i corredi funerari delle tombe di donne e guerrieri. Di particolare interesse il materiale celtico: fibule, spade e foderi decorati e uno straordinario disco solare in terracotta. Sono inoltre presenti ritrovamenti romani.
Il museo si è arricchito della ricostruzione in scala reale di un modello di casa dell’abitato etrusco-celtico di Pianella di Monte Savino.
-
Pizzano
Monterenzio (BO)
Pizzano Vecchia, m 366, è caratterizzata dalla presenza di due case-torri cinquecentesche e nelle cui vicinanze si osservano pittoresche formazioni acuminate di roccia arenaria, dette Castelloni.
-
Badia di Monte Armato
Ozzano dell'Emilia (BO)
Monte Armato m 250, in posizione panoramica nella valle dell'Idice, fu sede nel Medioevo di un’abbazia di cui, nella parte bassa dell’abitato, rimane la chiesa, che ha mantenuto il nome di Badia di Monte Armato; dell’originaria costruzione, risalente ai secoli XII-XIII conserva l’abside e il campanile con bifore.
-
Castel dei Britti
San Lazzaro di Savena (BO)
All’interno dell’area del Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa si trova Castel dei Britti m 165, disposto in posizione elevata, anticamente Castrum Brittorum, denominato anche Castel Gessaro.
-
Settefonti
Ozzano dell'Emilia (BO)
Lungo il versante orientale della valle dell’Ìdice si incontra Settefonti m 366, con chiesa di cui restano solo la facciata e il campanile diroccati. Subito avanti, sulla destra, la Torre, palazzo dei Mezzovillani di probabile impianto cinquecentesco.
A sinistra, la via del Pilastrino conduce in breve, tra un suggestivo paesaggio di calanchi, al sito originario del monastero di S. Lucia di Settefonti, segnato da una semplice colonnetta (il pilastrino che dà il nome alla via) con lapide del 1679 che riporta la leggenda della Beata Lucia.
Il complesso conventuale camaldolese, attestato dal 1099, venne abbandonato nel 1245 dalle monache che si trasferirono nell’omonimo convento di Bologna, a causa della franosità della zona.
Alle vicende di questo monastero deve il suo nome il passo dell’Abbadessa, un’esile cresta calanchiva lunga circa 1 km, con uno stretto sentiero sul culmine.
-
Palazzo Guidalotti di sotto
Ozzano dell'Emilia (BO)
Noto anche come Villa Favorita, di origine cinquecentesca, articolato in due corpi di fabbrica (uno sormontato da torrione, l’altro con guardiole angolari) uniti da un arco d’accesso affacciato verso la pianura.
Tra gli alberi, della stessa via, c'è anche palazzo Guidalotti di sopra, costruzione seicentesca con torre angolare e oratorio, mentre avanti, in via delle Armi, del castello di Ozzano, ricordato dal 1117, restano la torre d’accesso al borgo, con caditoie sul lato a nord sostenute da mensole di arenaria.
-
Palazzo Bianchetti
Ozzano dell'Emilia (BO)
Preceduto da un viale di pini, risalente al XVI secolo e passato nel XIX ai Barnabiti e quindi al Collegio di Spagna di Bologna.