In collaborazione con 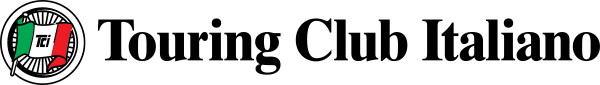
Nei suoi limiti attuali la città storica corrisponde solo parzialmente al perimetro della cinta bastionata di età moderna, essendo difficile tracciare a Parma un confine netto tra centro antico ed espansioni otto-novecentesche.
Realizzato tra il 1901 e il 1932, l’anello dei viali di circonvallazione si discosta in parte dal tracciato delle mura, pur collegandone le porte: oggi esso ingloba consistenti aree edificate nel XIX e XX secolo (zone di completamento, imbonimenti nel greto del Parma), i cui caratteri urbanistico-architettonici sono analoghi alle corrispondenti parti esterne.
Il nucleo antico risulta così meno compatto di quello di altre città emiliane. Il torrente Parma divide il centro in due porzioni: a est la parte cresciuta, secondo linee concentriche, tra l’XI e il XIV secolo, attorno al nucleo di fondazione romana, a ovest l’Oltretorrente.
Nella prima si conservano i segni più consistenti della storia politica e artistica della città, segni che sono andati aggregandosi intorno a tre poli principali: il centro della vita pubblica (piazza Garibaldi), entro il nucleo d’impianto romano; il centro religioso (il Duomo), lungo il suo limite nord; il centro ducale (la Pilotta), all’angolo nord-occidentale.
Ancora percepibile, il piano ortogonale romano si stende a est del torrente. Nell’area a nord della Via Emilia sopravvivono, tra palazzi per uffici e di rappresentanza, alcuni tra i maggiori esempi dell’architettura religiosa del Rinascimento parmense; meno scompaginata dalle trasformazioni edilizie, l’area a sud presenta un’orditura più omogenea che ha in gran parte conservato il volto sette-ottocentesco.
-
Lunghezzan.d.
-
Parma
Parma (PR)
Situata lungo la Via Emilia e attraversata dal torrente omonimo, Parma (m 57, ab. 200.455) costituisce un centro di polarizzazione per il settore occidentale della regione.
Le memorie dell’età comunale (il Duomo e il Battistero) e le testimonianze del suo passato di capitale di ducato ben si combinano con un tessuto culturale particolarmente vivace; Parma offre istituzioni e monumenti da grande città, quasi in contrasto con il suo carattere ambientale, tipico di un centro medio della Padania.
Nel 2016 Parma ha conquistato il titolo Unesco di Città Creativa per l’Enogastronomia, giustificato dal numero di prodotti Dop e Igp del suo territorio, che danno vita a un sistema museale legato al cibo.
Istituita capitale della Foodvalley, è anche sede dell’Efsa (European Food Safety Authority), Autorità per la Sicurezza Alimentare dell’Unione Europea.
-
Piazza Garibaldi
Parma (PR)
La piazza Garibaldi (piazza Grande fino al XIX secolo) è il centro della vita cittadina, in parte coincidente con l’area del forum che si estendeva a sud della Via Aemilia (oggi strada della Repubblica a est, strada Mazzini a ovest).
L’aspetto attuale della piazza presenta un carattere eterogeneo, conseguenza delle successive fasi di formazione e delle più recenti alterazioni novecentesche lungo il lato ovest.
Attorno a quest’area nel XIII secolo si disposero le sedi del Comune: dapprima il palazzo del podestà Torello da Strada (detto poi del Comune, degli Anziani o dei Notai), 1221, e altre pertinenze completarono il lato sud, poi nel 1282-85, con la costruzione del palazzo dei Mercanti (ora del Governatore) sul lato nord la piazza assunse la forma attuale.
Nel XIV secolo lo spazio venne racchiuso entro una fortezza con quattro porte e quattro torri. Dopo il crollo (1606) di una torre duecentesca, eccessivamente sovralzata durante il XV secolo, si rifabbricò il palazzo del Comune (1627-30; tuttora incompleto).
Una nuova torre (1673) sul lato nord fu inglobata nel generale rifacimento neoclassico che, insieme all’allontanamento del mercato nel primo Ottocento, completò l’opera di valorizzazione funzionale e architettonica.
-
Chiesa di S. Vitale
Parma (PR)
Chiesa barocca, opera di Cristoforo Rangoni (1651-58). Interno a croce latina con cupola (il cui transetto corrisponde alla precedente fabbrica duecentesca), a una navata e quattro cappelle per lato.
Significativa è la decorazione a stucco del transetto sinistro, intitolato alla Madonna di Costantinopoli, dei ticinesi Domenico e Leonardo Reti (1666-69). Notevole anche il presbiterio (affreschi di Giuseppe Peroni, 1763; dipinto di S. Vitale condannato a morte di Michele Plancher). Inoltre: nella 3a cappella sinistra, Incontro tra Luigi XI e S. Francesco di Paola, tela di Gaetano Callani (1799); nella 2a destra, Madonna di Caravaggio, attribuita a Carlo Francesco Nuvolone; nella 1a destra, S. Carlo Borromeo di Mauro Oddi.
-
Palazzo del Governatore
Parma (PR)
Sul lato nord della piazza Garibaldi E.A. Petitot realizzò la lunga fronte neoclassica del duecentesco palazzo del Governatore (aperto al pubblico in occasione di mostre); al centro, la Torre (1673), con meridiana del 1829 e statua della Madonna col Bambino di J.B. Boudard (1762), fronteggiata dal bronzeo monumento a Garibaldi di Davide Calandra (1893).
Dopo un accurato restauro, il palazzo è stato riaperto al pubblico nel 2010, divenendo la principale sede espositiva della città dedicata all’arte contemporanea.
-
Palazzo del Comune
Parma (PR)
Nell’angolo sud-est della piazza Garibaldi è il palazzo del Comune; disegnato da G.B. Magnani (1627), è un massiccio volume laterizio scandito da paraste, nicchie e riquadri, interamente loggiato a pianterreno; all’esterno, monumento a Correggio di Agostino Ferrarini (1870); sul lato opposto del palazzo è una fontana disegnata da Paolo Toschi (1829), sormontata dalla copia del seicentesco gruppo in rame di Ercole e Anteo, opera di Teodoro Vandersturck (originale nel cortile di palazzo Cusani).
Uno scalone ottocentesco sale al piano superiore, ove nell’atrio, nella sala del Consiglio (ornata di affreschi di Cecrope Barilli e Girolamo Magnani) e nello studio del sindaco si conservano dipinti di Annibale Carracci, Bernardino e Gervasio Gatti, Frans Denys, Ilario Spolverini.
Il complesso municipale incorpora altri edifici di origine medievale: nel lato sud della piazza, l’ex palazzo del Podestà (o del Capitano), con merli e trifore ripristinati nel 1904-10 (lo sfalsamento indica l’andamento di uno scalone poi demolito).
All’imbocco della strada della Repubblica è l’ex palazzo delle magistrature podestarili poi dell’Uditore criminale, con grandi trifore: accanto sono visibili tracce dell’antica Domus civitatis (XIII secolo).
-
Chiesa di S. Pietro
Parma (PR)
Nel lato ovest della piazza Garibaldi emerge la chiesa di S. Pietro, con facciata realizzata su progetto di E.A. Petitot (1760-62).
Interno a una sola navata, con altari laterali e alta cupola. Gli stucchi dei pilastri e dei pennacchi e il 2° altare sinistro sono opera di Antonio Ferraboschi; gli affreschi della volta, cupola e pennacchi sono di Antonio Vizzani (1715 circa).
Al 1° altare sinistro, S. Giuseppe morente di Alessandro Bernabei; sotto la cantoria sinistra, affresco con la Madonna col Bambino attribuito ad Alessandro Araldi; interessante l’altare maggiore con l’ancona, in legno intagliato e dipinto a motivi neoclassici, di Odoardo Panini (1781).
-
Chiesa di S. Rocco
Parma (PR)
La chiesa di S. Rocco fu trasformata dai Gesuiti su disegno di Alfonso Torreggiani (1737) e modificato in corso d’opera (1737-54) da Edelberto dalla Nave. L’interno a una navata è articolato da un’alternanza di cappelle e avancorpi poligonali includenti coretti lignei.
Nel presbiterio, dietro l’altare maggiore, Madonna col Bambino in gloria e S. Rocco di Francesco Scaramuzza.
Nella cappella a sinistra del presbiterio, alla parete sinistra, monumento alla contessa Giacinta Sanvitale attribuito ad Alberto Oliva (1652), con busto della defunta.
La chiesa era annessa all’adiacente ex collegio gesuitico, vasto complesso che dal 1768, allorché la compagnia venne espulsa, ospita uffici dell’Università.
-
Università
Parma (PR)
L’edificio ha origine dalla donazione (1564) della chiesa di S. Rocco ai Gesuiti che, istituito il collegio, trasformarono e ampliarono il complesso nel XVII secolo, fino a conferirgli l’attuale severo aspetto di blocco quadrangolare.
Espulsi i Gesuiti, venne qui trasferita l’Università, uno dei più antichi Studi d’Italia. Già nell’XI secolo esisteva una scuola in cui si insegnavano le sette arti liberali; nel XII vi fiorivano un collegio di medici e uno di giuristi, e nel XIII vi insegnava dialettica Giovanni Buralli.
I due periodi di maggiore floridezza furono la prima metà del Seicento, quando il duca Ranuccio le diede privilegi amplissimi, e la seconda metà del Settecento, quando Ferdinando I di Borbone le conferì il titolo di Università di Stato (1768), dotandola dei beni dei Gesuiti.
Conservata durante la dominazione francese, favorita nei primi anni del governo di Maria Luigia, fu chiusa nel 1831, e da allora ebbe inizio una fase di decadenza che si protrasse fino ai primi decenni del Novecento.
Attualmente essa comprende i seguenti dipartimenti: Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali; Giurisprudenza, studi politici e internazionali; Ingegneria e architettura; Medicina e chirurgia; Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale; Scienze degli alimenti e del farmaco; Scienze economiche e aziendali; Scienze matematiche, fisiche e informatiche; Scienze medico-veterinarie.
I dipartimenti di ambito scientifico-naturalistiche (con Ingegneria) sono dislocati nel cosiddetto Campus universitario – area delle Scienze, appositamente costruito nella zona sud della città (via Langhirano).
L’Università possiede cospicue raccolte scientifiche, che nel loro insieme compongono il Sistema Museale d’Ateneo. Sono importanti, oltre al Museo di Paleontologia, il Museo di Mineralogia e il Museo di Storia naturale.
-
S. Tomaso Apostolo
Parma (PR)
Fondata nell’XI secolo ma radicalmente trasformata nel Settecento; lungo il fianco sinistro, tracce delle strutture originali; all’interno, dietro l’altare maggiore, Natività attribuita ad Alessandro Mazzola.
-
Museo di Storia naturale
Parma (PR)
Il Museo di Storia naturale comprende la collezione Fourcault, le collezioni Strobel, la collezione Eritrea Bottego (circa 600 esemplari raccolti dal capitano Vittorio Bottego in due anni nella regione di Massaua, Asmara e Cheren), la collezione Andres, la collezione del Prato di Fauna parmense, la collezione Piola del Congo Belga, donata nel 1907 da Emilio Piola, e la collezione Ferrante.
-
Conservatorio di musica «Arrigo Boito»
Parma (PR)
Istituito nel 1888 presso l’ex convento del Carmine, con la chiesa (secolo XIV) in forme gotiche, attualmente adibita ad auditorium del Conservatorio; a tre navate separate da pilastri polistili, fu completata negli arredi e nelle decorazioni nei secoli XVI-XVIII.
Dopo le soppressioni napoleoniche la chiesa perse il suo importante patrimonio pittorico, del quale rimangono solo frammentari affreschi quattrocenteschi e i dipinti del primo Seicento della volta della piccola sagrestia.
Il piccolo Museo storico del Conservatorio ospita tra l’altro: la ricostruzione dello studio di Arturo Toscanini (1867-1957), allievo interno del Conservatorio, con biblioteca e un pianoforte Steinway; lo studio di Arrigo Boito (1842-1918) con una biblioteca e testimonianze della sua attività come librettista di opere di Giuseppe Verdi; una collezione di strumenti musicali antichi.
-
Ponte di Mezzo
Parma (PR)
Nel sottopasso pedonale del ponte di Mezzo sopravvivono due arcate dell’antico ponte romano (187 a.C.), originariamente formato da 11 arcate, che consentiva alla Via Emilia di varcare il torrente, e abbandonato per lo spostamento del torrente nel secolo XII.
La riqualificazione del sottopasso e la ‘musealizzazione’ del grande manufatto archeologico è stata completata grazie all’ideazione di Spazio Aemilia 187 a.C., un percorso espositivo che raccoglie in vetrine una parte dei reperti portati alla luce durante gli scavi di realizzazione del parcheggio interrato dell’adiacente piazza Ghiaia; gli oggetti rinvenuti – alcuni dei quali preziosi – erano stati gettati dai passanti a scopo di buon augurio o caduti durante l’attraversamento del ponte.
-
S. Alessandro
Parma (PR)
Già parte di un complesso conventuale di Benedettine di antica fondazione (837), in gran parte distrutto nel 1821 per la costruzione del Teatro Regio, la chiesa di S. Alessandro risale, nelle strutture attuali, all’edificio costruito nel 1527 su disegno di Bernardino Zaccagni, ampiamente modificato in facciata da Antonio Bettoli (1784), e all’interno da G.B. Magnani (1622), cui si deve anche il campanile (1626).
L’interno è un esempio tra i più intatti di intreccio scenografico di architettura e decorazione del primo Seicento emiliano.
La sola navata scandita da una catena di serliane ha il suo fulcro nell’altare maggiore, realizzato dallo stesso Magnani; la pala con la Madonna col Bambino e i Ss. Giustina, Alessandro papa e Benedetto, è opera di G. Mazzola-Bedoli (1540 circa); la cupola e i pennacchi furono affrescati da Alessandro Tiarini (1627), mentre tutta la grande decorazione della navata si deve al giovane Angelo Michele Colonna (1625).
-
Chiesa di S. Maria della Steccata
Parma (PR)
Splendida chiesa costruita a partire dal 1521 a spese del Comune per contenere un’immagine della Madonna ritenuta miracolosa, in origine sul muro di un piccolo oratorio, detto «dello steccato» dal riparo in legno che frenava l’afflusso dei fedeli; consacrata nel 1539, venne elevata nel 1718 a chiesa magistrale dell’ordine Costantiniano di S. Giorgio.
La fabbrica è una potente aggregazione di prismi e semicilindri, aperti da eleganti finestre, sormontata da una cupola a loggiato in biancone e rosso di Verona, con lanterna: un impianto che sancisce l’affermazione della cultura rinascimentale a Parma.
Tra le molte ipotesi attributive (Vasari parlò di Bramante, ora si pensa a un’idea leonardesca) emerge con certezza solo l’apporto, in qualità di capi d’opera, di Bernardino e Giovan Francesco Zaccagni, fino al 1525, poi di Giovan Francesco da Agrate, che realizza forse alcuni suggerimenti di A. da Sangallo il Giovane.
Gli ornati di coronamento (volute, festoni, statue, vasi e balaustrata) furono aggiunti nel 1696 da M. Oddi.
L’impianto centrale dell’interno è esaltato dai quattro potenti arconi che delimitano un vasto spazio mediano, attorno al quale si dispongono quattro bracci absidati e altrettante cappelle ottagonali inserite nelle torri angolari; l’armonia delle linee architettoniche originarie non appare alterata dalla costruzione (1725-30), a ridosso dell’abside presbiteriale, del coro dei Cavalieri, capolavoro di Edelberto dalla Nave, che comunica con la chiesa tramite una tripla apertura ad arco.
1° braccio. Nel catino, Adorazione dei Magi di Michelangelo Anselmi (1548), cui si devono anche gli affreschi del grande arco e dei sottarchi; tutti i dipinti furono portati a termine da Bernardino Gatti (1559) dopo la morte dell’artista; le eleganti pilastrate a chiaroscuro sono di Andrea Seghizzi (1669). Sopra il portale, L’elezione dell’Immacolata del Malosso (1594); alle pareti, due tele, in origine portelle d’organo, con David a destra e S. Cecilia a sinistra, opere giovanili del Parmigianino (1522-23), ampliate poi da Jan Sons con le grandi colonne tortili sorreggenti putti.
A sinistra dell’ingresso è collocato il monumento funebre al conte Adamo Neipperg, marito morganatico di Maria Luigia, con effigie del defunto, opera di Lorenzo Bartolini (1829-31).
1a cappella d’angolo. All’altare, Il Redentore in gloria con S. Antonio da Padova e la Maddalena di A. Mazzola (1605); di fronte, a sinistra, monumento funebre a Bertrando Rossi di Bartolomeo Spani (1531-36).
2° braccio. Nel catino, Natività e adorazione dei pastori di G. Mazzola-Bedoli (1553-67) che dipinse anche l’arcone e i sottarchi; le pilastrate a chiaroscuro sono di Mercurio Baiardi (1568), pressoché rifatte dal Seghizzi (1669). All’altare, S. Giorgio che uccide il drago con Sacra Famiglia in gloria, opera accademica di Marcantonio Franceschini (1718); ai lati, statue raffiguranti la Fortezza e la Prudenza di Francesco e Gian Giacomo Baratta su modelli di Giuliano Mozzani (1726-28).
2a cappella d’angolo. All’altare, Madonna col Bambino e i Ss. Ilario e Giovanni evangelista di Innocenzo Martini (1605); a destra dell’altare, monumento funebre a Guido da Correggio di G.B. Barbieri (1568-70); tavola con Madonna col Bambino e i Ss. Luca e Giovanni Battista e angeli musici di Simone Martinazzi detto delle Spade (1520 circa) a destra dell’altare.
Nella cupola, l’affresco raffigurante l’Assunzione della Vergine di B. Gatti (1560-72), ispirata alla cupola correggesca del Duomo. Dello stesso Gatti sono gli Apostoli tra le finestre del tamburo e i dipinti dei pennacchi; i riquadri al disotto delle finestre e il fregio con putti si devono a Lattanzio Gambara; i chiaroscuri dei pilastri su cui si imposta la cupola sono di Giovanni Maria Conti (1669), a eccezione di quelli presbiteriali, di Pietro Rubini (1760 circa).
3° braccio. Notevolissimo è il ciclo decorativo dell’arcone che, realizzato per primo dal Parmigianino (1530-39), rappresentò il modello per la decorazione degli altri: è costituito da due serie di tre canefore alle estremità e da una ricchissima ornamentazione con figurazioni animali e vegetali su fondo rosso, tra 14 rosoni in rame dorato, posti entro lacunari; le figure femminili, caratterizzate dal fatto di reggere lampade accese a destra e spente a sinistra, richiamano la parabola evangelica delle Vergini sagge e folli; nei sottarchi aggettanti, con motivi dorati su fondo blu, compaiono quattro figure monocrome ai lati delle canefore, Eva e Aronne a destra, Adamo e Mosè a sinistra.
L’opera, che venne realizzata con l’utilizzazione di cartoni e l’intervento di aiuti, rivela un gusto decorativo straordinariamente raffinato, una stesura materica preziosissima, un’eleganza estrema nei corpi allungati e sinuosi.
Nel catino dell’abside, Incoro nazione della Vergine, realizzata da M. Anselmi (1540-47) su cartoni di Giulio Romano; le pilastrate sottostanti con allegorie dell’Innocenza e della Castità sono di P. Rubini (1760 circa).
Il presbiterio presenta un ricco arredo realizzato alla metà del secolo XVIII. Sull’altare, statue di David e S. Gioacchino di Francesco e Gian Giacomo Baratta, su modello di G. Mozzani (1726-28); l’affresco dell’ancona con la Madonna allattante il Bambino, di artista padano della fine del XIV secolo, è la venerata immagine alla quale è legata la costruzione del tempio.
Coro dei Cavalieri. Al centro della volta, entro una cornice mistilinea, Assunzione della Vergine di A. Vizzani (1729-30), autore anche dei quattro ovati monocromi; i pennacchi sono di Giuseppe dalla Nave, cui vengono attribuite anche le sottostanti pilastrate.
Lungo la parete, coro ligneo intagliato da Gaetano Banzi (1750-53), e al disopra del leggio, Cristo risorto, in bronzo, di Andrea Spinelli (1543). Per una porta a sinistra si passa nel corridoio della sagrestia, con un prezioso lavabo di G.F. da Agrate (1514 circa), proveniente dal convento di S. Paolo. Qui affacciano la sagrestia comune e la sagrestia nobile, quest’ultima con notevoli armadi lignei (1665-70) realizzati da G.B. Mascheroni, Carlo Rottini e Rinaldo Torri; le statue degli Evangelisti sono di Francesco Niccolino (1670); sull’altare, Sacra Famiglia di Jan Sons (1607).
Dal corridoio una porticina immette nella cappella sepolcrale, fatta costruire da Maria Luigia nel 1823 per ospitare le tombe dei duchi di Parma, Farnese e Borbone; l’arca in pietra di fronte all’altare contiene le ceneri di Alessandro Farnese e della moglie, Maria Daviz di Portogallo.
Rientrati in chiesa, si passa a visitare la 3a cappella d’angolo. All’altare, dipinto con il Crocifisso tra i Ss. Girolamo e Rocco di Antonio Bresciani (1783); a destra, monumento funebre a Ottavio Farnese, con busto attribuito a G.B. Fornari e parti decorative realizzate su disegno di Antonio Brianti (1765); di fronte, monumento funebre a Sforzino Sforza, elegante opera rinascimentale di G.F. da Agrate (1528-36).
4° braccio. Nel catino dell’abside, Pentecoste di G. Mazzola-Bedoli (1547-53), del quale è pure la decorazione dell’arcone e dei sottarchi; i chiaroscuri delle pilastrate sono di A. Seghizzi (1669).
Sull’altare, bella pala di Giambettino Cignaroli (1762-65), raffigurante Trinità con i Ss. Basilio, Gregorio taumaturgo e Nicola di Bari; ai lati, la Verginità e l’Umiltà, statue di Francesco e Gian Giacomo Baratta su modello di G. Mozzani (1726-28).
Alla parete destra, due tele, un tempo portelle d’organo, di Jan Sons (1580), raffiguranti Fuga in Egitto sullo sfondo di uno splendido paesaggio.
4a cappella d’angolo. All’altare, Madonna del Rosario, statua donata da Maria Luigia.
-
Museo costantiniano della Steccata
Parma (PR)
Presso il santuario della Steccata è stato inaugurato il Museo Costantiniano, che comprende una ricca quadreria, tessuti e paramenti preziosi del XVII secolo, suppellettili dei migliori argentieri dei secoli XVII e XVIII e cimeli della Casa di Borbone.
-
Chiesa di S. Lucia
Parma (PR)
Ricostruita da M. Oddi dopo il 1691 e recentemente restaurata, con facciata adorna di statue attribuite a Giacomo Barbieri. Interno a una navata, con volta e cupola affrescate da Filippo Maria Galletti. Dietro l’altare maggiore, bella pala di S. Ricci (1730).
-
Strada Cavour
Parma (PR)
Strada (già dei Mercanti o di S. Lucia), lungo la quale si allineano prestigiosi negozi.
Lungo il lato orientale sono la sede della Banca del Monte di Parma (Gio Ponti con Pier Luigi Nervi, Antonio Fornaroli e Alberto Rosselli, 1968-74) e, verso il fondo, il palazzo INA (Franco Albini, Franca Helg, 1951-54), e la chiesa di S. Lucia.
All’incrocio con l’asse via Pisacane-strada al Duomo, emergono, a sinistra il palazzo delle Poste (Moderanno Chiavelli, 1905-9) e di fronte la torre campanaria dell’ex convento di S. Paolo (Domenico Valmagini, 1690).