In collaborazione con 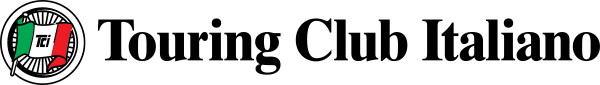
Il percorso è ambientato nella porzione urbana dove, dagli inizi del Seicento, più incisero gli interventi estensi: primo fra tutti il Palazzo Ducale che immette perentoriamente valenze monumentali e scenografiche, nonché dimensionali, estranee alla cultura locale, configurandosi nella stessa trama urbanistica – tutt’intorno diradata – come una sorta di isola, superbamente a sé, metafora pietrificata dell’imporsi della casa d’Este sulla vicenda storica modenese.
Acuto l’intento di rappresentanza anche nelle aree limitrofe, concresciute al palazzo: il corso Estense (ora corso Vittorio Emanuele II), di formazione seicentesca, i giardini ducali, l’aristocratico corso Canal Grande, nel quale più che altrove è percepibile l’atmosfera cortigiana, tanto di ancien régime che della Restaurazione.
Mezza giornata è più o meno il tempo richiesto dal percorso, non considerando però il Palazzo ducale, che richiede modi e tempi di visita insoliti.
-
Lunghezzan.d.
-
Modena
Modena (MO)
Modena m 34, ab. 189.013, ubicata lungo la Via Emilia, su una lieve altura a circa 30 km dalle montagne appenniniche, è città di grande vivacità civile e culturale, e, dal secondo dopoguerra, in costante rapida fase di espansione economica che, oltre ai prosperi comparti produttivi tradizionali (agricolo, zootecnico, tessile), vede fiorire soprattutto nuove aziende metalmeccaniche e le attività terziarie cosiddette avanzate. Prescindendo dai poli monumentali di fama più consolidata, a un’indagine superficiale Modena può apparire città dal volto dimesso, quasi sottotono rispetto ad altri centri padani dal prestigio indiscusso. In realtà, se la bellezza di Modena possiede timbri meno appariscenti, è pur viva, intensa, talora sontuosa; soltanto, essa si manifesta al di là degli austeri involucri delle sue chiese e dei riservati prospetti dei numerosi palazzi, al cui interno fantasiose scenografie decorative e architettoniche sorprendono frequentemente per l’acuto contrasto con gli esterni, essenziali eppure euritmici per qualità di moduli e profili.
-
Via Farini
Modena (MO)
Costituisce l’accesso relativamente angusto al piazzale del Palazzo ducale. La prima costruzione a destra (ingresso al N. 4), in angolo con la via Emilia, è un edificio già sede di un teatro documentato dal XVI secolo, poi appartenuto ai Rangoni, quindi al Comune, soppresso infine nel 1840 circa; l’attuale facies architettonica è saggio neorinascimentale di Cesare Costa. Sempre a destra, N. 12, il palazzo Rangoni, trasformato nella prima metà del XVIII secolo; il balcone fu aggiunto nel 1846 nel corso dei restauri diretti da Ludovico Caula. Allo sbocco nel largo S. Giorgio si manifesta repentinamente, non senza un previsto effetto sorpresa tipicamente barocco, la gran mole del Palazzo ducale.
-
S. Giorgio
Modena (MO)
Costruita attorno al 1650 dal Galaverna su progetto di Gaspare Vigarani, al posto di una cappella di cui si ha notizia dal 1189; di poco posteriore è l’elegante facciata a due ordini di Tommaso Loraghi, con statue di Giovanni Lazzoni. L'interno è a croce greca, definito da pilastri giganti a sostegno della cupola circolare, con fasci di colonne addossate che reggono tribune angolari simili ai palchetti di un teatro, raffinata citazione dall’ingegneristica teatrale di cui Vigarani fu autorevole esponente. Fulcro visivo è, nell’abside, l’ancona marmorea di Tommaso Loraghi, contenente la Madonna del Popolo, venerato affresco riportato su tela di Pietro Paolo Abbate (1617). All’altare destro, Annuncio dell’angelo a S. Giuseppe di Antonio Consetti, proveniente dalla soppressa chiesa di S. Teresa.
-
Palazzo Ducale
Modena (MO)
Enfatizzato, per contrasto, dalla discrezione architettonica del contesto circostante, al centro della piazza Roma si erge il Palazzo ducale, fastoso nella sua poderosa mole quadrilatera. Sorse a partire dal 1630 circa attorno al nucleo del castello fondato dagli Estensi nel 1288, distrutto ai primi del ’300 e ricostruito dal 1336, in corrispondenza di un cardine di collegamento tra il centro dell’abitato e il percorso del canale Naviglio. L’edificio vide mutare il proprio ruolo difensivo nel 1598 quando, eletta Modena capitale dello stato, la corte vi si trasferì da Ferrara. Dopo alcune riqualificazioni sotto Cesare, primo duca del ramo modenese, fu con Francesco I, regnante dal 1629, che se ne poté configurare una fisionomia di aulica rappresentanza. Attribuita la funzione difensiva alla Cittadella (eretta dal 1630 a nord della porta S. Agostino), si progettò un grandioso edificio che si agganciasse ai lati nord e ovest del castello, inglobandolo. Sviluppandosi a occidente dell’antica struttura, la fabbrica venne a insediarsi sulla confluenza di altri canali, con implicazioni anche di ingegneristica idraulica. Ci si affidò al romano Girolamo Rainaldi, e poi all’allievo Bartolomeo Avanzini, che avrebbe seguito la vicenda progettuale e il cantiere, consulenti Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Carlo di Castellamonte. Gli succederanno Gaspare Vigarani, Tommaso e Antonio Loraghi (quest’ultimo terminerà il cortile e lo scalone) e, tra gli altri, ormai nel Settecento, Pietro Bezzi e Pietro Termanini, operoso al torrione centrale; nel secolo XIX Giuseppe Maria Soli che erigerà l’ala orientale con articolato sistema di logge, il figlio Gusmano, autore dell’attico nel cortile, disegnato dal padre, Francesco Vandelli e Giovanni Lotti che compirà il prospetto settentrionale. Bartolomeo Avanzini realizzò la lunghissima facciata a tre ordini di finestre su doppie cornici marcapiano e balaustrata sul cornicione, fra due torri angolari; al centro, il torrione che si alleggerisce progressivamente nella sopraelevazione della loggia a tre arcate e in quella dell’orologio, collocato nel 1756. Ai lati del portale le statue di Ercole e di Emilio Lepido di Prospero Sogari, tra colonne libere che reggono la balconata. Il basamento pieno, tipico della cultura romana fra tardo manierismo e barocco che pur incise sulla progettazione, è qui sostituito dalle aperture dell’interrato, quasi che il palazzo sorga dal terreno piuttosto che vi si imponga. Se l’abbinamento delle finestre accresce la valenza dei vuoti sui pieni, con effetto di superficie traforata invece che di mole oppressiva, la balaustrata superiore, con statue di divinità mitologiche, esalta l’impressione di ariosità; le statue sul torrione centrale e sull’ala destra sono di Giovanni Lazzoni e di Gabriello Brunelli (1680 circa), quelle sull’ala sinistra di Giuseppe Graziosi (inizi XX secolo). Il palazzo è dal 1862 sede dell’Accademia militare, che trae origine dalla Scuola militare centrale di Fanteria istituita nel 1859, e provvede all’addestramento e alla preparazione degli ufficiali in servizio effettivo dell’esercito e dell’arma dei carabinieri, e dei servizi. All'interno, superato l’atrio, con il lapidario degli ex allievi caduti in guerra realizzato da Arturo Prati, si accede al *cortile d’Onore. Ideato dall’Avanzini, ha pianta rettangolare, cinta da portico e loggia superiore, strutturati entrambi su archi a tutto sesto poggianti su colonne libere e inquadrati nella maglia composta delle lesene e della balaustrata (l’attico è aggiunta del primo Ottocento); l’aerea sequenza di arcate fu concepita come perno fra l’edificio originario del castello e i corpi aggregati. Luogo cerimoniale per eccellenza, media l’accesso allo scalone la cui struttura, pur modellata su quella del romano palazzo Barberini, è reinterpretata in chiave scenografica emiliana. Dal loggiato si passa nelle sale storiche. Tra le prime, la sala delle guardie Nobili, dal soffitto a cassettoni dorato e argentato. Segue la galleria dello Stringa che ha il soffitto dipinto da Francesco Stringa con le Nozze di Amore e Psiche (1690 circa) tra stucchi di Antonio Traeri; notevoli i ritratti estensi, a opera di Sante Peranda, Justus Sustermans, Henri Gascars, Giuseppe Maria Soli, Luigi Asioli, e una grande Uccisione di Ezzelino da Romano di Adeodato Malatesta. La sala detta Camera d’oro è così chiamata per il soffitto dorato con specchi. Il salone d’Onore, situato in corrispondenza della torre centrale, ha la volta affrescata da Marcantonio Franceschini con l’Incoronazione di Bradamante da parte di Giove (1696; allusione alle nozze tra Rinaldo I e Carlotta Felicita di Brunswick). Dalla sala del Trono si accede al gabinetto d’Oro, piccolo vano rivestito da pannelli lignei dorati, smontabili, raffiguranti a rilievo Apollo e Dafne, Leda e il cigno, Pan e Siringa e il Ratto d’Europa, di un raffinatissimo rococò di marca francese spettante a Michele Salvatori (1756). Al piano nobile sono la biblioteca (circa 35 mila volumi), già appartamento dei Principi. Negli appartamenti trova posto il museo dedicato alla memoria degli ufficiali ex allievi delle accademie militari caduti in guerra. Sorto nel 1905, il museo ha recentemente riaperto i battenti dopo una risistemazione. Nelle sale si susseguono cimeli e ricordi dei militari scomparsi durante i moti risorgimentali, nelle guerre coloniali e nei due conflitti mondiali, insieme a documenti relativi alla storia dell’Accademia dal 1863 ai giorni nostri. Del patrimonio museale fanno inoltre parte alcune divise storiche, una collezione di figurini e modelli militari e due tricolori, uno donato nel 1849 da Carlo Alberto all’Accademia Militare di Torino, l’altro, del 1891, appartenente all’Accademia di Fanteria e Cavalleria. Il percorso espositivo si conclude solennemente con la Camera d’oro, ove si conservano i ritratti di circa cinquecento ufficiali insigniti di medaglia d’oro al valor militare e con la Stanza ovale delle colonne, già usata come sala da pranzo, suggestivo ambiente che funge da sacrario dei caduti della prima guerra mondiale.
-
Piazza Roma
Modena (MO)
Ampio spazio di rispetto a fronte del Palazzo ducale, delimitato da due ali di edifici di Giovanni Lotti affini per lineare classicismo. Sulla destra, il monumento a Ciro Menotti, fautore dei moti del 1831, di Cesare Sighinolfi (1879); nei medaglioni, le effigi di patrioti modenesi.
-
S. Domenico
Modena (MO)
Si affaccia sulla piazza omonima, dove si trova anche il ricostruito (1972) monumento ai Martiri del 1821 e del 1831, con statua della Libertà di Marino Quartieri (1970). La chiesa fu costruita nel 1708-35 nell’area della gotica S. Matteo, su progetto di Giuseppe Antonio Torri con la collaborazione di Francesco Maria Angelini. L’imponente facciata è a edicola, a ordine unico di lesene che reggono il frontone ricurvo con inscritto un altro triangolare. L'interno è ad aula ellittica, più sviluppata nel senso longitudinale, con colonne binate giganti addossate ai pilastri angolari a sostegno della cupola ribassata; all’aula si agganciano i transetti, ciascuno con tre cappelle, e un profondo presbiterio, secondo una tipologia ancora tardo-manieristica, rispondente all’esigenza di un ambiente unitario per la predicazione. In alto, entro le nicchie tra colonna e colonna, gli Evangelisti, statue in gesso di Giuseppe Mazza; i soprastanti dipinti a monocromo con storie di S. Domenico sono di Antonio Consetti. Transetto destro: all’altare sinistro, S. Tommaso d’Aquino di Giambettino Cignaroli; all’altare destro, Martirio di S. Pietro di Francesco Monti. Nell’abside, Re David che suona l’arpa di Ignaz Stern. Transetto sinistro: all’altare destro, S. Pio V di Francesco Vellani (1745); all’altare sinistro, S. Vincenzo Ferreri di Giacomo Zoboli. Nel battistero, a sinistra dell’ingresso, gruppo plastico di Antonio Begarelli riproducente Gesù nella casa di Marta e Maria, gli apostoli Pietro e Andrea e due donne.
-
Istituto di Istruzione superiore «Adolfo Venturi»
Modena (MO)
Accanto alla chiesa di S. Domenico, in un’ala originariamente appartenente al convento dei Domenicani (attualmente disabitato), è la sede storica dell’Istituto di Istruzione superiore «Adolfo Venturi» (la direzione e parte delle aule sono state trasferite in via dei Servi). Già Accademia Atestina, istituita da Ercole III d’Este nel 1786, e ancor prima del tribunale dell’Inquisizione. Il riuso nella seconda metà del Settecento ne comportò la trasformazione tra gusto barocchetto e principi neoclassici; il prospetto porticato, ordito da lesene e concluso da frontone, spetta a Giuseppe Maria Soli (1786), mentre la statua di Saturno collocata di fronte, entro una raffinata ringhiera di G.B. Malagoli, è opera cinquecentesca proveniente dalla villa d’Este di Tìvoli. All’interno ospita la Galleria delle statue riallestita nel 2010, ricca collezione di calchi e copie di sculture antiche, eseguite dagli allievi dell’Accademia Atestina, e di opere realizzate ex novo dagli stessi.
-
Archivio di Stato
Modena (MO)
Nell'ex convento di S. Domenico, l’ala corrispondente a via Cavour accoglieva in periodo napoleonico la Prefettura dipartimentale del Panaro. Risalgono a quell’epoca gli adattamenti architettonici del prospetto e dell’atrio, l’imponente scala a forbice di gusto neoclassico e le decorazioni ad affresco, tra le quali una Gloria di Napoleone (nella sala di consultazione) e alcune allegorie (nella sala della direzione) di Geminiano Vincenzi. Con la Restaurazione ospitò uffici governativi e dal 1862 l’Archivio segreto estense. Attualmente è sede dell’Archivio di Stato, tra i più importanti d’Italia per la ricchezza e continuità cronologica dei documenti estensi (dall’VIII al XVIII secolo), occasionalmente esposti in mostre temporanee. Possiede inoltre carte del periodo napoleonico, tra le quali gli archivi delle istituzioni soppresse, l’archivio austro-estense (dal 1814 al 1859), documenti successivi all’Unità e archivi di famiglie locali. Vi è annessa una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica.
-
S. Maria degli Angeli
Modena (MO)
La chiesa di S. Maria degli Angeli, detta del Paradiso, fu eretta nel 1596 su disegno di Giovanni Guerra come prima sede dell’ordine teatino. La facciata, d’impronta tardo-manieristica ben rappresentativa della cultura del tempo, è modellata da un ordine di lesene giganti e da un complesso gioco di timpani spezzati e sovrapposti. Anche l’interno, a navata unica con sei cappelle, ampio transetto e coro semicircolare, si conforma sul tipico schema chiesastico controriformistico. La prima metà della copertura è a cassettoni lignei, dipinti da Camillo Gavassetti (1620); i rosoni a fogliami in rilievo sono attribuiti a Marco Meloni. Al 1° altare destro, i Ss. Gioacchino e Anna di Pietro Paolo Abbate; al 4°, S. Giovanni in estasi di Michele Desubleo, in ricca ancona di legno dorato; al corrispondente altare di sinistra, sempre entro ancona lignea, S. Teresa tra i Ss. Giuseppe e Paolo di Giacinto Garofalini; nel pilastro dell’arcone tra questo altare e il 3°, un bassorilievo in marmo, Madonna in trono col Bambino, di arte bolognese del secolo XIV; al 1°, Annunciazione di Ercole dell’Abate.
-
Corso Cavour
Modena (MO)
Il rettifilo del corso Cavour (l’antica Terranova) risale all’operazione di urbanizzazione cinquecentesca nota come «addizione Erculea». Lungo il suo tratto di destra, all’altezza della fronte posteriore del Palazzo ducale che avanza con due ali sporgenti, il corso è sovrappassato da un ottocentesco cavalcavia di collegamento con la caserma Montecuccoli. Lungo il tratto di sinistra, invece, che si concludeva visivamente con la scomparsa rotonda della cittadella, prosegue il complesso dell’ex convento di S. Domenico, dove, al N. 21, ha sede l'Archivio di Stato. Sull’altro fronte del corso Cavour sorge invece la chiesa di S. Maria degli Angeli.
-
Palazzo Boschetti
Modena (MO)
Palazzo Boschetti, già Galliani (secolo XVII), riqualificato attorno al 1740; ha impianto a U aperto sull’amplissimo giardino con peschiera, ghiacciaia e serra (secolo XIX), e interno affrescato da Francesco Vellani con allegorie entro quadrature di Giuseppe Dallamano.
-
Corso Vittorio Emanuele II
Modena (MO)
Antico corso Estense, storico asse di uscita verso nord attraverso la distrutta porta Castello, nonché collegamento con l’antico sistema di navigazione fluviale. Il percorso, attrezzato dal 1639 con la darsena, struttura di servizio per i natanti ornata di marmi da Gaspare Vigarani, ebbe fin dall’origine una connotazione aristocratica per la prossimità al quartiere ducale e per la funzione di nesso viario con la suburbana villa estense delle Pentetorri (distrutta da un bombardamento nel 1944), eretta sempre dal Vigarani nel 1652 per Francesco I e affrescata da Jean Boulanger e allievi. Chiusa la darsena nel 1858, con la successiva costruzione della stazione delle Ferrovie dello Stato il corso acquistò un nuovo e pur sempre significativo ruolo urbanistico, assumendo l’aspetto di un boulevard. Introduce nel corso, sul lato destro, il prospetto della chiesa della Visitazione (ora cappella dell’Accademia militare), fondata nel 1660, con l’attiguo monastero delle Salesiane (attuale caserma Montecuccoli), dalla duchessa Laura Martinozzi, su disegno di Gaspare Vigarani che ne ritagliò l’area dai giardini ducali. Poche residue sopravvivenze ricordano l’originaria destinazione residenziale nobiliare. Al N. 41, il palazzo Boschetti, già Galliani. Al N. 59, il palazzo d’Aragona, poi Coccapani, oggi sede dell’Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti.
-
Palazzo d’Aragona
Modena (MO)
Palazzo d’Aragona, poi Coccapani, fu costruito per il segretario ducale Rocco Lorenzotti dal 1683 e compiuto nel 1776; all’interno, un seicentesco scalone affrescato con divinità mitologiche da Ludovico Bosellini (1780 circa) conduce all’appartamento nobile, con stucchi rococò e dipinti. Vi ha sede l’Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti, fondata nel 1583 dal marchese Bonifacio Rangoni come Accademia dei Dissonanti. Tra i suoi membri annoverò Ludovico Antonio Muratori, Lazzaro Spallanzani, Antonio Scarpa, Girolamo Tiraboschi. Possiede una biblioteca di 130.000 volumi, una collezione di epistolari, una raccolta numismatica di oltre 6.000 pezzi dall’epoca romana al XIX secolo.
-
Tempio monumentale
Modena (MO)
Costruito a partire dal 1923 da Domenico Barbanti e Achille Casanova in memoria dei caduti della prima guerra mondiale. La sua architettura è il prodotto di un revival eclettico che nella grandiosa cupola emisferica fra quattro torri cupolate si ispira alla basilica antoniana di Padova, mentre nei loggiati, nel rosone e nel portale con protiro riprende citazioni dal romanico e dal gotico padani, e infine nell’impianto a croce greca, con absidi raccordate da corpi quadrangolari, ricorda esempi altomedievali. All’interno (il tempio è dedicato a S. Giuseppe) nella cupola e nelle calotte absidali è riprodotto il motivo gotico dei costoloni. Le acquasantiere all’ingresso sono ricavate da due massi del monte Grappa. Subito a destra, la cappella funeraria dell’arcivescovo Natale Bruni, ideatore e maggior oblatore per la costruzione del tempio, con medaglione marmoreo del defunto di Giuseppe Graziosi. Nella cripta, i nomi dei 7.300 caduti della provincia di Modena.
-
Museo Casa Enzo Ferrari
Modena (MO)
Inaugurato nel 2012, è costituito da due edifici: il primo è la casa dove nacque Enzo Ferrari (1898-1988), mentre il secondo è una prestigiosa opera di architettura contemporanea, il cosiddetto cofano giallo che porta la firma dello Studio Future Systems di Londra dell’architetto ceco Jan Kaplicky. L’interior design e la direzione artistica sono stati invece curati dall’architetto Andrea Morgante di Shiro Studio, co-progettista dell’opera. La grande facciata vetrata si ispira alla griglia frontale delle auto mentre la copertura, in doghe d’alluminio doppiamente curvato verniciato in giallo (il colore fa riferimento al colore dello sfondo del marchio Ferrari) ricorda un cofano con aperture simili a prese d’aria. La casa natale ospita, accostando tradizione e modernità con un accattivante allestimento multimediale, i ricordi della vita di Enzo Ferrari e della nascita della casa automobilistica. Il padiglione giallo espone le automobili più significative del Cavallino Rampante, affiancato dall’officina del padre di Enzo perfettamente restaurata, e dal Museo dei Motori Ferrari.
-
Giardino Ducale Estense
Modena (MO)
Giardini pubblici, già ducali, recinti da un’inferriata di G.B. Malagoli (1771). Subito di fronte all'ingresso, il monumento a Nicola Fabrizi di Francesco Fasce (1896). Il percorso sinuoso dei viali conduce alla Palazzina ducale, o dei Giardini, eretta fra il 1632 e il ’34 da Gaspare Vigarani su idee di Girolamo Rainaldi e Bartolomeo Avanzini e posta in relazione scenografica con la prospettiva del corso Canal Grande; ampliata con due ali a esedra da Pietro Bezzi nel 1750 circa e arricchita di busti d’imperatori, fu teatro di feste, poi adibita a serra e, dal 1980, è sede di mostre d’arte moderna curate dalla Fondazione Modena Arti visive. Più avanti si stende l’Orto botanico dell’Università di Modena, istituito nel 1758 da Francesco III per la «dimostrazione delle piante medicinali».
-
Museo della Figurina
Modena (MO)
È la più ricca e varia collezione del genere esistente al mondo, frutto della passione di Giuseppe Panini, fondatore delle omonime edizioni. La raccolta di maggior valore è costituita dalle oltre 50.000 figurine Liebig. Molti gli esemplari francesi (figurine dei magazzini Au bon marché di Parigi) e inglesi (Cigarettes Cards del 1879), oltre alle figurine Panini con i divi del cinema e i campioni dello sport.
-
Palazzo Santa Margherita
Modena (MO)
Eretto su disegno di Francesco Vandelli (1830) nelle forme della Restaurazione. Il palazzo è sede della Fondazione Modena Arti Visive, che gestisce le collezioni di fotografia storica e contemporanea, italiana e internazionale, le raccolte del disegno (opere su carta di artisti italiani del Novecento (come Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Alighiero Boetti, Giuseppe Penone, Carla Accardi), entrambe della Galleria civica del Comune di Modena, e il Museo della Figurina. Il complesso del palazzo di S. Margherita, che ingloba l’antico convento dei Minori Francescani e la chiesa di S. Margherita di Pasio Pasi e G.B. Codebue (fine XVI secolo), dal 1874 divenne sede del Patronato dei Figli del Popolo e accoglie anche la biblioteca civica «Antonio Delfini» e l’Istituto superiore Musicale «Vecchi Tonelli».
-
Teatro comunale Luciano Pavarotti
Modena (MO)
Edificio classicistico di Francesco Vandelli (1841), con prospetto porticato, a sostegno della balconata; confermano lo stile ‘Restaurazione’ dell’architettura i rilievi (scene del teatro classico) e le statue del fastigio, tutti di Luigi Righi. La sala ellittica, con quattro ordini di palchi, ha la volta dipinta da Ferdinando Manzini (1869).
-
Palazzo Calori Cesi
Modena (MO)
Palazzo nobiliare con atrio colonnato adorno di ferri battuti di G.B. Malagoli, dal quale si dipartono, a destra, un sistema di scalette gemelle e, a sinistra, un monumentale scalone di Andrea Tarabusi, decorato di stucchi e prospettive dipinte di Ludovico Bosellini (1780 c.).
-
Palazzo Sabbatini
Modena (MO)
Palazzo nobiliare che nel cortile presenta le statue dei fiumi Secchia e Panaro tra arbusti in ferro battuto, virtuosistica prova del Malagoli; lo scalone barocchetto è affrescato nella volta con l’Apoteosi della casa Sabbatini di Francesco Vellani (1740 circa), pure autore della decorazione con Giove, Marte e Minerva nella sala all’ultimo piano.
-
S. Vincenzo
Modena (MO)
Costruita da quell’ordine nel 1617, sull’esempio della romana S. Andrea della Valle. Direttore del cantiere fu il padre Bernardo Castagnini; la facciata, più tarda (1760-61), a due ordini di lesene con colonne addossate, timpano e statue, spetta a Gaspare Paoletti. L’interno, a unica navata con sei cappelle laterali, largo transetto e vasta abside semicircolare, erge una cupola ribassata all’incrocio dei bracci (zona absidale e cupola, bombardate nel 1944, sono state rifatte). Le volte e le pareti sono ricoperte da una fastosa decorazione a stucchi e ad affresco, opera di Sebastiano Sansone e Sigismondo Caula. La documentata partecipazione al cantiere di Bartolomeo Avanzini e Guarino Guarini è individuabile nei coretti, nelle sottostanti finestre e nei capitelli della navata. Fulcro ideale e prospettico dello scenografico spazio è il tabernacolo in marmo a forma di tempietto di Tommaso Loraghi su progetto di Bartolomeo Avanzini (1650 circa), voluto da Isabella di Savoia d’Este, qui sepolta; ai suoi ascendenti alludono le statue ai lati, S. Contardo d’Este e il Beato Amedeo di Savoia, di Giovanni Lazzoni (1660). Dall’Ottocento il tempio acquisì il ruolo di pantheon ducale e in conseguenza fu aggiunta la cappella mortuaria estense (accesso dalla sagrestia), su disegno di Francesco Vandelli, che accolse le salme di duchi e principi già tumulate altrove. In chiesa, altri monumenti funerari della Restaurazione (nella cappellina a sinistra del presbiterio, quello del principe Ferdinando figlio di Francesco IV, morto nel 1849, di Paolo Aleotti); inoltre, nella 2a cappella sinistra, Deposizione di Cristo di Matteo Rosselli (1629); nella 1a, Madonna, S. Gregorio e S. Giovanni, notevole opera del Guercino, commissionata nel 1630; l’opera, trafugata nel 2014, fu poi ritrovata e ricollocata al suo posto.
-
Corso Canal Grande
Modena (MO)
Ampia elegante strada perpendicolare alla via Emilia, definita da quinte di palazzi dalla facies prevalentemente sei-settecentesca; aperta a seguito della copertura (secolo XVI) del canale che ne costituisce ancora il tracciato, rappresentò un’arteria di urbanizzazione residenziale elitaria, come è testimoniato dal carattere colto che contraddistingue gran parte del suo tessuto edilizio. Ne è saggio il palazzo Schedoni, ora hotel Canalgrande (N. 6), ex convento dei Rocchettini adattato, nel 1790, da Giuseppe Maria Soli. Contigua è la chiesa di S. Maria delle Assi o della Trinità. Altri cospicui episodi residenziali sono, al N. 21, il neo-rinascimentale palazzo Valenti di Vincenzo Maestri, al N. 20 la casa Seghizzi (secolo XVI), infondatamente ascritta al Vignola, al N. 27 il palazzo Bortolani, dal suggestivo giardino ottocentesco, e al N. 30 l’imponente palazzo del principe Foresto. Lungo il tratto settentrionale del corso Canal Grande, che arriva fino ai Giardini pubblici, si fronteggiano la neoclassica ala orientale del Palazzo ducale, dovuta a Giuseppe Maria Soli, e le scuderie dell’Accademia militare, già ducali, progettate da Bartolomeo Avanzini (1650 c.), con abbellimenti di fine Settecento. Lungo il lato destro del corso, si alza poi il classicistico prospetto del palazzo di S. Margherita, eretto su disegno di Francesco Vandelli (1830) nelle forme della Restaurazione. Altro edificio classicistico di Vandelli è il vicino Teatro comunale «Luciano Pavarotti», di fronte al quale si allinea una bella sequenza di palazzi nobiliari, tra i quali al N. 90 la casa di Ciro Menotti, al N. 88 il palazzo già dei conti Calori Cesi, al N. 84, il palazzo Boschetti, fronteggiato dal palazzo Sabbatini. A poca distanza, il palazzo del Tribunale e la chiesa di S. Vincenzo.