In collaborazione con 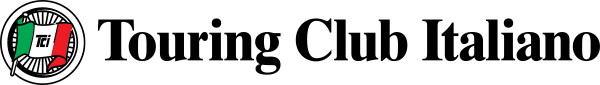
L'ambiente e la storia
Di formazione recente, creatosi per alterni fenomeni di sollevamento e abbassamento, il territorio della provincia di Ferrara è costituito per metà circa della sua estensione, a oriente, dal vasto piano delle «terre nuove» di bonifica (basso Ferrarese), poste in notevole parte quasi a livello del mare Adriatico o sotto il suo livello e prosciugate con il sollevamento meccanico delle acque; e per un’altra metà, a occidente, dalla piattaforma delle «terre vecchie», da più remota età emerse dalle acque e abitate.
Oltre le «terre nuove», conquistate dalla bonifica negli ultimi cinque secoli e dove restano alcuni residui dell’originario ambiente lagunare (Valli di Comacchio, Valle Bertuzzi eccetera), si stende con mutevole larghezza una fascia litoranea di terreni sabbiosi, lungo la quale i cordoni delle dune (in parte distrutti dagli insediamenti del XX secolo) si dispongono a guisa di lunghi, inarcati pennacchi e consentono di ravvisare le fasi del processo di deltazione della fiumana padana dall’epoca etrusca all’età moderna.
Gli insediamenti
La prima consistente memoria storica di insediamento umano stabile e complesso è stata la città di Spina. Siamo alla fine del VI secolo a.C., e il ramo principale del Po è allora quel corso fluviale il cui alveo fossile si riconosce tra il Volano e il Primaro da Ferrara a Comacchio (Padus Vetus, cioè Po Vecchio). Già nel I secolo a.C. Spina appariva relegata nell’entroterra dal protendersi verso sud-est della foce del Po, lontana una decina di chilometri dalla costa.
Sempre in età romana, crescenti problemi di accesso al mare indirizzarono i traffici verso Ravenna, cui, per iniziativa di Ottaviano Augusto, si collegò più direttamente il Padus Vetus con l’escavazione (o la sistemazione da una vena naturale) di un canale lungo una trentina di chilometri: la fossa Augusta, la prima di una serie di vie d’acqua artificiali trasversali al Po.
Frattanto, nella zona di Spina gli insediamenti lentamente sparirono per l’esaurirsi del Padus Vetus e il predominare di altri vicini rami del Po: in età romana il Volano, dopo il secolo VII il Primaro. In tale ambiente, a poca distanza dal principale ramo di Volano sorse, con ogni probabilità nel secolo VII, l’abbazia di Pomposa, che non fu solo centro di cultura e spiritualità, ma anche polo promotore di bonifica e di buona gestione dei patrimoni boschivi.
ùLa posizione di Ferrara al nodo di importanti vie d’acqua – il Po di Volano e di Primaro – aveva consentito, dopo il secolo X, che la città diventasse a poco a poco il luogo di transito più naturale e facile tra le zone interne della pianura padana e il mare Adriatico.
Ma già a partire dal Trecento, con un processo che culminerà nel XVI secolo, gli effetti della diversione del Po, avvenuta due secoli prima a Ficarolo, indebolirono e poi impedirono la funzione navigatoria e commerciale della città, che da emporio dei traffici fluviali dovette convertirsi a centro di gestioni e produzioni agricole e quindi conquistare gradatamente le sue difficili campagne.
In questo territorio transita un segmento della Via Romea Germanica, che ripercorre il viaggio affrontato dal monaco Alberto di Stade nel 1236 verso Roma e minuziosamente trascritto nel suo diario di viaggio. La Via Romea Germanica parte da Augusta (Baviera) e, passando per Trento e Padova, sede della Basilica del Santo, entra in Emilia-Romagna attraverso la pianura padana dove tocca Ferrara. Da qui giunge all’abbazia di Pomposa e a Ravenna. Ai piedi dei rilievi appenninici il percorso romeo si inerpica verso Bagno di Romagna e il passo Serra, attraversando il Parco delle Foreste Casentinesi e ridiscende poi verso la Toscana alla volta di Roma.
Questa via è uno dei 20 cammini promossi dalla Regione Emilia-Romagna.
Un altro dei cammini a tema religioso, la Viae Misericordiae, parte dall’abbazia di Pomposa, tocca Bagnacavallo e Modigliana e termina a Faenza dopo 225 km. Tra il 1450 e il 1470 Borso d’Este inizia i lavori di prosciugamento nel Polésine di Casaglia, cui seguirà quarant’anni dopo la bonifica della grande tenuta della Diamantina.
E negli anni di Alfonso II (1559-97) si lavora già con uno spirito capitalista nella bonifica del Polésine di Ferrara (la cosiddetta «Grande Bonificazione»), che coinvolse importanti esponenti della scienza idraulica, fra cui G.B. Aleotti.
L’apertura della città al contado ha come ulteriore effetto la costruzione di residenze campestri (le ‘delizie’) tipiche del periodo degli Este: oltre che altamente rappresentative della loro forza, i signori le vogliono al più possibile adorne di arte e di bellezza naturale; la corte vi svolge attività ricreative e di divertimento, passando dalle gare sportive ai giochi, agli intrattenimenti intellettuali. Il declino della Grande Bonificazione.
Quando il ducato di Ferrara passò sotto la diretta dominazione della Chiesa (1598), iniziò anche il declino della Grande Bonificazione.
Declino determinato – a parte le inevitabili imperfezioni e insufficienze tecniche – da mancate opere di manutenzione. Ma insieme, o soprattutto, dalla diversione del ramo principale del Po compiuta dai Veneziani tra il 1599 e il 1604 («taglio di Porto Viro»). Per evitare l’intasamento della loro laguna i Veneti condussero l’estremo corso del fiume in direzione sud-est; dopo questo intervento le alluvioni deltizie cominciarono a depositarsi in direzione meridionale, vanificando completamente gli impianti che la bonifica aveva costruito. Inizia così nel territorio di Ferrara il sopravvento delle forze fluviali che, non più disciplinato, culminerà agli inizi del XVIII secolo con una delle più spaventose alluvioni che la Bassa Padana abbia mai conosciuto. Gli anni francesi alimentarono un ritorno a provvedimenti di riassetto idrico (allora fu realizzato il cavo Napoleonico per lo scarico del Reno in Po), ma fu solo nella seconda metà dell’Ottocento che le macchine idrovore a vapore mutarono completamente il paesaggio della pianura ferrarese.
Le bonifiche del Novecento
L’ultima pagina di questo processo bonificatorio è costituita dal prosciugamento, molto discusso, della Valle del Mezzano (la parte occidentale delle Valli di Comacchio), attuata nel 1962-65. Sui risultati complessivi di questa operazione oggi però è necessario sottolineare criteri di valutazione differenti: tra quelli emersi vi sono terreni adatti alla coltivazione (terre del vecchio Polésine di S. Giorgio e di Ferrara) e altri (ex Valle del Mezzano) che per loro natura non lo sono affatto.
L’esperienza di tali bonifiche ha insegnato che una gestione intelligente del patrimonio ambientale non può travalicare funzioni e vocazioni gradatamente entrate nella storia come insopprimibili caratteri naturali.
Parco regionale del Delta del Po
Della conquista di una cultura di tutela del territorio è prova l’istituzione da parte della Regione Emilia-Romagna del Parco regionale del Delta del Po.
Comprende, oltre al Delta emiliano attuale e al Delta storico (steso a mezzogiorno fino alla foce attuale del Reno), anche le aree pinetali e le paludi d’acqua dolce che un tempo cingevano interamente Ravenna; i circa 52 mila ettari – parte in provincia di Ferrara, parte in quella di Ravenna – sono suddivisi in sei stazioni, coincidenti con le zone dove i diversi ambienti naturali, che un tempo componevano l’intero paesaggio dell’area deltizia, hanno resistito in condizioni di buona conservazione: esse sono, procedendo da N a S, Volano Mésola-Goro, centro storico di Comacchio, Valli di Comacchio, Campotto di Argenta, pineta di S. Vitale e piallasse di Ravenna, pineta di Classe e salina di Cervia. Nell’attesa dell’auspicato Parco nazionale del Delta del Po, l’area deltizia rimane divisa tra la zona veneta e quella emiliana, che gestiscono in collaborazione il territorio protetto ( area emiliano-romagnola - area veneta).
L’Unesco
Dal 1999 tutte le ville di delizia estensi, di cui questo territorio è ricco, fanno parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, insieme a Ferrara, città del Rinascimento (dal 1995), e al Delta del Po.
È anche Riserva MAB (Man and the Biosphere) dell’Unesco la spettacolare zona in cui il Po si divide tante lingue di acqua, prima di gettarsi in mare, creando un paesaggio di dune, lagune, pinete, zone umide salmastre, dove vivono 360 specie di uccelli come l’airone viola e 10 000 fenicotteri rosa.