In collaborazione con 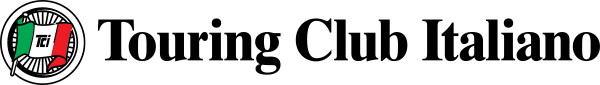
L'ambiente e la storia
L’Appennino bolognese comprende i bacini idrografici del F. Reno e dei suoi affluenti Silla e Setta, dei torrenti Sàvena, Zena e Ìdice e, per il piccolo tratto della valle del Dardagna, del F. Panaro.
Le valli costituiscono itinerari geologici privilegiati, consentendo l’attraversamento delle strutture e dei corpi principali, con prospettive molteplici e variegate; sono servite ciascuna da una strada (talora da due sui fianchi opposti) che corre sul fondovalle, come è il caso della Porrettana, a mezza costa, utilizzando i terrazzi fluviali che offrono tratti più o meno pianeggianti, oppure in crinale come, per un buon tratto, la statale della Futa.
I terrazzi naturali, visibili dall’alto dei versanti, testimoniano le trasformazioni subite dall’idrografia del territorio: individuabili come spianate di fondovalle, direttamente incombenti sull’alveo dei corsi d’acqua e disegnati da un’ordinata geometria di campi e strade, oppure come ripiani sospesi a mezzacosta a vari livelli, sono i residui più o meno estesi di paleoalvei, portati all’altitudine odierna dal sollevamento della montagna o dall’abbassamento del livello del mare, e incisi dal fiume, costretto a scavarsi un nuovo corso incassato tra ripide sponde. Il sistema orografico bolognese, mentre sfuma a ovest in quello modenese, ha un limite naturale molto netto a est lungo la valle del Sìllaro, dove passa una delle grandi linee che segmentano trasversalmente la catena appenninica, separando due zone a struttura e paesaggio diversi.
Verso sud lo spartiacque con la montagna toscana segue un andamento molto frastagliato, dal Corno alle Scale alla fonte del Reno, vicinissima a Pistoia, al passo della Collina, ai monti sovrastanti i bacini di Suviana e Brasimone, e Castiglione dei Pèpoli, infine ai passi della Raticosa e della Futa.
La struttura geologica è quasi interamente costituita da un unico grande corpo, benché articolato: il cosiddetto «complesso Liguride», ovvero le ‘argille scagliose’ dei vecchi autori, un mosaico di varie formazioni, prevalentemente argillose, suddivise in scaglie minute da numerosi e fitti piani di taglio, di origine alloctona, provenienti da un’area che coincide approssimativamente con quella dell’attuale Mar Ligure.
A causa del sommovimento da cui hanno tratto origine e degli stress subiti, le formazioni liguridi si sono accatastate e smembrate, rompendosi quelle più dure in pezzi di varie dimensioni, e franando lungo i versanti quelle argillose, plastiche. Ne deriva che il loro aspetto corrente è quello definito ‘caotico’, una sorta di impasto irregolare di blocchi di roccia entro una massa plastica priva di stratificazione e dall’aspetto franoso, come si può osservare soprattutto a sud-ovest di Bologna, e nelle valli dell’Ìdice e del Sìllaro.
Gli scogli di rocce dure, che evitano lo sfasciume geologico delle ‘argille scagliose’, svettano sul paesaggio come montagne isolate e sono costituiti da strutture cristalline, più o meno alterate in serpentine screziate di verde (dette anche pietre verdi o ofioliti), o da formazioni sedimentarie di assetto più tabulare e stratificato, composte per lo più di arenarie, calcari e marne.
La zona collinare ha un aspetto più regolare rispetto all’area del complesso Liguride ed è occupata da argille stratificate, il cui colore azzurro si nota in molti affioramenti calanchivi tra Pianoro, Sabbiuno, Pieve del Pino e palazzo Rossi.
A ridosso immediato della città, si è invece in presenza di marne biancastre mioceniche e di gessi dai caratteristici cristalli a ferro di lancia (selenite), all’interno dei quali si determinano forme carsiche superficiali (doline, inghiottitoi) e sotterranee (le grotte di Farneto e della Spìpola). Le cave, che hanno storicamente sfruttato il materiale gessoso soprattutto per l’attività edilizia, sono state chiuse per l’impatto ambientale negativo causato dal loro sviluppo su scala industriale, ed è stato istituito, su una superficie di 4815 ettari, il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
L’umanizzazione dell’Appennino bolognese si delineò, forse con più alta densità rispetto alle altre zone montane della regione, fin dall’età del Bronzo.
Prima della conquista romana, risulta abitato da popolazioni di stirpe ligure, fra le quali si inserì, nel corso del VI sec., la penetrazione etrusca, che si spinse verso la pianura padana lungo la valle del Reno.
L’occupazione romana fu decisamente meno capillare che in pianura: essa si limitò a controllare, dopo averle vinte, le popolazioni indigene, facendo inoltre confluire nell’area appenninica le genti celtiche superstiti, espulse dalla pianura, e riutilizzò, in larga misura, il reticolo viario preesistente.
Lungo tali direttrici è stato individuato, con sufficiente approssimazione, il tracciato di un itinerario stradale: la cosiddetta Flaminia minor, risalente al II sec. a.C., che correva lungo la dorsale tra le valli dell’Ìdice e del Sìllaro e congiungeva l’area etrusca alla romana Claterna sulla Via Aemilia. All’indomani del crollo imperiale, rapida fu la disgregazione politica della montagna bolognese, tagliata trasversalmente, a partire dal VI sec., dalla mobile linea di confine tra territori longobardi e bizantini; solo dopo la conquista franca, vi iniziarono a emergere alcuni centri feudali, consolidatisi nel IX sec., quali Monteveglio e Pànico nell’area collinare, e i feudi degli Alberti e degli Ubaldini nella parte alta delle valli o sui fianchi della dorsale peninsulare.
La viabilità medievale, per il collegamento di Bologna e Firenze, seguiva due direttrici fondamentali, lungo le vallate del Reno e del Sàvena.
La prima era articolata in due tracciati, disposti in altitudine su ambo i fianchi della valle. La seconda aveva il suo centro principale a Brento, sotto il M. Adone, proseguiva per Monzuno, aggirava il M. Bastione alle sorgenti del Sàvena e valicava la catena appenninica in corrispondenza del passo della Futa. Distrutto Brento e decaduto Monzuno, si affermò la strada lungo il crinale destro, che seguiva di massima l’attuale percorso della statale della Futa.
Dei 20 cammini promossi dalla Regione Emilia-Romagna tre sono sull'Appennino bolognese.
La Via della Lana e della Seta collega Bologna, nel Medioevo capitale della seta, e Prato, capitale della lana e del tessile: 130 km di cui 69 in regione, tra Bologna e Castiglione dei Pèpoli.
Un suggestivo percorso attrezzato, accessibile a tutti, è la Via degli Dei, che risale a epoca pre-romana; sono 67 km da Bologna a Monte di Fò, 123 per arrivare a Firenze.
La Via Mater Dei è il cammino che unisce alcuni fra i tanti santuari mariani presenti sull’Appennino bolognese; varcato il confine regionale, scende in Toscana dopo 157 km, dei quali 146 in Emilia.
La rinascita delle città, accompagnata dalla crescita dell’istituzione comunale, aprì, dopo il XII sec., una fase di conquista dell’Appennino da parte dei centri della pianura bolognese e del bacino interno toscano, che si concluse, dopo asprissime lotte, con l’affermarsi nel XIV sec., sull’intero territorio montano, della dominazione di Bologna e di Firenze.
Il Comune bolognese, in particolare, riuscì a travolgere, nella fascia collinare, l’originale sistema della proprietà contadina locale, sostituendolo con la gestione mezzadrile, al contrario di quanto avvenne nelle valli alte e lungo la dorsale appenninica, dove resistette, fino al XIX sec., la struttura autoctona, basata sull’articolazione politica e familiare in clan gentilizi, che raggiunse un elevato livello qualitativo nel governo del territorio e nelle forme di espressione della cultura popolare.
L’incremento demografico dell’area montana ebbe il suo culmine nel XVIII sec., ma già a partire dai secoli precedenti, per riequilibrare una densità di popolazione che nelle frequenti crisi alimentari si era rivelata eccessiva, si manifestarono flussi migratori stagionali verso la pianura, divenuti in seguito regolari e stabili. Una spinta decisiva a questa mobilità demografica, che nel giro di due secoli ha determinato vasti processi di popolamento, è stata data dalla realizzazione delle grandi vie di comunicazione interregionali: a cominciare dalla carrozzabile del valico della Futa (aperta tra il 1749 e il 1753 nella parte pertinente al Granducato toscano, e nel 1759-60 nel tratto in territorio pontificio), seguita, un secolo dopo, dalla nuova strada Porrettana sul fondovalle del Reno e dalla costruzione, tra il 1856 e il 1864, della ferrovia transappenninica lungo la stessa vallata, capolavoro di ingegneria ottocentesca, che valorizzò il centro termale di Porretta.
La viabilità appenninica è stata ulteriormente potenziata con la messa in funzione nel 1934 (accompagnata dalla creazione di alcuni bacini idroelettrici) della ferrovia ‘direttissima’ Bologna-Firenze, affiancata, dal 2009, dal corrispondente tratto della ferrovia Alta Velocità.
Analogamente, il tronco transappenninico dell’autostrada del Sole, aperto nel 1960, è stato sdoppiato grazie alla costruzione della Variante di valico, aperta nel 2015. Questo sviluppo ha favorito una discreta penetrazione, lungo gli assi di fondovalle della fascia collinare, di impianti industriali, e la fioritura di centri turistici sui versanti ancora boscati oltre gli 800 m.