In collaborazione con 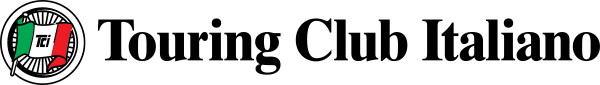
L’itinerario risale all’andata il fiume Montone, sulla statale 67 Tosco Romagnola; per il ritorno a Forlì da Premilcuore la 9 ter del Rabbi discende la valle del fiume Rabbi.
Il paesaggio della fascia collinare alterna alle case coloniche e alle colture promiscue le strutture dell’agricoltura e della zootecnia (allevamenti avicoli e suinicoli) su scala industriale.
Dei due centri di Terra del Sole e Castrocaro Terme, l’uno è raro esempio di cittadella fortificata cinquecentesca, mentre l’altro presenta una tipologia ricorrente di borgo medievale.
Il fiume Montone (circa 80 km di corso, circa 530 km2 di bacino) nasce dall’Alpe di S. Benedetto, presso il passo del Muraglione, e scende con direzione nord-est toccando Rocca San Casciano e Castrocaro Terme.
In pianura, dopo un tratto arginato, scorre insieme al fiume Ronco nell’alveo dei Fiumi Uniti, canalizzato nel 1733-38 per circa 9 km, con foce in mare a S di Lido Adriano.
In corrispondenza dello sbocco in pianura, alle porte di Forlì, riceve da destra il fiume Rabbi (circa 220 km2 di bacino), i cui rami sorgentizi nascono anch’essi dall’Alpe di S. Benedetto.
-
Lunghezza117,6 km
-
Chiesa dei Romiti
Forlì (FC)
Chiesa dei Romiti (o S. Maria del Voto), ricostruita in forme romanicheggianti da Leonida Emilio Rosetti nel 1926; preceduta da portichetto, ha nella 1a cappella destra una Visitazione di Pier Paolo Menzocchi (1576) e nel presbiterio quattro santi, probabilmente frammenti di un polittico di Livio Modigliani.
-
Villa Saffi
Forlì (FC)
Casa-museo con parco dove nel 1890 morì Aurelio Saffi (acquistata dal Comune di Forlì, è oggi visitabile). Il complesso, originariamente convento gesuitico, è composto da un edificio principale, adibito in parte a casa padronale e in parte a residenza del custode, da una casa colonica ora in disuso e da un edificio di servizio impiegato come rimessa. Era annesso a un vasto fondo agricolo acquistato dal conte Tommaso Saffi, nonno di Aurelio. La villa era usata come residenza solo nei periodi estivi e al tempo del conte Pietro, zio di Aurelio, fu sede di riunioni carbonare e indicata in linguaggio cifrato come «Vendita dell’Amaranto». Aurelio Saffi e la sua consorte Giorgina Craufurd dal 1867 elessero l’edificio ad abitazione stabile per la loro famiglia, animata dalla presenza di quattro figli maschi. La villa racchiude volumi, memorie storiche della famiglia Saffi, cimeli di Giuseppe Mazzini, arredi e mobili d’epoca, tra cui esemplari significativi di manifattura inglese e in stile Impero. Tra gli ambienti più suggestivi il salone principale, lo studio di Aurelio Saffi, la cucina e la cosiddetta sala del ping-pong, dipinta a trompe-l’oeil nel 1937 dal pittore Amerigo Bartoli Natinguerra. Sul prospetto principale sono visibili le tracce dell’originaria cappella conventuale e due epigrafi in memoria di Aurelio e di Giorgina. Il parco presenta varie specie di piante arboree ed arbustive, un maestoso cedro del Libano risalente al tempo del Triumviro e una suggestiva neviera al centro di un boschetto di querce.
-
Rocca di Monte Poggiolo
Forlì (FC)
Avamposto fiorentino ricostruito nel 1471 su disegno di Giuliano da Maiano, è a pianta quadrilatera, con torri cilindriche angolari abbastanza conservate.
-
Terra del Sole
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
A m 62, cittadella fortificata che Cosimo I de’ Medici fondò nel 1564 sul confine nord-est del proprio granducato. Conserva intatta la struttura originaria a pianta rettangolare (perimetro di m 2.087), con cinta muraria, quattro bastioni angolari, casematte e passaggi coperti. Ipotetica è l’identificazione del luogo come sede degli Umbri Solonates, dai quali sarebbe stato assunto il toponimo attuale che ha sostituito quello cinquecentesco di Eliopoli. Fu progettata da Baldassarre Lanci, architetto militare del granduca, coadiuvato da altri fra cui il Buontalenti, e sostanzialmente compiuta nel 1579. Rimasta sempre inattiva, venne disarmata nel 1774; nel 1894 vennero tagliate le mura per rendere più agevole il passaggio della strada, che in precedenza sottopassava le porte urbiche.
-
Piazza Garibaldi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Limpido spazio di misura rinascimentale, in cui si fronteggiano il palazzo Pretorio e la chiesa di S. Reparata. A sinistra di S. Reparata, le linee toscane del palazzo del Provveditore (sul cortile prospetta la seicentesca ex chiesa di S. Barbara, con facciata su via delle Mura); di fronte, il palazzo Pretorio.
-
S. Reparata
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Chiesa (1594-1605; il campanile fu completato con la cupola nel 1818), dal bell’interno a navata unica che conserva, del secolo XVI, un coro ligneo, un Crocifisso pure ligneo di scuola fiorentina e, al 2° altare sinistro, una Madonna del Carmine di Pier Paolo Menzocchi (1575). Al 1° altare destro, Crocifissione di scuola romagnola del ’600; al 2°, Madonna del Rosario di Francesco Longhi (1610).
-
Palazzo Pretorio o dei Commissari Granducali
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Palazzo con stemmi e portico a tre archi: costruito su disegno del Buontalenti e poi restaurato, ospita il Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, cui si accede dal cortile con doppio loggiato su tre lati.
-
Museo dell'Uomo e dell'Ambiente
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Ha sede nel palazzo Pretorio. La raccolta museale, recentemente rinnovata, si articola in 25 sale e due percorsi. Il primo, a carattere storico-architettonico, illustra l’origine e lo sviluppo della città fortezza. Il secondo, mirato agli aspetti etno-antropologici e territoriali, illustra la vita e il lavoro degli abitanti di queste zone attraverso la ricostruzione degli ambienti, le usanze, le credenze popolari, i giochi, gli eventi musicali, gli antichi mestieri, i lavori stagionali e il ciclo del grano e del vino. Le carceri criminali sono visitabili solo per ragioni di studio.
-
Castrocaro Terme
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
A m 68, sede del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ab. 6.301, e Bandiera Arancione del TCI. Moderno e frequentato centro d’acque, sviluppatosi intorno alle terme alla sinistra del Montone, conserva un nucleo medievale racchiuso da due cerchie fortificate e dominato dalla rocca. Il decollo turistico vi ha stimolato la promozione di manifestazioni (noto il Festival delle voci nuove per la canzone), nonché di sagre e di feste che in qualche caso si legano alle tradizioni agricole locali. Potrebbe essere l’antica Salsubium, mentre il nome attuale deriva da un forse altomedievale Castrum Carium di cui non è stata finora chiarita l’origine. Dominio degli arcivescovi di Ravenna, ebbe poi propri signori, per passare nel 1403 sotto Firenze che ne fece il capoluogo della Romagna toscana fino al 1579, quando la sede commissariale passò a Terra del Sole.
-
Ss. Nicolò e Francesco
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Parrocchiale con l’interno a tre navate. Nella 2a campata destra, Visitazione di Francesco Longhi, firmata e datata 1611; al 3° altare, Madonna dei Fiori, stucco policromo di scuola toscana del secolo XV. A destra dell’altare maggiore, Madonna con i Ss. Sebastiano e Rocco, affresco votivo di scuola romagnola del ’400; nell’abside, Madonna in trono e santi, bella pala di Marco Palmezzano, datata 1500, entro cornice originale. Sulla parete della navata sinistra, S. Sebastiano, affresco votivo riportato di fine ’400; nella 2a campata, Madonna del Carmine attribuita a Carlo Cignani. Notevole, nel tesoro, una croce processionale in argento dell’ambito del Ghiberti.
-
Voltone dell'Orologio
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Detto anche porta di S. Nicolò. Documentato nel 1371, è una delle due porte superstiti (delle quattro primitive) della cerchia muraria esterna che racchiude il borgo medievale.
-
Borgo medievale
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Vi si accede dalla via Garibaldi, sottopassando il voltone dell’Orologio, o porta di S. Nicolò: documentato nel 1371, è una delle due porte superstiti (delle quattro primitive) della cerchia muraria esterna che racchiude il borgo Medievale. In questo si trova la chiesa di S. Nicolò, che si ritiene risalga al secolo XI; di struttura tardo-gotica, possiede resti di affreschi del ’400. Poi, percorsa la via S. Antonio, il palazzo Pretorio, che incorpora la torre di difesa dell’adiacente porta di S. Francesco; il palazzo, ampliato nel 1541-42, fu dimora dei capitani di giustizia e dei commissari generali inviati da Firenze, ai quali appartengono gli stemmi in facciata, con eccezione di quello mediceo (1566) sopra l’ingresso. Si sale quindi fino alla cerchia fortificata interna, la Murata, oltrepassata la quale si trova a destra il battistero di S. Giovanni, antica costruzione a pianta circolare che custodisce un sarcofago bizantino. Poco sotto, la cilindrica torre dell’Orologio, rifatta dai Fiorentini nel XV secolo su una precedente. In alto, superata la porta della Postierla, munita di torrione e ponte levatoio è l’imponente Rocca.
-
Rocca
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
In alto nel borgo medievale, superata la porta della Postierla, munita di un torrione rotondo e merlato e del ponte levatoio è l’imponente Fortezza o Rocca, restaurata nel 1999 e adibita a uso culturale. Vi è allestito infatti il Museo storico del Castello e della Città.
-
Museo storico del Castello e della Città
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Allestito nella Rocca, espone reperti archeologici (preistorici, etruschi, romani, longobardi, bizantini) e materiali medievali e rinascimentali (maioliche, armi, arredi e dipinti).
-
Dovadola
Dovadola (FC)
Da Duo Vadora, perché tra due guadi del fiume Montone. A m 140, ab. 1.569, al nucleo antico si aggiunse in età granducale, con l’ampliamento delle mura, l’ortogonale Borgo Fiorentino a ridosso del fiume. La via del Castello sale alla Rocca della casata dei Guidi (che l’apertura della statale ha separato dall’abitato), di cui sono discretamente conservate le cortine, con tratti bastionati, e il maschio quadrato. La struttura, di proprietà comunale, non è visitabile. La via Raineri Biscia, a destra, conduce invece alla piazza Battisti, ove di fronte al pluristemmato portico di Piazza è la porta turrita che segna l’inizio della via d’accesso al borgo medievale. Nella cinquecentesca parrocchiale di S. Andrea (in basso, al di là del Montone: da piazza Battisti, via Matteotti e piazza Marconi), che sta sul sito dell’abbazia di S. Andrea fondata nell’XI secolo dai Cluniacensi, ha interesse una Madonna delle Lacrime (3a campata sin.) di scuola faentina del Cinquecento.
-
Rocca San Casciano
Rocca San Casciano (FC)
A m 210, ab. 1.807, principale centro della media e alta valle, dominato sulla destra dai ruderi della Rocca medievale (bastionata e con mastio). Attorno alla bella piazza Garibaldi, a pianta triangolare, parzialmente porticata, prospetta, unitamente alla torre del Pretorio (statua settecentesca della Madonna), l’ex chiesa del Suffragio.
-
S. Maria delle Lacrime
Rocca San Casciano (FC)
Parrocchiale ricostruita nel 1766-84: al 2° altare destro, Madonna delle Lacrime, terracotta del ’500; al 2° sinistro, Crocifisso ligneo quattrocentesco.
-
Ex chiesa del Suffragio
Rocca San Casciano (FC)
Ex chiesa (secolo XVII-XVIII), oggi spazio espositivo, con una Deposizione di Giovanni Stradano e, provenienti dall’abbazia di S. Donnino in Soglio, un tondo (Madonna in adorazione del Bambino) di Andrea della Robbia e un bassorilievo protoromanico con santi gemini.
-
Abbazia di S. Donnino in Soglio
Rocca San Casciano (FC)
La chiesa di S. Donnino, già parte dell'abbazia di S. Donnino in Soglio, conserva resti dell’abside preromanica e romanica poligonale, con un affresco del XIV-XV secolo, nonché sculture e bassorilievi romanici sulla facciata; a fianco, il convento-fortezza con muro a scarpa.
-
Portico di Romagna
Portico e San Benedetto (FC)
A m 301, ha ottenuto il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Sede del Comune di Portico e San Benedetto, ab. 732, è un antico borgo che del tempo in cui fu preso da Firenze (1341) conserva quasi integralmente l’impianto e notevoli tratti delle cortine della rocca. Nel 1398 vi fu destinato, quale capitano della provincia fiorentina, il novelliere Franco Sacchetti. La parrocchiale di S. Maria in Girone custodisce tele del secolo XVIII; la chiesa della Compagnia, una pregevole Madonna attribuita a Lorenzo di Credi. Le storiche case Traversari, con finestre e portali a bugnato in pietra serena, e Portinari prospettano sulla piazza Ambrogio Traversari (sovrastata da una poderosa torre resto dell’antico castello) dedicata all’umanista qui nato nel 1386. Dalla piazza si può scendere a un bel ponte a schiena d’asino su unica arcata.
-
Bocconi
Portico e San Benedetto (FC)
A m 388, con una torre del secolo XIV; dal pittoresco ponte medievale della Brusìa, a tre arcate, un’antica mulattiera sale ai resti della rocca.
-
San Benedetto in Alpe
Portico e San Benedetto (FC)
A m 495, ebbe origine attorno al Mille dal monastero benedettino di cui, in località Poggio m 598, rimangono la cripta della chiesa dell’XI secolo (altare con le presunte spoglie dei martiri romani Primo e Feliciano) e i ruderi di un chiostro. È consigliata la passeggiata (meno di 2 ore) alla cascata dell’Acquacheta m 728, citata anche da Dante (Inferno XVI, 96-102).
-
Museo della Fauna del Crinale romagnolo
Premilcuore (FC)
Allestito all’interno del Centro visite del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, propone la ricostruzione di piccoli ecosistemi animali e vegetali in cui sono presenti, fra gli altri, il lupo, il daino, il cervo, varie specie di uccelli rapaci, ma anche insetti, anfibi e rettili.
-
S. Martino all’Oppio
Premilcuore (FC)
Al di là del Rabbi, a valle dell’abitato di Premilcuore, sorge tra i cipressi la pieve di S. Martino all’Oppio, ricostruita nel ’500 e poi (1706, 1933) ristrutturata. È a tre navate, con una notevole Madonna del Carmine di Jacopo Vignali.
-
Premilcuore
Premilcuore (FC)
A m 450, ab. 723. Tranquillo centro di soggiorno estivo, lo caratterizza un nucleo medievale murato e ben conservato nella topografia, con castello (privato) già dei Guidi. Il borgo ha meritato il marchio di qualità Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Sottopassate, scendendo al fiume, due porte delle fortificazioni, e lasciato a destra l’oratorio di S. Lorenzo (Madonna del Rosario, di scuola toscana del XVII secolo, si continua dopo il ponte in riva destra fino al Museo della fauna del crinale romagnolo. Al di là del Rabbi, a valle dell’abitato, sorge tra i cipressi la pieve di S. Martino all’Oppio.
-
Predappio Alta
Predappio (FC)
A m 237, forse fortificata nel 1288 da Giovanni d’Appia, e perciò detta Pietra d’Appia (ma c’è chi sostiene la derivazione da praedium Appii, cioè podere di Appio), conserva sulla destra della via principale il Castello ampliato nel 1471 da Pino Ordelaffi; sulla piazza allo sbocco della stessa via, il settecentesco santuario della Madonna, con un affresco del secolo XV.
-
S. Agostino in Rocca d’Èlmici
Predappio (FC)
Chiesetta romanica con abside semicircolare e interno decorato di affreschi del secolo XIV-XV, di scuola riminese; della medievale Rocca d’Èlmici, già dei Calboli, poi potenziata da Pino Ordelaffi nel 1471, restano sull’altura a sinistra i pochi ruderi coperti dal bosco.
-
Predappio
Predappio (FC)
L’abitato di Predappio, concentrato poco più a valle, ha impronta moderna, dovuta alla crescita programmata fra le due guerre del vecchio nucleo di Dovìa; documentali, nella piazza S. Antonio, la Parrocchiale del 1934, su disegno di Cesare Bazzani, e (circondato da giardino) il palazzo Varano, progettato da Florestano di Fausto nel 1926 e oggi sede municipale.
-
S. Cassiano
Predappio (FC)
Importante chiesa risultato di arditi interventi di rifacimento (1934), conserva all’esterno sull’abside mediana decorazioni scultoree pertinenti all’originaria costruzione romanica del secolo XI, mentre la facciata, tripartita, è coronata di archetti e ha un semplice portale sormontato da bifora; l’interno è a tre navate, con presbiterio sopraelevato sulla cripta e tre absidi semicircolari. Un atrio con colonne e capitelli d’imitazione bizantina fa da ingresso all’adiacente cimitero: vi fu sepolta nel 1957, dopo varie peripezie, la salma di Benito Mussolini che qui era nato nel 1883.