In collaborazione con 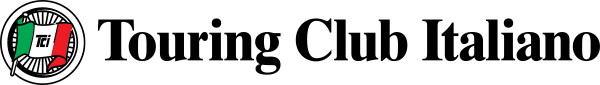
Il settore della pianura medio-bassa, del quale l’itinerario propone la visita, ha come poli estremi Brescello e Guastalla, oltre alla stessa Reggio.
Accompagnano il primo tratto le statali 63, del valico del Cerreto, e 358, di Castelnovo, che tagliano rispettivamente la fascia delle bonifiche benedettine medievali e un’area ancora oggi ben rappresentativa di una porzione della centuriazione romana.
Il tratto intermedio utilizza la 62, della Cisa, che costeggia un tratto del Po, toccando uno dei più interessanti sistemi insediativi di sponda della regione (Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara), con alcuni centri di notevole interesse urbanistico-monumentale e storico.
Il tratto conclusivo si snoda lungo una serie di strade provinciali, più adatte della parallela statale 63 a stabilire un contatto con il paesaggio rurale e con le modificazioni che l’opera dell’uomo ha prodotto in un ambiente un tempo in gran parte vallivo.
La bonifica di età moderna della zona data dal 1576, allorché Cornelio Bentivoglio incaricò l’Argenta di realizzare un articolato piano di sistemazione idraulica del feudo di Gualtieri. Il progetto previde, tra l’altro, la nuova inalveazione del basso Cròstolo e la realizzazione, tra Gualtieri e Santa Vittoria, sotto il medesimo torrente, di una «botte» lunga 77 m (botte Bentivoglio), tuttora efficiente.
Dopo la costituzione del Consorzio Bentivoglio (1878), precedente storico del successivo Consorzio della Bonifica Bentivoglio-Enza, furono realizzati gli impianti meccanici che consentirono il completo prosciugamento delle terre basse e l’irrigazione di quelle della media pianura: fra tutti, l’idrovora del Torrione a Gualtieri (1926) e la presa del Po a Boretto (1927). Dal 2009 l’ente è stato riassorbito nel Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Tra i progetti, la realizzazione di un lago serbatoio sull’Enza, presso Vetto.
-
Lunghezza69,8 km
-
Cadelbosco di Sopra
Cadelbosco di Sopra (RE)
Cadelbosco di Sopra (m 33, ab. 10.698) è l’antico Vico Zoario munito di castello fin dal 1032; nella settecentesca chiesa di S. Celestino, preziosi arredi (reliquiario del 1518, croce penitenziale in argento del XV secolo); nella piazza della Libertà, monumento alla Resistenza di Marino Mazzacurati (1965).
Fuori dal paese, presso l’argine del Cròstolo, una strada sterrata conduce alla corte del Traghettino, rilevante ancorché degradato esempio di corte fortificata medievale, già appartenente al monastero benedettino di S. Giovanni di Parma; in evidenza le costruzioni del torrione merlato e del grande edificio civile a loggiato.
-
Castelnovo di Sotto
Castelnovo di Sotto (RE)
Castelnovo di Sotto (m 27, ab. 8.406) è un antico feudo dei da Correggio, sotto i quali il nucleo storico raggiunse il massimo sviluppo urbanistico; passato agli Estensi, fu da questi venduto nel 1656 come feudo ai marchesi Gherardini di Verona.
La Rocca, originaria del IX secolo, trasformata sul finire del Settecento in residenza signorile, è oggi sede del municipio; di fronte, monumento ai Caduti della Resistenza di Marino Mazzacurati.
Altro edificio rilevante è la chiesa della Beata Vergine della Misericordia, utilizzata per mostre e cerimonie; contiene buone tele del Seicento padano, tra le quali la Natività della Vergine di Lionello Spada (1616) e la Crocifissione di Palma il Giovane (1614).
-
Museo Cervi
Gattatico (RE)
Istituito dal 1970 e riallestito nel 2002 nella casa rurale appartenuta dal 1934 alla famiglia di Alcide Cervi, il museo raccoglie la documentazione storica relativa alla vita della famiglia, al suo impegno nella lotta antifascista e nella Resistenza, in quanto era punto di riferimento e di concreto aiuto per antifascisti, renitenti alla leva e oppositori alla guerra.
Oltre a testimoniare gli eventi collegati alla fucilazione dei sette fratelli (28 dicembre 1943), è un interessante esempio di tipica casa contadina reggiana a corpo unico, divisa nei due settori produttivo e residenziale, corredata di tutti quegli strumenti e arredi che consentivano la vita dell’azienda familiare.
A fianco del museo è stato realizzato il Parco agroambientale dell’Istituto Alcide Cervi, che configura l’istituzione come un vero e proprio ecomuseo. Annesso alla casa Cervi, rappresenta un itinerario guidato nell’ambiente naturale e culturale della media pianura padana; infatti mantiene e ricrea, nell’ambito del territorio agricolo, spazi naturali promuovendo pratiche agronomiche che contribuiscono al mantenimento del paesaggio agrario storico come, ad esempio, la piantata reggiana.
Nel 2011 è stato inaugurato un nuovo filare di frutti antichi dell’Emilia-Romagna, che costituisce una sintesi della biodiversità rurale.
-
Poviglio
Poviglio (RE)
Poviglio (m 29, ab. 7.028), già sede di un castello con cinta bastionata, ora scomparso, a lungo conteso tra l’episcopato reggiano e quello parmense; fino al 1848 fece parte del ducato di Parma, per essere poi annesso ai domini estensi. Ospita il Museo della Terramare Santa Rosa.
-
Museo della Terramara S. Rosa
Poviglio (RE)
All'interno del Museo della Terramara S. Rosa sono esposti materiali provenienti da un grande villaggio terramaricolo (frequentato tra il XIV e il XII secolo a.C., dall’età del Bronzo medio a quella del Bronzo tardo) e da una piccola necropoli, scoperti in località Santa Rosa di Fòdico, a nord-est del capoluogo comunale; lo scavo intrapreso nel 1984 sembra aver rivelato la più grande terramara finora individuata (circa 6 ettari).
Nella stessa area della terramara Santa Rosa nel V secolo a.C. si formò un piccolo insediamento, e nel I a.C. si installò una villa romana.
-
Brescello
Brescello (RE)
Brescello (m 24, ab. 5.682) è un grosso borgo agricolo di antica formazione presso la confluenza del fiume Enza nel Po. Già insediamento celtico, divenne la romana Brixellum, colonizzata dai veterani di Augusto.
Ebbe rilevanza strategica nel 69 d.C., quando l’imperatore Ottone vi pose il suo quartier generale contro il rivale Vitellio e, udita la notizia della sconfitta delle sue truppe a Bedriacum (presso Calvatone, CR), vi si uccise.
Nonostante la buona posizione sul Po, alla fine del IV secolo è ricordata da S. Ambrogio tra le città dell’Emilia cadute in rovina; fu centro cardine della difesa bizantina contro i Longobardi, che lo distrussero alla fine del VI secolo.
Subì una terribile inondazione del Po nel 606 e rimase sepolto sotto metri di terriccio, ma rinacque nel X secolo con Adalberto Atto di Canossa, che vi costruì un castello e il monastero di S. Genesio. Conteso per secoli per motivi strategici, dal 1479 fu degli Estensi; nel 1553 Alfonso II lo fortificò con una cinta pentagonale, abbattuta nel 1704 dai Franco-Ispani.
Nel tessuto edilizio sopravvivono modeste tracce del composito nucleo antico. Il 3 settembre del 1951 il paese fu scelto per le riprese della saga di Giovanni Guareschi che raccontava le gesta di Don Camillo e Peppone, e quindi fu trasformato in un grande set cinematografico.
-
Museo Peppone e Don Camillo
Brescello (RE)
Il Museo Peppone e Don Camillo espone una ricca documentazione – con ricostruzione di ambienti, abiti di scena, fotografie della lavorazione – relativa alle fortunate cinque trasposizioni cinematografiche dei racconti di Giovanni Guareschi.
-
Museo Brescello e Guareschi, il Territorio e il Cinema
Brescello (RE)
Il nuovo spazio museale, inaugurato nel 2009, propone la ricostruzione di un set cinematografico originale dei film di Don Camillo e Peppone, raccontando il rapporto tra cinema e territorio.
Una sezione rievoca la grande alluvione del 1951, anche attraverso rievocazioni del mondo rurale e le imbarcazioni del Po.
-
Museo archeologico
Brescello (RE)
Nel centro culturale S. Benedetto, ex monastero omonimo che risale, nella parte più antica, al XV secolo, il Museo archeologico dedicato a Brixellum espone sculture e iscrizioni funerarie – tra le quali notevoli una statua di personaggio con lacerna (pesante mantello con cappuccio), forse un battelliere del Po, della metà del I secolo d.C., una probabilmente di commerciante del fiume e una di togato (fine del I secolo a.C.), due mosaici geometrici del I secolo d.C. e altro materiale dall’area urbana.
-
Chiesa di S. Maria Nascente
Brescello (RE)
Chiesa di Luigi Groppi (1830-37); nell’interno, a tre navate: Cristo portato al sepolcro, tavola di pittore emiliano del ’500, e Crocifisso in legno di Bruno Avesani; inoltre, diverse opere di Carlo Zatti.
-
Boretto
Boretto (RE)
A m 23, ab. 4.817, al riparo del possente argine del Po, Boretto è ricordato per la prima volta nell’835; nel 1939 in località Goleto fu rinvenuto il monumento funerario dei Concordii, ora nel giardino pubblico di Reggio.
-
S. Marco
Boretto (RE)
Parrocchiale (1871-83) sormontata da un’imponente cupola alta 46 m, ricostruita recentemente: l’originale, elevata nel 1883, era crollata nel 1988; nel braccio sinistro, grazioso dipinto di scuola veneta del secolo XVIII, raffigurante la Madonna col Bambino, S. Antonio da Padova e angeli di Giacomo Guerrini.
-
Museo del Po e della Navigazione interna - Po 432
Boretto (RE)
In alcuni edifici entro la golena del Po e presso lo scalo fluviale funziona Po 432 museo-cantiere, interamente dedicato al fiume e alla sua navigazione. La singolare denominazione deriva dal fatto di trovarsi a 432 km dalla sorgente sul Monviso.
È un museo di archeologia industriale che conserva oggetti, strumenti e macchinari utilizzati principalmente nella prima metà del secolo scorso dal Genio Civile per la manutenzione dei fondali e la regolamentazione della navigazione.
-
S. Andrea
Gualtieri (RE)
Chiesa del secolo XIII, a pianta centrale, ridotta nelle forme attuali all’inizio del XVIII secolo; nell’interno, opere del XVII e XVIII secolo.
-
Villa Guarienti
Gualtieri (RE)
Già castello dei vescovi di Parma e poi palazzo dei Malaspina, di impianto cinquecentesco con sovrapposizioni del secolo XVIII.
-
S. Maria della Neve
Gualtieri (RE)
La collegiata, organicamente inserita nel progetto di piazza Bentivoglio dell’Aleotti, fu rovinata dalle inondazioni del Po del 1765 e ricostruita da G.B. Fattori nel 1773-83; nell’interno, Crocifissione di Camillo Ricci; in una cappella a sinistra dell’altare maggiore, Annunziata e angeli di Carlo Bononi.
-
Museo documentario «Antonio Ligabue»
Gualtieri (RE)
Il Museo documentario «Antonio Ligabue» ha sede nella sala di Giove del palazzo Bentivoglio ed espone alcune opere del pittore naïf nativo di Gualtieri (1899-1965) e soprattutto documenti a lui riferiti, con annesso Centro studi.
-
Piazza Bentivoglio
Gualtieri (RE)
Passando sotto l’arco aperto nella torre dell’Orologio, si entra nell’armoniosa vasta piazza Bentivoglio, tenuta a giardino e porticata su tre lati; la scansione ancora rinascimentale dello spazio e il disegno omogeneo dei palazzi circostanti sono dovuti a G.B. Aleotti, detto l’Argenta (inizi del secolo XVII).
La collegiata di S. Maria della Neve, organicamente inserita nel progetto dell’Aleotti, fu rovinata dalle inondazioni del Po del 1765 e ricostruita da G.B. Fattori nel 1773-83. L’intero lato fronteggiante la torre è occupato dal massiccio palazzo Bentivoglio, iniziato alla fine del secolo XVI da Cornelio Bentivoglio su progetto dell’Aleotti.
-
Teatro Sociale Gualtieri
Gualtieri (RE)
Elegante teatro settecentesco, opera di G.B. Fattori (1775), all'interno di Palazzo Bentivoglio. Di recente recuperato dall’abbandono, ha adottato una singolare innovazione: la platea su cui si affacciano i palchetti, di solito territorio del pubblico, è diventata il palcoscenico per attori e musicisti. E nel luogo dove si trovava il vero palcoscenico ora prendono posto gli spettatori.
-
Donazione «Umberto Tirelli»
Gualtieri (RE)
Nella sala di Icaro del Palazzo Bentivoglio, esposizione permanente di 53 opere d’arte contemporanea, dove spiccano lavori di Balthus, Guttuso, De Chirico e Manzù.
-
Palazzo Bentivoglio
Gualtieri (RE)
Iniziato alla fine del secolo XVI da Cornelio Bentivoglio su progetto dell’Aleotti. Residenza signorile fino al 1634, fu parzialmente demolito nel 1750. Nell’interno sono notevoli il grandioso salone dei Giganti, con affreschi (episodi della Gerusalemme liberata) del XVII secolo, e l’Investitura di Cornelio Bentivoglio di Giovanni da San Giovanni; la sala di Enea con scene tratte dall’Eneide; le sale di Giove e di Icaro, entrambe con fregio di scuola carraccesca e soffitto a cassettoni dipinti (inizio secolo XVII); la cappella dei Bentivoglio, con affreschi (storie della Vergine) del primo Seicento nelle lunette e stucchi barocchi; l’elegante teatro settecentesco, opera di G.B. Fattori.
Il palazzo ospita, nella sala di Giove, il Museo documentario «Antonio Ligabue» e, nella sala di Icaro, la Donazione Tirelli, un’esposizione permanente di 53 opere d’arte contemporanea.
-
Gualtieri
Gualtieri (RE)
Gualtieri (m 22, ab. 6.286) è l’antico Castrum Walterii concesso nel XII secolo al vescovo di Parma, poi oggetto di contese tra Estensi e Correggeschi, fino a che venne aggregato al ducato estense (1479).
Nel 1567 Cornelio Bentivoglio, patrocinatore della grande opera di bonifica delle terre a S di Gualtieri, ottenne il feudo da Alfonso II d’Este, associando le imprese di redenzione agraria alla trasformazione del centro.
Estintasi nel 1634 la famiglia Bentivoglio, il feudo tornò agli Este. L’abitato, disposto parallelamente al Po da cui è separato dall’argine, fu spesso soggetto a catastrofiche inondazioni (l’ultima nel 1951), i cui diversi livelli sono registrati nelle colonne dei portici della piazza centrale.
-
Basilica della Pieve
Guastalla (RE)
Detta anche chiesa di S. Pietro, ricordata come oratorio nel donativo imperiale dell’864, ricostruita da Berengario I nel 915 circa e consacrata nel 997; in essa nel 1095 papa Urbano II adunò un sinodo e nel 1106 papa Pasquale II un concilio.
Venne quasi del tutto rifatta nel XIII secolo in forme lombarde, poi rimaneggiata nel 1605 e rimodellata nelle attuali forme romaniche nel 1926-31.
L’interno, a pianta basilicale a tre navate absidate, suddivise da pilastri, coperte da volte con affreschi decorativi primo-novecenteschi, conserva una vasca battesimale per immersione del IX-X secolo, e nella cappellina a sinistra del presbiterio una Madonna col Bambino in terracotta dipinta, attribuita a Guido Mazzoni; pochi i resti di affreschi del secolo XVI, opera probabilmente di pittori locali.
-
Torre del Pubblico
Guastalla (RE)
Torre del Pubblico o Campanone, eretta agli inizi del Settecento sul sito della rocca abbattuta alcuni anni prima.
-
Teatro Ruggeri
Guastalla (RE)
Teatro neoclassico teatro, globalmente restaurato nel 1814.
-
Piazza Garibaldi
Guastalla (RE)
Raccordo urbanistico tra la città quattrocentesca e quella medievale, ruotante attorno all’ottagonale oratorio della Madonna della Concezione (1579), e inquadrata dai due ‘traguardi a fondale’ della chiesa di S. Maria dei Servi sulla sinistra, e della chiesa delle Cappuccine (1673) sulla destra.
-
Chiesa di S. Maria Annunziata o dei Servi
Guastalla (RE)
Eretta su disegno di Francesco da Volterra (1598), rimaneggiata, con interno a croce latina: nel transetto sinistro, Deposizione e i sette santi fondatori dell’ordine dei Serviti, tela di Giuseppe Maria Crespi; nell’abside, Annunciazione di Pietro Rotari.
-
Biblioteca Maldotti
Guastalla (RE)
La Biblioteca Maldotti (nell’atrio, puteale del XVI secolo) conta circa 100 mila volumi, di cui alcuni molto rari, e manoscritti. Il lascito del fondatore l’abate Marcantonio Maldotti (1721-1801) consistente in circa 5000 volumi stampati principalmente nel XVI e nel XVIII secolo, si arricchì via via con le librerie degli ordini religiosi soppressi; tra i libri antichi figurano una ventina di incunaboli, alcuni decorati con splendide miniature, e circa 2000 cinquecentine.
-
Guastalla
Guastalla (RE)
Località agricola e commerciale, ricca di industrie metalmeccaniche, alimentari e del legno, Guastalla (m 25, ab. 14.782) è centro di aspetto urbano, cui la presenza per quasi due secoli della corte di un ramo dei Gonzaga ha conferito un ruolo di preminenza rispetto ai vicini borghi distribuiti lungo il Po, ruolo che certamente tuttora conserva.
Di probabile origine longobarda (come fa pensare il nome, derivato da Wartstall, da cui Guardistallum), fondata presso la confluenza del torrente Cròstolo nel Po, compare come corte regia nel IX secolo, assegnata dall’imperatrice Angilberga al monastero di S. Sisto in Piacenza.
Le controversie per il suo possesso durarono per tutto il X e l’XI secolo, fino all’affermazione dei Canossa. Non si esclude che il cosiddetto Castelvecchio, sito nella parte meridionale del centro storico, abbia costituito il primo insediamento stabile. Dopo la breve parentesi comunale e l’influenza del Comune di Reggio, Guastalla è conquistata nel 1307 da Giberto da Correggio che, spianato il Castelvecchio, lo sostituì con un compatto castello quadrilatero.
Passò successivamente ai Visconti e nel 1406 a Guido Torello. In quegli anni un più recente borgo, detto Castelnuovo, venne a saldarsi al nucleo antico. Acquistata nel 1532 da Ferrante Gonzaga, rimase fino al 1746 sotto il dominio di un ramo collaterale di quella famiglia.
Nel corso del Cinquecento e soprattutto con l’avvento di Cesare Gonzaga si procedette a una complessa ristrutturazione urbanistica, secondo il piano elaborato da Domenico Giunti, che comportò l’integrazione dei due organismi medievale e quattrocentesco, la definizione funzionale degli isolati e la costruzione di una cinta muraria pentagonale; la regolarità e cellularità dell’impianto del Giunti, caratterizzato da una struttura a maglie ortogonali imperniata sulla centrale strada Gonzaga, si manterrà per tutti i secoli successivi.
Nel 1626 Guastalla venne elevata al rango di ducato, assumendo una certa importanza come centro culturale e artistico. Una nuova riforma al sistema delle fortificazioni avrà luogo nel 1685 a opera dell’ingegnere francese Du Plessis, con la realizzazione di un circuito ettagonale stellare e il rinforzo di bastioni, muraglie e argini.
Con il trattato di Aquisgrana del 1748 la città è annessa al ducato di Parma, e, dopo la parentesi napoleonica, verrà confermata alla duchessa Maria Luigia, per passare poi, solo dal 1848 al 1859, al ducato di Modena. A partire dall’Ottocento il contorno esterno venne progressivamente intaccato e alterato con la demolizione delle porte, la rimozione di ogni avanzo delle fortificazioni e la realizzazione di parte della circonvallazione, che aprì la strada all’erosione urbana della fascia rurale.
Dopo l’ultimo trentennio di edificazioni discutibili e di sostituzioni incontrollate del tessuto antico, oggi l’amministrazione cerca di limitare i processi insediativi, avviando nel contempo progetti per il recupero e il riuso del centro storico.
-
Palazzo Ducale
Guastalla (RE)
Nonostante l’aspetto modesto dell’esterno e le trasformazioni subite nei secoli (oggi di proprietà privata e in parte restaurato), Palazzo Ducale conserva qualche lacerto della sua fastosa origine: sul fronte, stemmi delle famiglie Visconti, Torello e Gonzaga; all’interno, dopo un atrio, la galleria Mossina, ricca di statue, e un ampio scalone marmoreo; in alcuni ambienti, decorazioni a grottesche di Bernardino Campi (1586). Al primo piano (dove alcune sale sono adibite a mostre temporanee) è sistemata la Quadreria della Biblioteca Maldotti.
-
Cattedrale
Guastalla (RE)
Cattedrale di S. Pietro, di Francesco da Volterra, consacrata nel 1575 da Carlo Borromeo; la facciata, chiusa tra due campanili, venne rifatta nel XVIII secolo. Nel vasto interno, a una navata con cupola, gli arredi più interessanti, risalenti al XVII secolo, sono costituiti dagli stalli col trono vescovile e da un dipinto della Sacra famiglia di scuola lombarda; nel tesoro è un bel paliotto d’argento, pure seicentesco.
-
Piazza Mazzini
Guastalla (RE)
Luogo più rappresentativo della città, che i portici e l’acciottolato contraddistinguono come spazio tipicamente padano; in corrispondenza della tangenza con la strada Gonzaga si erge la statua di Ferrante I Gonzaga, opera di Leone Leoni (1564), rivolta verso il Palazzo ducale. Nel lato settentrionale della piazza prospetta la Cattedrale.
-
Quadreria della Biblioteca Maldotti
Guastalla (RE)
Al primo piano del Palazzo Ducale è sistemata la Quadreria della Biblioteca Maldotti, che consta di 50 opere frutto di collezionismo privato; di particolare pregio, Arria e Peto di Luca Ferrari, Lot e gli angeli di Marcantonio Franceschini, S. Caterina d’Alessandria di Giuseppe Bazzani, una Madonna col Bambino a fondo oro del XIV secolo, un acquerello di Francesco Hayez, un piccolo olio su cartone di Giuseppe de Nittis, alcune fra le tele più significative del guastallese Antonio Gualdi, un Ritratto di Mazzacurati.
-
Asilo d’infanzia Iride
Guastalla (RE)
Progetto di Mario Cucinella realizzato dopo il terremoto del 2012, che interpreta le esigenze della moderna pedagogia. È composto dalla moltiplicazione di 50 portali in legno lamellare intervallati da ampie vetrate. L’effetto dell’interno è simile a una grande pancia, che ricorda quella della balena di Pinocchio (il complesso è noto anche come La Balena).
-
Oratorio di S. Giorgio
Guastalla (RE)
Pregevole esempio di architettura romanica attribuibile al XII secolo (ma menzionato nel donativo di Ludovico II dell’864), più volte restaurato; all’esterno è notevole l’abside centrale; nell’interno, a tre navate absidate ripartite da basse colonne in cotto, sono stati ricollocati resti di affreschi.
-
Luzzara
Luzzara (RE)
Luzzara (m 22, ab. 8.577) è una località documentata dal VII secolo, quando sorgeva sopra un’isola del Po, ma frequentata anche in epoca romana (rinvenimenti in frazione Codisotto). Dal 1311 appartenne al ducato di Mantova, e dal 1630 a quello di Guastalla.
Tipico centro agricolo e industriale padano, dette i natali allo sceneggiatore Cesare Zavattini (1902-89) e ha la prerogativa di essere considerato la terra dei naïf italiani.
-
Chiesa di S. Giorgio
Luzzara (RE)
Parrocchiale del 1657, sorta su una precedente romanica (parte absidale esterna a fornici), a sua volta ricostruzione di una dell’VIII secolo (nel coro, Madonna col Bambino e i Ss. Giorgio e Girolamo di Bernardino Luini, 1521).
-
Palazzo della Macina
Luzzara (RE)
Cinquecentesco palazzo con facciata adorna di uno stemma gonzaghesco in terracotta invetriata e, nell’interno, capitelli marmorei cinquecenteschi.
-
Centro Culturale Zavattini
Luzzara (RE)
Un ex convento agostiniano è la sede del Museo nazionale delle Arti naïves, nato da un’idea di Cesare Zavattini; espone documentazione sulla vita e opere di autori naif italiani e stranieri.
-
Azienda agricola Riviera
Novellara (RE)
L'Azienda agricola Riviera ebbe origine in seguito alle bonificazioni intraprese dai Gonzaga tra il XV e il XVI secolo; i primi edifici della tenuta datano all’inizio del Seicento, la ristrutturazione dell’azienda e la costruzione degli ultimi fabbricati all’Ottocento, per opera della famiglia Spalletti.
Ai lati del lungo viale d’accesso si distribuisce un vero e proprio campionario di tipologie rurali; sul fondo, la corte padronale, un tempo cinta da parco, con il palazzo, l’oratorio e vasti fabbricati colonici.
-
Palazzo Greppi
Gualtieri (RE)
Realizzato con la probabile consultazione di Giuseppe Piermarini e, più certamente, di Andrea Tarabusi (1770-74); già centro di moderne sperimentazioni agrarie, è oggi di proprietà comunale e utilizzato come centro polifunzionale.
-
Seta
Cadelbosco di Sopra (RE)
A m 23, nucleo risalente alla colonizzazione medievale, con chiesa di S. Bernardino di origine quattrocentesca.
-
Argine
Cadelbosco di Sopra (RE)
A m 29, dove una villa al centro di un’importante corte rurale è nominata in un diploma di Ottone I del 963, e la chiesa dei Ss. Giustina e Cipriano – rifacimento del 1681 di Pietro Ferretti – conserva frammenti di un affresco quattrocentesco.
-
Torre di Sesso
Reggio nell'Emilia (RE)
La slanciata torre (1740) precede l'abitato insieme alla parrocchiale dedicata a S. Maria Assunta; entrambe furono iniziate da G.M. Ferraroni e compiute da Andrea Tarabusi, completandosi con un arco d'ingresso che, in un assetto viabilistico diverso, ne sottolineava scenograficamente la prospettiva.
-
Stazione AV Mediopadana
Reggio nell'Emilia (RE)
Avveniristico progetto di Santiago Calatrava (2013), realizzato sulla linea ferroviaria Milano-Bologna, a compimento della riorganizzazione dell’area settentrionale della città.
Consiste nella ritmica successione di 25 portali in acciaio, sfalsati tra loro, che si traduce in una successione di candide onde in movimento. La realizzazione era stata preceduta nel 2007 dal vicino sistema dei tre ponti a vela uno dei quali scavalca l’autostrada A1, altro complesso visionario in acciaio dipinto di bianco, con spalle di appoggio in cemento armato, campate che superano i 200 metri e un’altezza di 70.