In collaborazione con 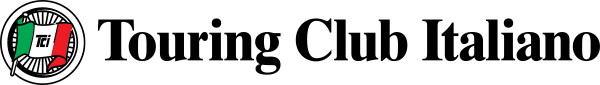
Fin dal XV secolo il vago paesaggio e la vicinanza alla città richiamarono la residenza in villa della corte estense e delle facoltose famiglie reggiane, che privilegiarono la fascia al di qua della prima linea difensiva di età medievale, da Casalgrande alle Quattro Castella.
«Le più belle colline d’Italia», come le definirono il Baedeker e Luigi Vittorio Bertarelli, furono cantate da Ludovico Ariosto, che nelle Satire ricorda la sua villeggiatura sulle pendici di Montegaio.
L’itinerario (a sviluppo circolare) segue dapprima la direttrice della valle della Secchia, fino al nucleo storico di Scandiano, volge quindi a ponente fin quasi a San Polo per la strada pedemontana – che vi si è delineata sicuramente in età protostorica – e rientra lungo il solco del torrente Enza, attraverso Montecchio.
L’interesse è principalmente paesistico, ma alcuni nuclei storici fra cui Scandiano arricchiscono la visita di attrattive monumentali.
-
Lunghezza64,8 km
-
Reggio nell´Emilia
Reggio nell'Emilia (RE)
Collocata in corrispondenza dello sbocco della piccola valle del torrente Cròstolo, tra i due più importanti bacini della Secchia e dell’Enza, Reggio nell’Emilia (m 58, ab. 169.803) è compresa in quella serie di città mediopadane, da Rimini a Piacenza, disposte ai margini della linea pedecollinare che fa da tramite – oltre che da straordinaria quinta scenografica – tra il paesaggio appenninico e l’antistante pianura distesa verso il Po.
La sua struttura urbana insiste sull’asse della Via Emilia, principale direttrice storica dell’organizzazione territoriale della regione, potenziata in epoca moderna dal fascio infrastrutturale costituito dalla ferrovia e dall’autostrada del Sole.
A Reggio si collega altresì un articolato sistema viario radiocentrico, testimonianza del ruolo storico di accentramento polifunzionale della città sul contado, oggi integrato nel più complesso sistema metropolitano regionale.
-
Arceto
Scandiano (RE)
A m 72, località citata nell’anno 833, conserva nel nucleo appena al di là della strada per Scandiano la chiesa di S. Maria Assunta, dall’elegante portico settecentesco a tre luci, e l’imponente Castello, trasformato nel Settecento in dimora signorile.
-
Scandiano
Scandiano (RE)
Scandiano (m 95, ab. 25.765) è un grosso centro agricolo, commerciale e industriale, disteso ai piedi di colli che producono rinomati vini bianchi.
La pittoresca rocca e il borgo adiacente ne fanno anche un luogo d’interesse monumentale. Il più precoce segno di presenza umana nel territorio è riferito a un abitato neolitico presso la frazione Chiozza, il cui scavo (1968) ha fra l’altro restituito una statuetta femminile, detta «Venere di Chiozza», esposta nei Musei Civici di Reggio.
L’insediamento attuale ha origine da un castello fondato nel 1262 da Gilberto Fogliani, intorno al quale si stabilirono diverse famiglie provenienti dal diroccato Castellazzo di Pratissolo e fuorusciti guelfi sconfitti a Montaperti (1260) da Farinata degli Uberti.
Occupato nel 1409 da Nicolò III d’Este, fu quindi (1423) dato in feudo – con Arceto, Gesso e Torricella di Ventoso – a Feltrino Boiardo, del quale fu nipote e successore il poeta Matteo Maria Boiardo, autore dell’Orlando innamorato.
In questo periodo furono realizzati complessi lavori di ripristino delle fortificazioni e una nuova cinta muraria. Estintasi con Ippolito la famiglia Boiardo (1560), il feudo, che dal 1443 aveva il titolo di contea, passò come marchesato a Ottavio Thiene e nel 1634 a Enrico Bentivoglio, ritornando in seguito alla Camera ducale e a un ramo degli Este.
-
Convento dei Padri Cappuccini
Scandiano (RE)
Nella moderna periferia nord-orientale, il maestoso complesso seicentesco del convento dei Cappuccini, fondato su di un terreno leggermente rilevato donato dal marchese Thiene.
Nella chiesa, con facciata del 1902, alla parete destra si conserva un grande dipinto di Stefano da Carpi, raffigurante l'Esaltazione dei Santi francescani; all’altare maggiore, un tabernacolo ligneo di fra’ Fedele da Scandiano.
-
Piazza Lazzaro Spallanzani
Scandiano (RE)
Piazza porticata dedicata, con la statua al centro (opera di Guglielmo Fornaciari, 1888), all’illustre naturalista scandianese (1729-99).
-
Chiesa di S. Giuseppe
Scandiano (RE)
Chiesa con settecentesca facciata, contenente nella cappella a sinistra alcuni lavori d’intaglio di qualche interesse: un venerato Crocifisso, un tabernacolo di scuola dei Ceccati e una cantoria barocca.
-
Parrocchia di S. Maria
Scandiano (RE)
Parrocchiale con campanile quattrocentesco a bifore e, nell’interno, in cui sono sepolti alcuni membri della famiglia Boiardo, un dipinto con S. Caterina d’Alessandria di Bartolomeo Passarotti e un gruppo ligneo policromo della Madonna del Rosario (secolo XVI); in un andito presso la porticina del lato destro, cenotafio di Lazzaro Spallanzani.
-
Rocca dei Boiardo
Scandiano (RE)
La rocca fu eretta nel 1262, e rimaneggiata dai Boiardo e dai Thiene, che la riadattarono a residenza signorile su progetto di G. B. Aleotti detto l’Argenta. L’ingresso è caratterizzato da un’elegante torre massiccia, con merlatura ghibellina, un tempo munita di ponte levatoio.
All’interno, Giulio Boiardo fece dipingere verso il 1540 da Niccolò dell’Abate scene ispirate all’Eneide e altri affreschi, tolti nel 1772 e trasportati a Modena dove in gran parte si trovano nella Galleria Estense; vi permangono, invece, stucchi tardo-seicenteschi di Antonio Traeri e affreschi del primo Settecento che decorano alcune sale dell’appartamento Estense: sala dei Gigli con vedute di Scandiano; sala del Camino in stile rococò; sala del Drappo così detta dal drappo che avvolge la volta; sala dell’Alcova con scene di battaglia; sala delle Aquile, ricavata nella torre, con busti di personaggi della dinastia d’Este.
La Rocca, di proprietà demaniale, è data in concessione d’uso al Comune, che la utilizza per esposizioni temporanee. Alla destra della rocca, in fondo alla via Magati si innalza la torre dell’Orologio, eretta nel XVI secolo dove già esisteva una porta del primitivo circuito del castello.
Sottopassata la torre e percorsa la via Garibaldi, si raggiunge il maestoso fronte meridionale della rocca, di impronta tipicamente baroccheggiante, connesso a un torrione merlato; l’insieme, di notevole eleganza compositiva, è la parte meglio conservata dell’intero complesso.
-
Casa natale di Lazzaro Spallanzani
Scandiano (RE)
Nel centro storico, nei pressi della Rocca, una raffinata palazzina settecentesca è la casa natale di Lazzaro Spallanzani.
-
Casalgrande
Casalgrande (RE)
A Casalgrande Alto (m 162) ciò che rimane del castello è una corte rurale quattrocentesca organizzata intorno alla residenza fortificata e munita di due torri quadrate.
Originario del XII secolo, passò ai Fogliani che lo tennero fino al 1409, e nel 1557 fu in gran parte distrutto dagli Spagnoli di Ottavio Farnese. Oltre alle parti già descritte, ne resta il torrione d’ingresso, con resti di merlature e portale provvisto di fenditure per il ponte levatoio.
-
Dinazzano
Casalgrande (RE)
In posizione elevata sopra l’abitato di Dinazzano (m 172), si può osservare la bella villa Carandini, neoclassica.
Sul colle più alto (m 257) è visibile quanto resta del Castello di Dinazzano, poco più che un semplice torrione isolato e ruderi del perimetro murario, databile tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV; ebbe importanza a partire dal XII secolo, sotto il Comune di Reggio, come punto di controllo del canale di Secchia che convogliava le acque del fiume in città.
-
Montericco
Albinea (RE)
A m 226, con il santuario della Beata Vergine Immacolata di Lourdes, realizzato nel 1896 su disegno di Carlo Barbieri, e, inglobato in edifici del 1927, il trecentesco Castello; all’interno (privato), sono interessanti la sala d’ingresso e il salone centrale con camino quattrocentesco.
-
Albinea
Albinea (RE)
Albinea (m 166, ab. 8.773) è un moderno abitato dominato, dall’alto di un colle, dalla seicentesca villa Tarabini-Viganò. Più avanti, in incantevole posizione elevata appare la settecentesca chiesa della Natività di Maria di Albinea. Al culmine del poggio, il castello di Albinea con il suo parco, di proprietà privata.
-
Chiesa della Natività di Maria
Albinea (RE)
Settecentesca chiesa in incantevole posizione elevata, ricordata come pievana nel 980; all’interno, una copia del 1638 della cosiddetta Madonna di Albinea di Correggio (l’originale è disperso), e un dittico a tempera della fine del secolo XV, raffigurante la Madonna col Bambino e S. Lucia.
-
Castello
Albinea (RE)
Castello con il suo parco, di proprietà privata, appartenuto dal 1070 al vescovo di Reggio, passò ai Fogliani che ne ristrutturarono l’impianto difensivo, e dal XV secolo ai Manfredi che ne conservarono il possesso fino al secolo XVIII; nel Cinquecento fu rinforzato da una struttura a baluardi e nell’Ottocento venne ricostruita la torre d’ingresso con il ponte levatoio.
-
Villa ducale di Rivalta
Reggio nell'Emilia (RE)
Un imponente disorganico insieme di fabbricati è quanto resta della Villa ducale o Estense, detta «il Palazzone di Rivalta». Costruita per il principe ereditario Francesco d’Este a partire dal 1723, probabilmente da Giovan Maria Ferraroni, e ripresa dal 1730 sotto la direzione di Francesco e G.B. Bolognini con la collaborazione di Lodovico, era un tempo una splendida ‘delizia’ ispirata alla reggia di Versailles.
In gran parte demolita nel 1807, ne restano intatte solo l’ala meridionale, la chiesetta, oggi adibita a uso agricolo, la corte rurale e la cinta muraria bastionata.
-
Quattro Castella
Quattro Castella (RE)
Quattro Castella (m 161, ab. 13.159) ha nome da quattro rocche sorte tra il 985 e il 1054 su altrettanti caratteristici rilievi boscosi ugualmente alti e vicini (da levante, i monti Vetro, Bianello, Lucio e Zane), che formavano un naturale avamposto a protezione del castello di Canossa.
Ad eccezione di Bianello, delle altre tre rocche rimangono pochi ruderi. Dalla piazza del Municipio si risale la via Roma (sulla destra, il cinquecentesco palazzo S. Anna, già residenza dei duchi di Modena), raggiungendo al culmine la Parrocchiale, di origine romanica. Di qui un lungo viale alberato sale al castello di Bianello.
-
Castello di Bianello
Quattro Castella (RE)
Una delle proprietà allodiali di Matilde di Canossa che vi soggiornò più volte, e ai cui discendenti rimase fino al 1742; venne riformato tra il Seicento e il Settecento e adattato a residenza signorile, pur mantenendo aspetto severo e compatto, impostato su una struttura poligonale chiusa e bastionata, con mastio del secolo XIII.
-
Montecchio Emilia
Montecchio Emilia (RE)
Montecchio Emilia (m 99, ab. 10.452) è il principale centro commerciale della bassa val d’Enza, con vari stabilimenti industriali. Ubicata lungo la direttrice che da Brixellum, sul Po, risaliva la valle dell’Enza, è località nominata per la prima volta nel 781.
Montecchio fece parte dei dominî della contessa Matilde, e in seguito dei Vicedomini che lo tennero con alterne vicende fino al XIV secolo. Nel 1396 i Visconti lo diedero in feudo ad Alberico da Barbiano e più tardi Nicolò III d’Este lo concesse ancora in feudo a Muzio Attendolo Sforza. Nel secolo XV venne intrapresa un’imponente opera di ricostruzione degli apprestamenti difensivi con la ideazione di un nuovo impianto urbano.
Dal 1533 diventò feudo privilegiato per i cadetti di casa d’Este ed elevato a marchesato. Il nucleo antico a pianta regolare conserva ancora tracce delle cortine murarie quattrocentesche e dei bastioni.
-
Rocca
Montecchio Emilia (RE)
Unica ancora leggibile delle opere fortificate di Montecchio, si fa risalire a Matilde di Canossa, ma nell’assetto odierno risale al XIII secolo; delle due torri, merlate alla ghibellina e munite di caditoie, la più alta, il mastio, reca un orologio più tardo; a sinistra, due epigrafi dedicatorie romane del I secolo d. Cristo.
-
Museo del Parmigiano Reggiano-Civiltà contadina e artigiana della Val d'Enza
Montecchio Emilia (RE)
Allestito in una tipica casa contadina del Settecento, il museo raccoglie attrezzature da lavoro e testimonianze della vita rurale, con particolare attenzione alla produzione del Parmigiano-Reggiano.
Nei pressi è possibile visitare due caselli storici per la lavorazione del formaggio, uno al fuoco vivo di legna e l’altro a vapore; completano la rassegna la scuola dell’intaglio del legno e la collezione di mezzi di trasporto intagliati.
-
Cavriago
Cavriago (RE)
Cavriago (m 78, ab. 9.806) è un grosso centro agricolo-commerciale, notevolmente accresciutosi sulla spinta di un forte sviluppo industriale. Appartenne alla Chiesa di Reggio e fu in seguito conteso tra Parmensi e Reggiani, rappresentando fino al secolo XIX il confine tra le due diocesi.
Ebbe un castello, distrutto dai Reggiani nel 1486, sulla cui area rimane la chiesa di S. Terenziano, di origine romanica (pochi resti nel sotterraneo), rifatta da Francesco Pacchioni nel secolo XVI.