In collaborazione con 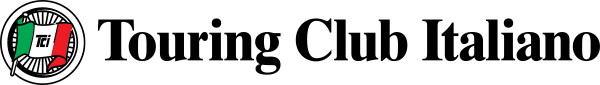
L'ambiente e la storia
Il territorio imolese, tra il torrente Sìllaro e il fiume Santerno, può considerarsi l’estremo lembo occidentale della regione romagnola.
Terra di confine, quindi, che ha conosciuto numerosi rimaneggiamenti amministrativi. Fino al 1859 Imola (con i mandamenti di Castel Bolognese e Càsola Valsenio) fu della legazione di Romagna.
Dopo l’Unità, l’istituzione delle province di Bologna e Ravenna portò vari cambiamenti nelle pertinenze amministrative: il vasto Comune di Imola passò nel 1863 in provincia di Bologna, e, più avanti, nel 1884 furono trasferiti a essa anche i territori di Castel del Rio, Fontanélice e Tossignano, di modo che il confine tra le province di Bologna e Ravenna si attestò sul crinale tra Santerno e Senio.
Una pianura a debolissima inclinazione è saldata alle prime ondulazioni appenniniche dalle piatte conoidi fluviali del Santerno e del Sìllaro, che la raccordano alle piane di fondovalle fin entro la bassa collina.
È una pianura che nell’assetto della viabilità locale e regionale e in quello idrografico conserva tutt’oggi una forte impronta della colonizzazione romana. Allo schema geometrico della centuriazione si adeguano i limiti di proprietà, a volte quelli dei Comuni, e in ogni caso quasi ovunque i contorni delle parcelle colturali: un paesaggio agrario da cui si ricavano sensazioni di ordine.
Sulle prime groppe collinari, fino alla strettoia di Borgo Tossignano, affiorano in prevalenza formazioni di sabbie e argille, modellate da una fitta rete di rii e torrentelli in forme arrotondate, spesso delimitate da ripide e brulle pendici, nelle quali un’intensa erosione ha inciso profondi solchi separati da creste: è il tipico paesaggio a calanchi diffuso in tutta la fascia collinare bolognese e romagnola.
In corrispondenza della strettoia di Borgo Tossignano si erge la Vena del Gesso, singolare cresta selenitica lunga c. 20 km e alta fino a 400-500 m, estesa a oriente fino a Brisighella nella valle del Lamone: è il più bel corpo gessoso della penisola italiana, che offre suggestivi scorci morfologici e riveste notevole interesse scientifico, anche per la presenza di associazioni vegetali, con specie arcaiche e a volte rare.
Sono peculiarità che creano i presupposti per l’istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. A monte delle bancate gessose affiora nella valle del Santerno la formazione marnoso arenacea, che si attraversa in tutte le valli romagnole; la ripetitiva alternanza in migliaia di strati sovrapposti di due tipi litologici, le marne e le arenarie, profonda fino a 1000 m, è spesso messa a nudo dall’erosione fluviale in prossimità del fondovalle. Le linee morfologiche del paesaggio assumono qui caratteri più propriamente montani.
Lungo lo spartiacque tra Santerno e Sìllaro, verso il Bolognese, è molto suggestivo il contatto tra il paesaggio spigoloso, con pendii ripidi e reticolo idrografico profondo, della fascia marnoso-arenacea e quello di aspetto più collinare, dai pendii ampi e franosi delle argille scagliose’, una formazione geologica eterogenea e caotica, che in una massa prevalentemente argillosa ingloba frammenti piccoli e grandi di rocce della più varia composizione: calcari, arenarie, soprattutto serpentini.
Si tratta di terreni con notevole predisposizione al dissesto; assente la vegetazione arborea; dalle tortuose e instabili strade si aprono rudi scenari su versanti segnati da lunghe colate di fango nelle quali biancheggiano i frammenti degli ‘esotici’.